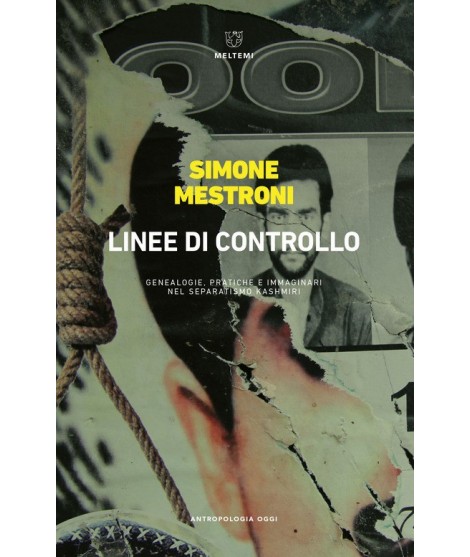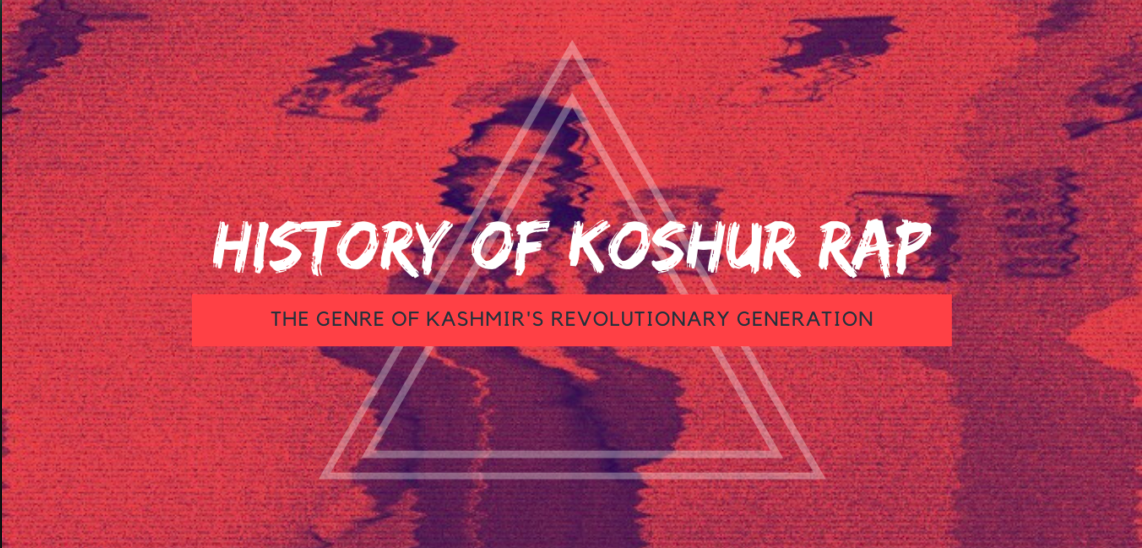di Simone Mestroni e Maria Tavernini
Tra i vari tormentati conflitti di lunga durata che costellano il mondo contemporaneo, la vicenda del Kashmir non è probabilmente tra le più raccontate dai media internazionali e, ancor meno quindi, da quelli italiani.
Eppure questo territorio incarna singolarmente una disputa che coinvolge tre potenze nucleari -India, Pakistan e Cina- le quali reclamano vicendevolmente aree situate al di là di confini non chiaramente delineati e riconosciuti, segnalati sostanzialmente solo dalla presenza di eserciti tra loro ostili, che, come di recente avvenuto in Ladakh, sulla cosiddetta Line of Actual Control (LAC, la frontiera indo-cinese), si riflette in saltuari scontri di bassa intensità.
La situazione è ancora più complessa sulla Linea di Controllo (LoC), il confine non riconosciuto che divide il Kashmir pakistano (denominato da Islamabad “Azad Kashmir” Kashmir libero) da quello Indiano (J&K), sul quale gli scambi di colpi artiglieria sono un fatto ordinario da più di 70 anni.
L’annessione del Kashmir in realtà è il pomo della discordia tra le due nazioni fin dalla loro nascita, nel 1947, a seguito della quale è immediatamente esploso il primo conflitto indopakistano, seguito dal secondo nel 1965, e alla guerra di Kargil nel 1999.
A questo livello formale di conflitto permanente, a partire dalla fine degli anni ’80, si è aggiunta la pratica di infiltrazione nella parte indiana di gruppi armati di matrice islamista addestrati in Pakistan, e soprattutto la cosiddetta “militancy”, un fenomeno per cui, negli anni ’90, migliaia di ragazzi kashmiri hanno imbracciato le armi per combattere per l’indipendenza (Azadi) o per l’annessione al Pakistan a seconda del gruppo di guerriglia a cui appartenevano.
Le cifre riguardanti le vittime di quest’ultima fase del conflitto sono stimate tra 40mila e oltre 100mila, e a queste si aggiungono diffuse violazioni dei diritti umani, stupri, torture e una capillare militarizzazione del territorio da parte dell’esercito indiano.
La stessa India, nell’immaginario e nella percezione di chi è nato e cresciuto negli ultimi decenni, ha assunto ormai i tratti di un’occupazione straniera, che implementa la sua sovranità attraverso la violenza delle forze armate, di fatto legittimata da leggi draconiane come l’Armed Forces Special Power Act e il Public Safety Act.
La questione etnico-religiosa si è inoltre impressa chiaramente come matrice identitaria del conflitto: i due discorsi nazionali che si contendono il Kashmir e la sua popolazione (in gran parte di fede islamica), richiamano infatti la polarizzazione tra induismo e islam: una frattura cristallizzatasi a livello politico grazie al “divide and rule” implementato nell’epoca coloniale britannica fino a metà del secolo scorso.
Il Kashmir, in questo contesto simbolico, incarna territorialmente la questione irrisolta della spartizione del subcontinente, sancita dalla controversa “teoria delle due nazioni”, per la quale le comunità nazionali di India e Pakistan si definivano, per approssimazione maggioritaria, sul piano confessionale.
In questa morsa politica, militare e identitaria, l’ideale “dell’azadi”, (libertà in lingua urdu), coniato agli albori della lotta separatista e rivelatosi istantaneamente un cavallo di troia per le inferenze pro-pakistane nel discorso indipendentista, si è comunque radicato nella sfera emotiva, nella struttura profonda del sé della popolazione: un contaminazione sospinta da un lato appunto dalla preesistente affiliazione all’Islam, dall’altro, non meno importante, dall’approccio repressivo e violento di Delhi nella gestione del dissenso.
Oramai, dopo 30 anni di occupazione, di mesi coprifuoco, di manifestazioni, scontri e martiri, nel sentire comune della vallata, musulmano e induista sono diventati sinonimi di vittima e carnefice, ed è nell’evidenza di questa associazione che le dinamiche antropologiche del conflitto, quindi in primo luogo la volontà di rivalsa, trovano modo di perpetuarsi nella loro sisifea ciclicità.
1846 Con il trattato di Amritsar, controfirmato dalla Compagnia delle Indie orientali, viene costituito il principato del Jammu&Kashmir. I territori di Jammu, la valle del Kashmir, il Ladakh e il Gilgit vengono sottoposti al dominio della dinastia induista dei Dogra.
1931 Prima insurrezione organizzata delle masse musulmane kashmiri contro il dominio Dogra. Sheikh Abdullah, appoggiato dal Mirwaiz Yousuf Shah, emerge come leader nella mobilitazione.
1938 Sheikh Abdullah cambia il nome della Muslim Conference in National Conference, avvicinandosi a una politica di stampo secolare influenzata dal legame con il futuro presidente dell’India Nerhu.
1940 Con la risoluzione di Lahore Jinnah delinea l’idea di Pakistan, futura patria per i musulmani del subcontinente.
1946 Sheikh Abdullah lancia la campagna “Quit Kashmir” contro il Marajà Hari Singh.
1947 Il 14 e il 15 agosto viene dichiarata l’indipendenza di Pakistan e India. Durante le migrazioni di massa da una parte all’altra del confine esplode la violenza interconfessionale. Il Marajà del Jammu&Kashmir, Hari Singh, rimanda la decisione inerente l’annessione, fino ad ottobre, quando le milizie irregolari supportate dal Pakistan invadono il principato dal lato occidentale, dando inizio alla prima guerra indo-pakistana. Il 26 ottobre il Maraja firma per l’annessione all’India e il giorno successivo le truppe di Delhi vengono aviotrasportate a Srinagar.
1948 Il presidente dell’India Nerhu riporta la questione del Kashmir all’ONU.
1949 Viene definita la Cease Fire Line, futura Line of Control. L’ONU emana una dichiarazione secondo cui la questione dell’annessione dovrà essere decisa attraverso un referendum. In ottobre l’autonomia del Jammu&Kashmir, la porzione indiana dell’ex principato, viene riconosciuta attraverso l’articolo 370 della costituzione. L’inferenza di Delhi nella vita politica dello stato è formalmente limitata alla difesa, agli affari esteri e alla comunicazione.
1951La National Conference di Sheikh Abdullah vince le prime elezioni statali.
1953 Sheikh Abdullah rimette al centro del dibattito politico il discorso dell’autodeterminazione e viene arrestato dalle autorità indiane con l’accusa di cospirazione antinazionale.
1965 Secondo conflitto indo-pakistano. Alcune migliaia di militari pakistani si infiltrano nella vallata portando a un conflitto di ampia scala. Il supporto nella vallata è però relativamente scarso e l’operazione fallisce.
1966 Da una fronda del Plebiscite Front, Maqbol Bath fonda il National Liberation Front, futuro JKLF.
1971 Il terzo conflitto indo-pakistano si conclude con la disfatta del Pakistan. Il Pakistan Orientale diventa l’odierno Bangladesh.
1975 L’accordo tra Indira Ghandi e Sheikh Abdullah sancisce un’ulteriore erosione dell’autonomia dello stato del J&K.
1984 Maqbol Bath viene giustiziato a Delhi.
1987 Le elezioni statali vengono palesemente segnate dai brogli. Masse di giovani vengono reclutati nel JKLF e attraversano la LoC per essere addestrati in Pakistan.
1988 Inizia l’insurrezione di massa in Kashmir: manifestazioni, scioperi e coprifuoco sono all’ordine del giorno.
1989 Nasce Hizbul Mujahideen (HM), il principale gruppo armato di chiara ispirazione propakistana.
1990 Jagmohan diviene governatore del J&K e impone l’AFSPA (Army Forces Special Act). Con la strage di Gaw Kadal, in cui vengono uccisi circa 100 manifestanti, inizia il periodo più violento della storia recente della vallata. Nello stesso anno i Pandit kashmiri emigrano in massa verso Jammu e altre zone dell’India.
1993 Il Mirwaiz, capo religioso sunnita della vallata fonda la Hurryat Conference, un conglomerato di organizzazioni di matrice islamica orientato a rappresentare le istanze separatiste a livello internazionale.
1994 Il JKLF di Yasin Malik abbandona ufficialmente alla lotta armata.
1999 Con la guerra di Kargil si sfiora un nuovo confltto di ampia scala tra India e Pakistan, entrambe due potenze nucleari.
2006 Il presidente pakistano Musharaf propone la sua “formula a quattro punti” per la risoluzione della questione kashmiri.
2008 Crisi politica legata al pellegrinaggio di Amarnath. Una nuova mobilitazione di massa coinvolge le generazioni cresciute negli anni della guerriglia. L’intera estate sarà segnata da scontri, con centinaia di feriti e decine di vittime.
2010 Dopo la morte di Tufail Matoo, ucciso dai militari a giugno, esplode una nuova protesta di massa che durerà circa cinque mesi.
2016 A luglio Burhan Wani, giovane e carismatico leader di Hizbul Mujahideen, viene ucciso dall’esercito indiano. Le proteste e gli scontri si protrarranno fino all’inizio del 2017, con migliaia di civili feriti.
2019 Il 5 agosto, con una mossa inattesa del governo guidato dal nazionalista indù Narendra Modi, il territorio del Jammu&Kashmir viene smembrato in due parti, entrambe formalmente incluse nell’Unione Indiana.
La storia contemporanea del Kashmir è contrassegnata, nell’immaginario degli abitanti della vallata, da una susseguirsi di congiure portate a termine dalle autorità politiche di volta in volta al potere, ai danni di una mai consultata volontà popolare.
La stessa nascita del principato, nel 1846, è sancita da una scandalosa vendita del territorio in questione, da parte degli inglesi, ad una dinastia induista di Jammu, in cambio della non inferenza nel processo di colonizzazione.
Qui si è definito geograficamente l’oggetto della disputa che si protrarrà, in diverse vesti, fino ai nostri giorni; ma soprattutto si è sancito il dominio di una minoranza induista su un’area a maggioranza musulmana, questione che si innesterà sia nelle politiche comunaliste britanniche, sia nelle fasi successive.
E’ però a partire dal 1947, quindi dalla Spartizione degli ex domini coloniali inglesi e la nascita di India e Pakistan, che la storia dei complotti e dei tradimenti si infittisce.
Nel momento in cui i sovrani degli ex principati si trovano a dover scegliere l’annessione a l’uno o l’altro stato nazionale in base all’appartenenza confessionale, il J&K, contiguo al futuro confine, ha la peculiarità di avere una maggioranza musulmana governata da un marajà induista.
Questi, in seguito ad un’invasione di truppe irregolari supportate da parte pakistana, firmerà per l’accesso all’India.
Temporanea o meno, questa scelta, dalla quale scaturirà istantaneamente il primo conflitto tra le due neonate nazioni, verrà vincolata da una risoluzione ONU secondo la quale la popolazione dell’ex principato avrebbe dovuto prima o poi decidere, attraverso un referendum la sorte del territorio.
Una risoluzione controfirmata dallo stesso presidente Nerhu, che però non è mai stata onorata, e che come in altri contesti d’intervento dell’agenzia, ha sostanzialmente fatto in modo che il conflitto fosse formalmente congelato.
Un altro tradimento, insomma. Ma forse ancora più lampante, nella memoria storica, rimane l’arresto del primo ministro e principale alleato di Delhi nella vallata, Sheikh Abdullah, nel 1953, alla quale seguirà una prima erosione dell’autonomia costituzionale dello stato: fino ad allora l’inferenza di Delhi aveva formalmente riguardato solo i settori delle telecomunicazioni, le relazioni internazionali, la difesa e la moneta in uso.
Lo stesso Abdullah, una volta ammorbidito dal carcere, verrà poi reintegrato nella politica locale: il suo accordo con Indira Ghandi (1975) segnerà un’ulteriore integrazione rispetto all’amministrazione indiana, e a tutti gli effetti un catalizzatore del malcontento delle masse musulmane che vedevano la loro leadership formale sempre più lontana dal rappresentare le istanze referendarie e separatiste. Non a caso è in questi anni che il Jammu&Kashmir Liberation Front e Jamaat-e-Islami, con le loro diverse modulazioni dell’ideale indipendentista (rispettivamente democratico-secolare, e islamista) si radicano nella società della vallata.
La svolta da cui è poi scaturita l’insurrezione di massa, in questo susseguirsi di manipolazioni dello status del Kashmir, la rinveniamo però con le elezioni del 1987, segnate da oramai confermati brogli a svantaggio del Muslim United Front, un partito che raccoglieva le istanze irredentiste e pro-referendarie sostenute un’ampia varietà di posizioni e organizzazioni.
E’ qui che la già fragile relazione tra la circolazione di idee nella vallata e la loro rappresentazione nella politica parlamentare si sfalda definitivamente, aprendo le porte alla cosiddetta militancy, la guerriglia armata contro l’occupazione indiana, la quale, pur ridimensionata nei numeri rispetto agli anni ’90, si trascina fino ai giorni nostri.
Fino all’estate del 2019 il pilastro costituzionale sul quale si reggeva l’autonomia del Jammu&Kashmir rispetto all’Unione Indiana, per quanto come visto ridimensionata a più riprese, era un articolo della costituzione Indiana, l’articolo 370, il quale definiva formalmente la peculiarità dello stato e dei suoi cittadini.
Uno dei termini più significativi di articolo, riguardava l’esclusività del diritto ad acquisire proprietà e terreni nell’ex principato per coloro che ne erano residenti permanenti, detentori quindi di un documento chiamato State Subject Certificate.
La norma era in realtà stata ripresa dall’epoca coloniale, ma nel progetto del presidente Jawaharlal Nerhu e del suo Congress Party, mirava a tutelare il carattere maggioritario islamico della regione, facendone in qualche modo un simbolo dell’aspirazione secolare del nazionalismo indiano.
In parallelo questa prospettiva, formalmente portata avanti dal Congress Party, il partito che ha dominato per settant’anni la scena politica del subcontinente, si era però delineata sempre più chiaramente un’ideologia di stampo etnonazionalista indù, consolidatasi in organizzazioni come l’RSS e la sua emanazione parlamentare, il BJP.
Per queste organizzazioni il Kashmir, con il suo carattere a maggioranza islamica, più che un tratto di cui fregiarsi (la cosiddetta corona del multiculturalismo Indiano), era una zona da riconquistare e riassorbire nel progetto dell’Hindutva, ossia di un’egemonia culturale e politica dell’induismo.
In questo senso l’abolizione dell’articolo 370 e la diluizione del carattere islamico del Jammu&Kashmir era da anni stato nel programma del BJP, il quale nel maggio 2019, con un’ampia maggioranza di voti, aveva avuto il suo secondo mandato sotto la guida di Narendra Modi.
Intorno ai primi giorni dell’agosto dello stesso anno si erano manifestati degli anomali segnali, nonostante la situazione nella vallata fosse relativamente tranquilla: spostamenti di truppe, evacuazione dei turisti, improbabili allerta per attacchi terroristici.
La mattina del 5 agosto, come già si mormorava nelle fitte disquisizioni politiche degli abitanti della vallata, il Jammu&Kashmir si risvegliò come parte integrale dell’Unione Indiana: l’articolo 370 era stato abolito, la specifica costituzione dello stato era stata eliminata e, mossa ancor più inattesa, il Ladakh, la parte a maggioranza buddista dell’ex principato, era diventato uno Stato a sé stante.
Il progetto fotografico di Andy Spyra, realizzato nella valle durante le rivolte del 2008-2009

After Prayers è un documentario basato su una ricerca etnografica sulle dinamiche attraverso cui la violenza politica si perpetua ciclicamente nella vita ordinaria del Kashmir.
Il progetto, realizzato da Simone Mestroni in collaborazione con Donatello Conti, è stato supportato dalla Wenner Gren Foundation ed ha ricevuto numerose selezioni e diversi premi ai festival internazionali.
Nel link trovate un estratto delle scene iniziali (il film completo è di 60 minuti)
Nei mesi che hanno preceduto l’agosto 2019, il Kashmir è stato invaso da voci di guerra o di divisione in tre parti: in entrambi i casi è stato inevitabile un giro di vite sui civili.
Da allora è passato un anno, ma non è cambiato molto. Anis Wani, del magazine Kashmir Walla, racconta come l’incertezza sia diventata una caratteristica permanente, incidendo sulla qualità della vita dei kashmiri ordinari.
Un estratto della sua graphic novel A year of palpable uncertainty.
Avevo conosciuto Oyoub alla fine del maggio del 2008, poco prima che esplodesse la più profonda crisi politica a cui abbia assistito direttamente in Kashmir, legata al pellegrinaggio di Amarnath.
Era stato un incontro totalmente fortuito: stavo in realtà bazzicando nel bazar di Kanyar, nei pressi del santuario di Dastgir Sahib, in cerca di un porta-pranzo che mi sarebbe servito per trasportare il riso preparato a casa al laboratorio.
I miei mastri d’intaglio, Joka e Gushtaba, con molto garbo, nonché mal celata preoccupazione, mi avevano fatto intendere che non era loro intenzione sfamarmi a oltranza durante il mio apprendistato.
Stavo contrattando con qualche negoziante che non voleva lasciarsi scappare l’occasione di gonfiarmi il prezzo e di guadagnarsi la giornata alle mie spalle, quando un anziano signore si avvicinò suggerendomi gentilmente: “Meglio che tu venga con me, altrimenti sicuramente ti trufferanno”.
Era Rasool, il padre di Oyoub. Si generò in breve una certa simpatia, il progetto del porta-pranzo venne rimandato e fui invitato a prendere un tè e a conoscere suo figlio. Ci infilammo in un vicolo di Noor mohalla, una delle zone più malfamate della città, ed entrammo attraverso un piccolo uscio in un giardino coltivato a haak, una verdura locale a foglia larga.
Un nugolo di bambini smise improvvisamente di giocare e si assiepò silenziosamente ad ammirare quest’inaspettato visitatore “angrees”. Sulla porta di casa era incisa in stampatello la scritta Bath Manzil, residenza Bath.
Entrammo. Oyoub era lì, seduto a terra in una stanza completamente vuota, con a fianco la radio sintonizzata su una qualche stazione in lingua urdu. Era chiaramente cieco e aveva il volto sfigurato da una grossa cicatrice sulla fronte. Sembrava mancargli una porzione della calotta cranica nell’area frontale, e poco sopra gli occhi, uno velato di bianco e uno svuotato del bulbo e ricucito, si intravvedeva, sotto la pelle sottile, una continua e irregolare pulsazione.
Il viso era serio, la bocca chiusa in un’espressione assorta, raccolta da una fitta barba grigio cenere. Era cieco, ma aveva un volto talmente espressivo che mi sarebbe venuto difficile asserire che non possedesse uno sguardo. “Ecco mio figlio, ora vado a preparare il tè mentre voi parlate”, disse Rasool.
Non vi erano molti dubbi: Oyoub era stato un mujahideen. Ad ogni modo, per escludere ogni incertezza, ricordo che forse la seconda o terza cosa che mi disse fu: “Abbiamo tutti il dovere di lottare per qualcosa; io, come puoi vedere, ho sacrificato praticamente la vita stessa per il mio Kashmir”.
Oyoub, classe 1965 era stato uno dei primi ad aderire alla lotta armata, iniziata ufficialmente nell’89. Era ancora uno studente quando, nei primi anni ’80, andando a giocare a cricket in un prato vicino casa, fu attirato dai discorsi di Azam Inquillabi, uno dei pionieri del JKLF, l’organizzazione che, a quel tempo, stava lavorando a una mobilitazione di ampia scala tra le nuove generazioni.
Azam Inquillabi era il suo nome di guerriglia, il suo vero nome era Altaf, Mohamed Altaf. Qualcuno mi disse: “Andiamo a sentire cosa dice”. Eravamo tutti ragazzi. Ci disse che eravamo schiavi, che l’India non aveva nessun diritto di governarci, che eravamo vittime di un sopruso storico e che dovevamo reagire. Le stesse cose me le aveva sempre dette anche mio padre. I miei studi non andavano bene e avevo iniziato a lavorare come commerciante di lenticchie. Intanto collaboravo con il JKLF: distribuivo volantini e andavo agli incontri. Un giorno stavo pregando in una moschea a Chota Bazar. Mi si è avvicinato un uomo e mi ha chiesto: “Cosa stai leggendo?” Avevo un giornale vicino a me. Aveva capito che ero istruito. Risposi: “Le poesie di Allama Iqbal” Mi disse: “Recitami un verso!”
Gli recitai un verso che mio padre mi aveva insegnato: “Ci sarà un solo musulmano alla guida della comunità islamica, dalle sponde del Nilo al Kashgar”. Allora mi chiese: “Vuoi andare in Afganistan?” A quel tempo c’era la guerra russo afgana. Gli risposi: “Si. voglio andare”.
“Ci incontrammo a Maqdoom Sahib e partimmo per Kupwara da Lal Chowk con l’autobus, da Kupwara al vicino al confine in macchina, e da lì in poi a piedi, verso il Kashmir pakistano. Eravamo sei ragazzi. Quella volta al confine non c’erano problemi. Nessuno si chiedeva dove stessimo andando. Chi ci vedeva pensava che stessimo semplicemente andando a fare un picnic. Da lì raggiungemmo Muzafarabad, la capitale del Kashmir pakistano, quindi Rawalpindi e Peshawar. Da lì al confine con l’Afghanistan. Quando ho raggiunto il campo di addestramento di Hizbul Islami ho incontrato Gulbuddin Hekmatyar (uno dei signori della guerra afgana, NDA). Quando mi ha chiesto perché ero venuto gli ho recitato un verso di Iqbal: “Ci sarà un solo musulmano alla guida della comunità islamica, dalle sponde del Nilo a Kashgar”. Lui mi ha baciato sulla fronte. All’epoca in Afghanistan c’era la guerra con i russi e l’America allora supportava pienamente la resistenza afghana. Mi ricordo che c’erano ufficiali della CIA che si aggiravano nel campo di addestramento. A quel tempo ci dicevano che i comunisti erano una minaccia per il mondo islamico, che ci volevano aiutare. Ora ti rendi conto di come le cose sono cambiate…In ogni caso non erano loro che ci addestravano, si limitavano a controllare che tutto fosse organizzato a dovere, il cibo, le condizioni igieniche, i dormitori. L’addestramento ce lo impartivano i militari pakistani, gli ufficiali dell’ISI (servizi segreti pakistani) e gli afgani. Mi ricordo che quello che si occupava del nostro gruppo mi disse un giorno: “Tu non andrai mai avanti in questo mestiere, non hai la testa per comandare”.
“C’erano mujhaidin arabi, ceceni, anche africani, ma erano separati, credo per questioni linguistiche. Ci addestrarono innanzitutto all’uso delle armi leggere: kalashnikov, mitragliatrice, lanciarazzi, pistola, granate, un po’ le mine e gli esplosivi, come organizzare un’imboscata… Un po’ di tutto. Per circa tre mesi rimanemmo nel campo, noi sei kashmiri e altri pakistani e afgani. Poi finalmente ci mandarono a combattere. Devo dire che i russi sono dei codardi. Magari avevano armi sofisticate, ma non combattono in maniera appropriata. Ricordo bene il primo scontro: eravamo nel bunker e ci attaccarono con i carro-armati. Ci bombardarono con l’artiglieria e i mortai. Contrattaccammo con i lanciarazzi e si ritirarono immediatamente. In breve ci attaccarono nuovamente e riuscimmo a distruggere due o tre carro-armati. Questo è stato il mio primo combattimento. Se ho ucciso qualcuno solo Dio lo sa! A quel tempo, a vent’anni, il mio sangue ribolliva. Se devo dire cosa provavo… beh, mi sono divertito! Nella comunità islamica ci sono afgani, iraniani, turchi, pakistani, indiani… ma gli afgani sono veramente coraggiosi. Ho visto il loro coraggio, combattono come si gioca, maneggiano le armi come giocattoli. Sparavano ai russi e poi ridevano! Ridevano…veramente! E gli urlavano “Kush amdiit! Kush amdiit!” Benvenuti… benvenuti! Ho ascoltato con le mie stesse orecchie. Quando i carro-armati ci venivano incontro gli gridavano “benvenuti!” Erano felici!”
Quello della resistenza afgana costituisce un nodo chiave nella storia del movimento separatista kashmiri sul piano storico, politico, simbolico, narratologico e morale.
Nella vicenda di Oyoub di fatto, i due fenomeni, la cui relazione non è sempre evidenziata nell’ambito dei lavori storico-politologici d’area, si annodano inscindibilmente sul piano esistenziale, rivelando connessioni tra geopolitica e immaginario locale.
Da un lato – e questo è un dato storicamente indiscutibile – i primi militanti kashmiri hanno ricevuto il training alle armi proprio in funzione del conflitto russo-afgano e in questa fase hanno sperimentato il campo di battaglia per la prima volta.
In secondo luogo questi campi, in genere disseminati lungo il confine tra Afganistan e Pakistan, sono gli stessi che verranno utilizzati da parte dell’ISI e dei militari pakistani per l’addestramento della massa di giovani kashmiri che attraverseranno il confine tra la fine degli anni 80 a tutti gli anni 90.
Terzo, il potenziale militare accumulato durante il conflitto russo-afgano, che aveva attirato jihadi dalle aree più disparate, rimaneva in gestione esclusiva dell’ISI, essendosi praticamente estinto il pericolo comunista e avendo quindi la CIA perso interesse nella gestione della situazione.
Passando alla questione dell’immaginario, rimane sorprendente come nella visione kashmiri della storia (e probabilmente pakistana e afgana), il crollo dell’Unione Sovietica e dello stesso comunismo (percepito tutt’ora da molti come sinonimo di ateismo e anti-islamismo), sia dovuto alla sola guerra in Afganistan.
Oltretutto, all’epoca, il fatto che la resistenza afgana avesse avuto successo contro un colosso come l’URSS non era stata ricollegata al fondamentale supporto americano; era stata invece percepita e raccontata come la vittoria di un piccolo Stato musulmano contro un impero militare emblema dell’ateismo occidentale.
Prosegue Oyoub: “Perché la loro storia è grande, gloriosa. Se leggi la storia del Kashmir siamo sempre stati schiavi. Non abbiamo mai avuto un governo nativo. Gli afgani ci hanno governato, senza dubbio erano musulmani, ma erano afgani! I Moghul ci hanno governati, i Sikh ci hanno governati, i Dogra ci hanno governato, sono una comunità minuscola, ma hanno regnato su di noi. Ma i kashmiri da cinquecento anni a questa parte non hanno mai governato sé stessi. Gli afgani non hanno mai accettato un dominio straniero. Qualcuno ha detto: “l’Afghanistan è la tomba degli imperi”. Prima Alessandro Magno che pur avendolo conquistato non fu in grado di mantenerlo, gli inglesi, alla stessa maniera rinunciarono a governarlo direttamente, poi la Russia e ora è il turno degli USA. Il mio parere è che dovrebbero negoziare con i talebani, perché non dimenticano mai. Le armi sono nel loro sangue.”
Negli corso degli anni ’80 il caso afgano era stato un catalizzatore strutturale nell’immaginario politico kashmiri e per molti versi lo è tutt’ora.
Di fatto, se vogliamo osservare la questione in una prospettiva ampia, tenendo presente quella che è la mappatura dell’immaginario politico sul terreno, viene da dire che l’insurrezione dell’89, e il suo stesso fallimento, siano legati al fatto che in quella fase, sul piano globale, si sia verificata una frattura a livello di equilibri geopolitici e di macro-narrative.
Per certi versi la fase saliente dell’insurrezione armata nella vallata si dipana lungo il periodo che va dalla caduta dell’URSS -e quindi la fine dell’assetto bipolare- al 2001 -quando la questione della lotta al fondamentalismo islamico s’impone come chiave interpretativa nello scacchiere politico e mediatico globale.
Quando Oyoub dice con amara ironia: “ci dicevano che ci stavano aiutando a proteggere l’Islam dai comunisti, ora vedi come sono cambiate le cose”, questi si mostra pienamente consapevole dello slittamento narratologico e strategico avvenuto nel corso degli ultimi 25 anni, nonché delle conseguenze sull’arena politica kashmiri.
Ovviamente il terminale ultimo di responsabilità del cambio di piattaforma discorsiva rimangono implicitamente gli USA, com’è implicito lo status di sostanziale impotenza dei mujahideen, per i quali era effettivamente impossibile contestualizzare le loro scelte di azione politica all’interno di un quadro così complesso.
Del resto anche una visione postuma di Rambo 3, quello in cui Stallone combatte a fianco dei poveri mujahideen indifesi, manderebbe in cortocircuito rappresentazionale un qualsiasi fruitore occidentale.
Proprio dal punto di vista cinematografico è proprio Oyoub a rivelare una sorprendente connessione tra la sua decisione di imbracciare le armi e la produzione Hollywoodiana.
Se tra le sue fonti di ispirazione mi aveva più volte citato la poesia di Iqbal, con il suo sogno di ricostruire l’unità del mondo Islamico e la sua definizione di schiavitù, successivamente, ha aggiunto: “Durante la mia adolescenza amavo i film di guerra, come Il ponte sul fiume Kwai, Il leone del deserto. Questi sono i film che mi hanno ispirato prima di entrare nella lotta armata. E poi, quando ero già operativo mi ricordo di aver visto Commando con Arnold Swarznegger. Nel film a un certo punto usava un tipo di mine che avevo già visto. Era una mina antiuomo che avevo imparato a innescare nei campi di addestramento in Aghanistan.”
Il movimento d’insurrezione in cui era stato addestrato Oyoub, il JKLF, era nato in una fase storica in cui i valori a cui si richiamava – autodeterminazione, resistenza, democrazia ecc. – non sarebbero stati sufficienti a sollecitare il sostegno dell’occidente.
Il tramonto dell’assetto bipolare, all’interno del quale l’India (anche se formalmente non allineata) era rimasta diplomaticamente più prossima all’URSS, stava per mutare radicalmente gli equilibri della geopolitica areale, allontanando progressivamente l’ipotesi di un sostegno degli USA alla causa Kashmiri tramite il Pakistan.
Del resto l’ideologia del JKLF rimandava sì all’indipendenza e agli ideali che ruotano attorno al più aggiornato modello di Stato nazionale occidentale: democrazia, laicità e autodeterminazione in prima linea, ma la realtà sul terreno, come mi ha candidamente confessato Oyoub, era ben diversa: “Eravamo giovani, avevamo le armi e uno splendido slogan, Azadi, libertà. Nessuno può mettere in discussione la libertà! Sembrava che nessuno potesse fermarci! In realtà, urlavamo, ma nei nostri cuori c’era il Pakistan.”
E’ infatti praticamente in coincidenza con l’inizio dell’insurrezione che emerge Hizbul Mujahidin. L’obiettivo dichiarato della nuova organizzazione armata è l’annessione al Pakistan e il logo raffigurava un Corano aperto con due Kalashnikov incrociati.
HM, forte anche del supporto del network di Jamaat-e-Islami, non tarderà ad imporsi sul JKLF, sia in scontri diretti che per logistica e numero di reclutamenti.
Tra gli altri proprio Oyoub, che già nel 1990 sarebbe diventato comandante d’area nella old town di Srinagar, il cuore geografico dell’insurrezione Kashmiri.
Questo brano è un estratto del libro ‘Linee di Controllo: genealogie, pratiche e immaginari nel separatismo kashmiri’ (Meltemi 2008). Il testo, basato su una ricerca etnografica completata tra il 2008 e il 2012 è un’esplorazione degli aspetti microsociali attraverso cui il discorso separatista e il conflitto nel suo complesso si perpetuano nella valle del Kashmir.
di Maria Tavernini
Una sera di settembre di dieci anni fa, Amir stava camminando a passo svelto tra le stradine deserte di Baramulla, non lontano dal confine con il Pakistan, nel Kashmir indiano, quando le forze di sicurezza gli hanno sparato contro, vicino al vecchio ponte. “C’erano stati scontri per tutto il giorno ma in quel momento sembrava tutto tranquillo”, racconta Amir, 30, seduto a gambe incrociate sul pavimento di legno nella penombra della stanza. Il suo viso porta i segni di quel colpo di fucile che gli ha cambiato la vita. “Ho subito diverse operazioni, in tutta l’India,” dice “ma sono ancora completamente cieco”.
Centinaia di pallini di metallo lo hanno colpito nella parte superiore del corpo facendogli perdere la vista da entrambi gli occhi. Amir è stata la prima vittima ufficiale dei fucili a pellet nel Kashmir indiano. Era il 2010, l’anno in cui le forze di sicurezza nel territorio conteso erano state equipaggiate con una nuova, devastante arma per sedare le proteste. I fucili a pellet sono solitamente usati per uccidere animali di grossa taglia; oltre al Kashmir, non sono utilizzati in nessun altro stato indiano contro le persone.
Sono fucili a pompa caricati con cartucce piene di pellet – tra i 450 e i 600 pallini di piombo affilati – che esplodono raggiungendo un ampio raggio, sempre più usati nella valle del Kashmir per sedare le proteste. Secondo il protocollo, chi le usa dovrebbe mirare al suolo, ma le forze di sicurezza indiane molto spesso mirano al volto e al petto dei manifestanti.
Amnesty International e altre organizzazioni internazionali hanno ripetutamente esortato le autorità indiane a mettere al bando l’uso dei fucili a pellet per controllare le rivolte in Kashmir.
Anche se sono definiti “non-letali”, secondo Amnesty, che ha raccolto i dati di centinaia di persone in Kashmir, i pellet sono responsabili dell’accecamento di centinaia di civili e della morte di almeno 20 persone da agosto 2016.
ll Kashmir è un posto in cui le persone vengono uccise (e accecate) anche in tempo di “pace” e dove la tortura viene sistematicamente usata contro i civili. La violenza esplode ciclicamente in Kashmir. Nell’estate del 2016 la valle era stata investita da una nuova ondata di proteste. Asif aveva 9 anni quando era stato sparato, proprio vicino a casa, ad Anantnag. Era passata una settimana da quando il comandante del gruppo Hizb ul Mujahideen, Burhan Wani, era stato ucciso dalle forze di sicurezza indiane, mentre il coprifuoco durato 53 giorni era temporaneamente revocato.
“Stavo andando allo shop quando è passata una macchina della polizia e alcuni ragazzi hanno iniziato a lanciare delle pietre. La polizia gli ha sparato e 15 pellet hanno colpito me”, dice Asif. Uno di questi lo ha colpito nell’occhio destro, dal quale ha perso la vista. Nonostante le difficoltà date dalla ridotta visuale, Asif non ha abbandonato la scuola e ha continuato a studiare grazie all’aiuto dei suoi compagni.
L’uccisione di Burhan Wani nel luglio 2016 aveva scaraventato la valle in una nuova fase di proteste. Wani era un giovane e carismatico militante, molto popolare sui social media tra i giovani kashmiri: una generazione nata negli anni in cui le forze di sicurezza indiane avevano inasprito la condotta repressiva sui civili, spingendo molti giovani verso la militanza armata.
“Il martirio di Wani è stata la scintilla che ha acceso l’intera valle. Il governo aveva imposto un coprifuoco di quattro mesi, mentre i leader separatisti invocavano uno sciopero a tempo indeterminato,” ricorda il fotografo romano Camillo Pasquarelli, che ha seguito la rivolta del 2016 e ha incontrato dozzine di vittime dei pellet, accecate in quell’estate di sangue, “centinaia di ragazzi si erano riversati nelle strade per protestare contro l’occupazione indiana. Da luglio 2016, le forze di sicurezza hanno risposto utilizzando i fucili a pellet in maniera massiccia”. Quell’estate, la Central Reserve Police Force (CRPF) aveva ammesso di aver sparato più di 2000 cartucce per disperdere i manifestanti nelle due settimane successive all’uccisione di Wani. Oltre il 50 per cento delle 317 persone ferite quell’anno erano state colpite agli occhi.
La polizia federale sostiene che i fucili a pellet siano l’opzione meno letale per contenere le proteste violente.
Secondo il rapporto My world is dark (“Il mio mondo è buio”) dell’Associazione dei genitori delle persone scomparse (APDP), watchdog dei diritti umani in Kashmir, dal 2016 sono stati registrati 3800 casi di lesioni e accecamento da pellet.
Tuttavia, l’APDP ritiene che il numero sia molto più alto: molte vittime non si fanno avanti per paura di eventuali rappresaglie e molte delle persone colpite non erano coinvolte negli scontri con le forze di sicurezza. Quelli che invece erano coinvolti, tendono a evitare di parlarne, per timore di ritorsioni. I dati e le statistiche sulle vittime non sono quindi sempre precise e tendono con ogni probabilità a sottostimare la realtà.
Manzoor, 18 anni, è stato colpito durante il bagno di sangue dell’estate 2016. Circa 20 pellet disseminati praticamente su tutto il corpo: dall’occhio sinistro vede solo figure sfocate, tanto che è stato costretto a lasciare la scuola. “Le forze di polizia mi hanno sparato da una distanza inferiore a 10 metri. Ho ancora un pellet in un occhio; i medici hanno detto che è troppo pericoloso rimuoverlo” sostiene.
Secondo Zahoor Wani di Amnesty International India “in alcuni casi, le persone ferite da fucili a pellet hanno i pallini di metallo ancora conficcati nel cranio, vicino agli occhi. I medici hanno timore di rimuoverli, per paura di intaccare la vista, ma non si sa quali siano gli effetti a lungo termine del piombo nel corpo”.
Nel 2017, Maleeha Lodhi, ex-rappresentante del Pakistan presso le Nazioni Unite, ha condannato l’uso aggressivo dei fucili a pellet da parte dell’India definendolo il “primo accecamento di massa nella storia”. Oltre a perdere la vista, molte vittime affrontano traumi, depressione e disturbi post-traumatici da stress (PTSD). Anche donne e bambini piccoli diventano vittime in questo conflitto a “bassa intensità”.
Shakeela, una donna di 37 anni ricorda di una notte di qualche anno prima: “avevo sentito dei rumori provenire dall’esterno della casa. C’erano venti poliziotti che tenevano due ragazzi legati, con la faccia coperta: era un fake encounter [“finto scontro”: quando sospetti terroristi, o spesso semplicemente civili vengono uccisi a sangue freddo dalle forze armate facendolo passare per uno scontro a fuoco]. Sono uscita e ho iniziato a gridare verso un poliziotto kashmiri. Mi ha colpito con un bastone, io l’ho schiaffeggiato e gli ho detto che avrebbe dovuto vergognarsi per quello che stava facendo alla sua gente. Dopo una settimana c’erano di nuovo scontri così ho aperto il cancello, c’era lo stesso poliziotto in strada. Mi ha visto e ha aperto il fuoco. Sono svenuta, ma credo di averlo sentito ridere”.
Dozzine di pallottole hanno colpito Shakeela al petto e tre agli occhi. Shakeela era stata colpita a distanza ravvicinata: i pallini hanno trapassato la retina, lasciandole solo il 10 percento della vista. Alla fine di novembre 2019, una bambina di 19 mesi è stata accecata dai pellet, riesplodere le contestazioni per l’uso indiscriminato di questo strumento di controllo nella valle.
Nel secondo rapporto sui diritti umani in Kashmir redatto dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani si legge che almeno 1.253 persone sono state accecate dai pallini di piombo dalla metà del 2016 alla fine del 2018. Le autorità sostengono di utilizzare i fucili a pellet durante le proteste solo se queste prendono una piega violenta e gli agenti vengono presi di mira dalle sassaiole.
Quando le proteste esplodono per le strade delle città del Kashmir dopo le preghiere del venerdì, è spesso la polizia locale ad essere incaricata di sedare gli scontri. Molte delle vittime sono state accecate dai pallini sparati da poliziotti kashmiri, aggiungendo un ulteriore livello di complessità al conflitto.
“Temendo di essere accusate dal governo di aver preso parte alle proteste e di subire ritorsioni, le vittime non forniscono i loro veri nomi in ospedale, impedendogli quindi di ottenere un risarcimento. In alcuni casi, vengono offerti impieghi statali o soldi come risarcimento cosicché, alla fine, nessuno risulta responsabile della violenza. Gli abitanti del Kashmir hanno perso fiducia nella giustizia”, spiega Wani di Amnesty. “Il governo sta cercando di risolvere il problema militarmente, ma ha solo esacerbato le ragioni dei manifestanti radicalizzando il sentimento anti-indiano”.
Tortura, coprifuoco, blocchi, arresti di massa, omicidi extragiudiziali di civili, fanno da tempo parte della strategia di controllo dell’India in Kashmir, aggravando il risentimento verso l’occupazione indiana, trasformatasi in un assedio militare a partire dallo scorso agosto. L’uso indiscriminato di fucili a pallini apparentemente “non letali” da parte delle forze di sicurezza in Kashmir è una strategia relativamente nuova e devastante: nonostante abbia suscitato indignazione internazionale e inchieste nazionali, continua senza tregua, ad un enorme costo umano.
“Il governo offre lavoro alle vittime di pellet”, dice Aquib, 18 anni, che ha abbandonato la scuola dopo la parziale perdita della vista, “e in cambio, ci toglie gli occhi”.
La versione originale di questo articolo, scritto sulla base delle interviste raccolte dal fotografo Camillo Pasquarelli in Kashmir, è stato pubblicato su TRT World.
di Siva Sai Jeevanantham
Foto 1: La lotta della memoria contro l’oblio è parte integrante del movimento del Kashmir
“L’anima che non prega per essere con te, che Dio la punisca, e che mai accada che sarò vivo e lontano da te!”
Il movimento dell’Azadi in Kashmir non è semplicemente una lotta per la giustizia, ma una lotta per la memoria, contro l’oblio. Siva Sai Jeevanantham, uno studente del National College of Design, ha
raccolto e archiviato foto di famiglia e documenti investigativi relativi alle persone che l’esercito indiano ha fatto scomparire nel nulla nel corso degli ultimi anni.
Ogni foto che realizziamo diventa un frammento della memoria, una registrazione del passato. Attraverso questo archivio Siva, in collaborazione con l’APDP (Associazione per i Genitori delle
Persone Scomparse) ha provato a capire come l’atto del ricordo, attraverso il supporto delle fotografie personali, diventi resistenza politica.Quando non è certo se una persona scomparsa sia viva, la famiglia cerca sollievo riprendendo in mano queste immagini con la speranza che questa un giorno ritorni. In questo conflitto senza fine la resistenza a livello famigliare consiste nel rievocare il passato e nel rifiutare il fatto che i loro amati non esistano più.
Foto 2: Dimenticare è una forma di perdono per molte famiglie, che non hanno più la forza per ricordare
Ho collaborato con l’APDP, un’organizzazione fondata da Parveena Ahanger per dare voce alle famiglie coinvolte nella lotta per rendere giustizia ai loro cari scomparsi. L’APDP è sostanzialmente un movimento che cerca di far emergere le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate indiane in Kashmir. Ho provato a chiedere a Parveena cosa significhi giustizia per lei e le altre famiglie.
“Che ci ritornino i nostri figli… L’India è in grado di ridarceli?” ha controbattuto. Ho risposto alla sua domanda con il silenzio, lo stesso silenzio del governo indiano. Per queste famiglie dimenticare significa accettare l’ingiustizia che le circonda e soccombere all’oppressione.
Ricordare, invece, dà loro la forza per continuare a lottare. Proprio mentre le famiglie si impongono la speranza di rivedere i loro figli, le foto riportano il pensiero al vuoto creato dalle politiche del conflitto.
Lavorando a questo progetto ho capito che non ci è dato sapere quale funzione le immagini che realizziamo avranno in futuro. Le immagini possono essere fatte con uno scopo e col tempo acquisirne di nuovi. Le immagini di questo progetto, in larga parte, sono state fatte per immortalare i momenti più importanti e felici delle vite di queste persone, ma hanno assunto tutto un altro valore.
Frequentando le famiglie delle vittime, ho incontrato la determinazione di una madre, la rabbia di una moglie e, in generale, un’invisibile resistenza nei confronti della violenza strutturale che le
circonda. Alcune famiglie non avevano una foto in cui tutti i membri fossero presenti, e per risolvere il problema avevano creato dei collage.
Queste operazioni mostrano quanto importante fosse suturare, senza occultarla, l’ingiustizia subita. Ricordare significa resistere, sperare dopo anni che qualcuno sia vivo in qualche prigione indiana, è la loro silenziosa rivolta.
Foto 3: Zeena Begum posa in uno studio fotografico indossando la camicia di suo marito
Mi è capitato più volte di sfogliare fotografie di coppie in cui il marito è stato fatto sparire dall’apparato militare indiano, mentre la moglie è rimasta sola con i figli. Una storia che mi ha colpito particolarmente è quella di Zeena Begum. Zeena, moglie di Abdul Rashid Parra, non è
lontanamente incline a dimenticare suo marito e il suo felice matrimonio. Mi ha raccontato che una volta suo marito l’ha fatta vestire apposta con occhiali e cappello per una sessione fotografica.
Piuttosto imbarazzata a causa di quell’insolito vestiario, Zeena ricorda più che altro l’agitazione del momento. Oggi però desidererebbe solo che lui fosse qui a costringerla a farsi fotografare un’altra volta. Zeena si ricorda tutto, dalla prima vacanza alla località turistica di Dharibal alla
routine quotidiana. Quando le ho chiesto come si relazionava a questa assenza mi ha risposto che era un tema deprimente e che, a parte per i suoi figli, le aveva fatto perdere ogni voglia di vivere.
Ogni documento di sparizione dell’APDP contiene una foto segnaletica della persona scomparsa. Molte sono immagini ritagliate da album fotografici di famiglia. Momenti personali, come un ritratto ad un matrimonio, diventano materiale investigativo, cambiano vesti funzionali e simboliche.
Queste microscopiche transizioni sono in fondo segni di quello che significa vivere in una zona di conflitto.
Foto 4 Abdul Rashid and Zeena durante la prima vacanza dopo il matrimonio.
Le foto, oltre a fare da supporto al dolore e alle memorie personali, aprono anche a una dimensione
mistica, quella di un Kashmir immutabile che si nasconde dietro alle persone ritratte. I soggetti posano di fronte ad una scenografia nello studio, o in una località turistica, in cui il Kashmir è essenzializzato in uno spazio ideale, immaginario, dove è possibile fantasticare una vita felice con il proprio caro. Ma la realtà in qualche modo si insinua nelle espressioni delle persone ed elude la finzione.
Il Kashmir è stato trasformato in una zona di guerra da India e Pakistan: la soluzione sarebbe potuta essere semplice se non fossimo stati così possessivi, ma sfortunatamente una componente ossessiva del patriottismo e l’avidità per la terra (più che per le persone che la abitano) è degenerata in crudeltà.
Forse, come indiani, preferiremmo contemplare gli splendidi scenari sullo sfondo e censurare gli esseri umani in primo piano, con le loro storie di dolore. Il Kashmir è stato consegnato a governi fantoccio e al controllo dell’esercito.
L’autonomia della regione è stata erosa, attraverso quella che Haley Duschinky ha definito “occupazione costituzionale”.
La violenza della repressione politica ha però incrementato il desiderio di indipendenza. Questo momento della resistenza si struttura intorno ai ricordi e alle emozioni che sopravvivono nel mondo interiore dei kashmiri.
Ascoltare le storie di ogni fotografia ha reso il lavoro di archiviazione più personale che politico, rivelando al contempo l’intersezione tra gli aspetti ideologici della memoria famigliare e la vita affettiva. Queste fotografie possono e devono essere usate per discutere del conflitto, per catalizzare e moltiplicare l’efficacia della memoria.
Un conflitto, specie per chi lo vive, ruota intorno al ricordare e dimenticare.Così sono andato a curiosare nel mio album di famiglia: cosa succederebbe se un giorno dovessi sparire, e i miei genitori fossero lasciati senza chiarimenti?
Questo è probabilmente uno dei traumi più laceranti per chi vive in una zona segnata da un conflitto di lungo termine.
Foto 5 – Il report dell’alta corte del J&K riguardo il “prelevamento” di Ghulam Nabi Bhat
Foto 6 – Una richiesta da parte di Abdul Rehman Khan al Ministero della Difesa in cui chiede il permesso di incontrare il figlio Fayaz Ahmad
Foto 7 – Basheer Ahmad Sofi è stato l’ultimo dei figli di Hajra Begum ad essere preso. È stato prelevato da un battaglione dei Rashtriya Rifles presso una panetteria a Onagam, Bandipura. Basheer è posto al centro del collage, in mezzo agli altri fratelli.
Foto 8 – Una poesia di Basheer Sofi sulla nostalgia per qualcuno, incisa su un muro di casa: “L’anima che non prega per essere con te, che Dio la punisca, e che mai accada che sarò vivo e lontano da te!”
Foto 9 – Bashrat Saleem Parray aveva 18 anni quando è scomparso. Stava rientrando sa Sonwar, Srinagar dopo le preghiere serali in moschea. Secondo i testimoni, è stato prelevato dalle forze militari. L’esercito ha dichiarato che è stato ucciso mentre cercava di attraversare il confine con il Pakistan. La sua foto non è stata rinvenuta tra i casi di scontri sul confine.
Foto 10 – Farooq Ahmed è stato scambiato per un omonimo ribelle e prelevato dalla Border Security Force (BSF) a Shankarpora, Srinagar. Alla famiglia era inizialmente permesso di andarlo a visitare, ma in seguito l’ufficiale responsabile, Jaswant Singh, ha negato l’arresto. Sei mesi dopo, il nipote di Farooq è entrato a far parte di una organizzazione di ribelli, ed è stato ucciso dalle forze indiane. Aveva due figli e una moglie, Sara, che in seguito si è risposata.
Foto 11 – I figli di Farooq Ahmed a Nowgam, Kashmir
Foto 12 – Abdul Rashid Malik aveva 18 anni quando è stato prelevato da casa sua a Kupwara. Due ufficiali dell’intelligence lo hanno prelevato e trasportato nel campo della Border Security Force (BSF) di Kupwara.
Foto 13 – Il fratello di Abdul Rashid (con la camicia bianca) insieme a degli amici. Docente ad un college di Kupwara, dopo la scomparsa del fratello ha avuto problemi psichiatrici e ha iniziato a scarabocchiare sui muri di casa
Foto 14 – Scarabocchi del fratello di Abdul sui muri di casa.
Foto 15 – Manzor Ahmad di Chattabal, Srinagar, è stato prelevato dalle forze di sicurezza. Sua zia ricorda di quando i militari hanno circondato l’area e hanno fatto irruzione in casa in piena notte. Un ufficiale del 35 Rashtriya Rifles di nome Malothra le ha detto che doveva fare un’identificazione. Secondo un’inchiesta della polizia Manzor era stato un “ribelle”. Le foto distinte di Manzoor, sua zia e i suoi cugini sono state composte in un collage per rendere l’impressione di una foto di
famiglia.
Le madri del Kashmir ricordano la vita e la morte dei loro figli – che sono morti nel conflitto in corso in Kashmir, lasciando dietro di sé famiglie lacerate e speranze infrante delle loro madri.
l rap del Kashmir è la continuazione delle sue origini popolari che sono politiche. E’ nato da una rivolta nel 2010, pioniere della generazione Millenial del Kashmir, testimone e sopravvissuto alla lunga guerra.
Leggi tutto il longform tratto da Made in Kashmir
Era l’aprile del 2011 e l’appuntamento con la semifinale dei mondiali di cricket andava avvicinandosi. Le candidate, dopo molti anni erano India e Pakistan, con la prima favorita sulla carta.
Il governo, per evitare disordini, aveva addirittura vietato l’assembramento di più di quattro persone negli spazi pubblici. I locali dovevano rimanere chiusi. Tra gli altri accettai l’invito di Saiba, una ragazza presso la cui famiglia avevo vissuto per circa un mese nel 2009, fino al momento in cui mi era stato possibile sopravvivere in una totale assenza di privacy.
Nonostante tutto avevo mantenuto rapporti di cortesia con i suoi genitori, ogni tanto avevo continuato a fare delle visite per il tè, portando dolci e bibite per i quattro figli. La famiglia di Saiba apparteneva alla classe medio bassa: la casa si trovava nella Bilal Colony, un’area residenziale di Srinagar piena piccole abitazioni abusive, ricavate da un terreno bonificato vent’anni prima dal governo ed immediatamente occupato.
In massima parte le famiglie di quell’area erano Hunz (o Hangi), la sezione della popolazione di Srinagar collegata alle attività del lago: la pesca, l’agricoltura, il turismo.
Sotto quest’aspetto essere Hanz riporta ad uno stereotipo di rozzaggine, scarsa educazione, disonestà, sporcizia, inaffidabilità, che segna una linea di demarcazione abbastanza netta rispetto al resto della popolazione.
All’interno delle strategie matrimoniali, ad esempio, nessuno vuole sposare o far sposare un Hunz ad un parente e l’ipotesi spesso suscita ilarità per il suo carattere assurdo. Non si tratta di una questione esclusivamente economica, bensì morale, in quanto molti Hunz hanno nel tempo sviluppato una condizione economica di buon livello ed hanno abbandonato il lago e le sue attività, come nel caso di Saiba e la sua famiglia.
La Bilal Colony è appunto una di quelle aree in cui gli Hunz hanno iniziato un processo di “riqualificazione” del loro status, cercando di dare un’istruzione ai loro figli ed emanciparsi dallo stereotipo che li intrappola. In queste aree, effettivamente, i primi matrimoni tra Hunz e non, vanno progressivamente aumentando, destando un certo sospetto nel vicinato. A livello economico la famiglia di Saiba viveva in uno stato di relativa indigenza: il padre saltuariamente lavorava come autista di autobus e la principale fonte di sussistenza derivava dalla irrisoria pensione della nonna.
Avevo ricevuto l’invito il giorno stesso in cui le finaliste avevano passato il turno, e non avevo potuto quindi declinare. Saiba mi aveva confidato il fatto che nella famiglia, com’è normale, erano tutti tifosi del Pakistan, che lei sola avrebbe supportato l’India e che avere una personalità neutrale a vedere la partita le sarebbe stato d’aiuto.
Io, pur essendo ben poco appassionato al
Saiba, in piena adolescenza, era di fatto l’elemento ribelle della famiglia, tant’è che più volte durante il mio soggiorno a casa sua, l’anno precedente, l’avevo vista litigare sfrontatamente con il fratello maggiore e con il padre. Un paio di volte avevo notato che aveva dei lividi sul volto e dopo aver provato inutilmente a spiegarmi che era scivolata nel bagno, aveva dovuto ammettere che il fratello l’aveva picchiata. Il college che frequentava, come molti altri gestiti indirettamente dal governo, era didatticamente vicino al nazionalismo indiano. Tutti elementi che entravano in conflitto con la tradizione famigliare, che per quanto non politicamente impegnata, rimaneva affettivamente prossima al separatismo. Lei stessa in certi momenti, in particolare durante i lunghi periodi di coprifuoco e sciopero dell’estate 2019, mi aveva chiaramente dichiarato di voler intraprendere la carriera di avvocato, e di diventare un’attivista anti-indiana.
Nonostante questa impostazione ideologica di fondo, nell’ambito del cricket Saiba aveva scelto di muoversi nello spazio dell’emancipazione relativo alle dinamiche di potere familiari. La madre, durante la partita, si era sostanzialmente auto-emarginata, lasciando la comprensione tecnica del gioco ad Abdul ed Adil e prestandosi ad un coinvolgimento emotivo ancillare, mirato perlopiù a disperdere la tensione degli uomini. Aveva apparecchiato, sparecchiato, non si era (singolarmente) lamentata quando Abdul aveva lasciato la cena nel piatto, aveva fatto qualche domanda ingenua sull’andamento della partita e in conclusione, quando le cose erano chiaramente orientate al peggio, si era messa a lavare i piatti in cucina.
La prima scelta di carattere emancipatorio affrontata da Saiba era stata quella di riporre tutta la sua soggettività nella fruizione della partita. Ne conosceva le regole, che mi aveva spiegato scrupolosamente, conosceva i giocatori, le loro qualità, i margini di errore che ci si poteva permettere ecc. Già in questo Saiba si stava infiltrando sfrontatamente in una dimensione simbolica che sul piano formale sarebbe normalmente dovuta rimanere dominio della mascolinità. Più di qualche volta, nel corso di conversazioni intime, mi aveva confessato la frustrazione legata al fatto di essere una ragazza in una società islamica, di non potersi muovere liberamente, di non poter nemmeno pensare di andare a studiare a Bangalore, il suo sogno difficilmente irrealizzabile.
Per svincolarsi ulteriormente dalla forza strutturante della ripartizione di gender intrinseca alle dinamiche famigliari, all’Islam ed alla tradizione kashmiri, aveva in qualche modo trovato un sostegno nel supportare l’India in ostilità aperta con il resto della famiglia, i cui membri avevano preso la cosa con una certa ironia canzonatoria. Saiba era per Adil ed Abdul quella “strana”, che doveva fare sempre il contrario di quello che facevano gli altri, che alla fine tifava Pakistan e voleva solo dare a vedere che supportava l’India. La madre invece sembrava covare una segreta fierezza nei confronti di quella scelta, riconoscendo forse una forza che lei, per varie ragioni, non avrebbe mai espresso. Era sensazione comune a tutti il fatto che la scelta di sostenere l’India non riguardasse l’ambito della politica formale, nonostante Saiba avesse detto di non sentirsi affatto Pakistana, perché di fatto si può essere musulmani ed indiani allo stesso tempo, e che la cosa non crea nessun paradosso. Il supportare l’India, al di là di queste razionali dichiarazioni di carattere ideologico, ricollegabili agli ideali di nazionalismo secolare impartite a scuola, rimaneva comunque circoscritta al cricket, intercettando la configurazione di forze della famiglia. Il politico tra queste due piattaforme discorsive, rimaneva un elemento strumentale, imprescindibile tramite che sarebbe riemerso attraverso una rivalsa delle emozioni e dell’affettività, con un sincero rientro nell’identità politica famigliare.
In fondo però Saiba la sua partita l’aveva vinta: aveva cioè negoziato la sua soggettività femminile sfondando in maniera relativamente diplomatica e dirompente degli argini formalmente predefiniti; aveva affrontato l’intero andamento della partita, sviluppando un’empatia crescente nei confronti del Pakistan quando questo si avviava alla sconfitta, mentre gli uomini di casa se n’erano andati per non affrontare emotivamente la questione. Tutto questo utilizzando una banale partita di cricket, le cui diramazioni ed implicazioni erano penetrate nella struttura famigliare Hangi della Bilal Colony di Srinagar. Per contro, la questione della “cricket diplomacy” dell’incontro tanto conclamato tra Gilani e Mohaman Singh, che aveva riempito le prime pagine dei giornali per diversi giorni, si risolse in chiacchiere prive di efficacia fattiva.
Mi avvia verso casa, anch’io piuttosto deluso, non saprei dire se per la sconfitta del Pakistan o per un semplice contagio emotivo. Passando davanti all’accampamento della CRPF di Bishembernagar sentii i canti, le urla, gli schiamazzi dei paramilitari indiani. Erano ubriachi: indiani ubriachi e felici chiusi in un edificio ricoperto di rotoli di filo spinato, circondati da gente che tristemente stava elaborando le ultime analisi tecniche sulla partita, sugli errori di un Afridi (ilcapitano) oramai vecchio, sulla superiorità schiacciante dell’India anche sul campo da gioco. In quel momento quello mi sembrava l’osceno simbolo di un’arrogante occupazione straniera. Il Pakistan, nonostante tutta la consapevolezza storica ed il distacco metodologico, era straordinariamente vicino. Per tutta la notte i festeggiamenti, racchiusi nelle sacche militarizzate della città avrebbero inondato il silenzio funereo della città. Ma già la mattina seguente passando davanti al medesimo campo militare avrei salutato la guardia di turno, che indossava la divisa delle grandi occasioni, congratulandomi per la splendida partita, di un gioco che mi risultava noiosissimo, e le cui regole non mi erano ancora completamente chiare. Le sue implicazioni sul piano microsociale erano molto più rivelatorie: il Pakistan era innanzitutto un’imprescindibile e potentissima emozione.
Questo brano è un estratto del libro“Linee di Controllo: genealogie, pratiche e immaginari nel separatismo kashmiri” (Meltemi 2008). Il testo, basato su una ricerca etnografica completata tra il 2008 e il 2012 è un’esplorazione degli aspetti microsociali attraverso cui il discorso separatista e il conflitto nel suo complesso si perpetuano nella valle del Kashmir.
, le avevo promesso che mi sarei addentrato nelle dinamiche del gioco e che avrei tifato per l’India giusto perché si trovava in minoranza.
In famiglia, soprattutto la madre, si dichiarava apertamente separatista: veniva da Fateh Kadal, un quartiere nel cuore della old town, e tutt’ora teneva nella stanzetta adibita a salotto e camera da letto per tutta la famiglia, un ritratto di Maulvi Farooq Mirwaiz, uno dei massimi leader separatisti, oltre che autorità dell’Islam sunnita. Era proprio in quella stanzetta si trovava il vecchio televisore cinese su cui avremmo seguito la partita attraverso un fitto “effetto neve”.
La partita era strutturata, come da regolamento, in due fasi. Nella prima parte della giornata aveva lanciato l’India, il che significa che si era definito il punteggio raggiunto dal Pakistan.
Nonostante un buon inizio il Pakistan era riuscito a totalizzare solo 231 runs, che non davano garanzie di vittoria. Intanto, nel corso del pomeriggio, nelle zone di Maisuma e in alcune aree della downtown, i cui negozi erano rimasti chiusi per decisione dei proprietari stessi, la gente si era radunata, nonostante il divieto imposto, per vedere la partita nei locali, la cui serranda era tenuta semi-abbassata nel caso che qualche pattuglia della CRPF (Central Reserve Police Force) o della J&K Police si fosse fatta viva.
Piccole processioni di ragazzi si erano aggirate per la città, sventolando bandiere e urlando slogan pro-pakistani. Le esplosioni dei petardi tratteggiavano lo spazio sonoro della città, silenziosa per un coprifuoco praticamente auto-imposto.
In seguito sarebbe stato riportato qualche incidente come il lancio di fuochi d’artificio e pietre ai bunker: nulla di serio comunque. Questioni conclusesi con un sano scambio di insulti.
Su Facebook impazzava intanto una guerriglia di post da parte delle due fazioni, in cui i tifosi dell’India, altrimenti invisibili nello spazio urbano, potevano dire la loro.
Umar Abdullah, il nuovo leader della National Conference, il principale partito filogovernativo, stava commentando l’andamento del match con spirito tatticamente imparziale, improntato quindi alle questioni tecniche, attraverso un susseguirsi di tweet.
Sul piano internazionale i due primi ministri di India e Pakistan, Gilani e Mohaman Singh, avevano invece deciso di recarsi a Mohali, dove si trovava lo stadio, per seguire la partita insieme. Si parlava di “Cricket Diplomacy”, di una possibilità di dialogo avviata proprio dall’evento sportivo, che aveva avuto per altro dei celebri precedenti durante gli anni 80.
Verso le sei di sera, dopo aver girato per la città per tastare l’atmosfera di frizzante tensione, decisi di recarmi da Imram, che sapevo generalmente interessato al cricket, sport che come molti altri era solito praticare a livello amatoriale nel campetto vicino casa.
Imram era solo nella sua stanza, con tutti i suoi due metri, dai piedi al naso, avvolti nel feran, il tradizionale pastrano di lana. Gli occhi, che affioravano appena sopra la serrata della cerniera, tradivano un infausto presagio. Alla radio passavano i commenti e le interviste. Imram ascoltava teso e preoccupato. Gli chiesi, cercando di spezzare l’evidente malumore, come gli sembrava che stesse andando.
Alla fine questo e solo un gioco…vince chi gioca meglio e di fatto non mi interessa. Non capisco questa gente che si agita tanto per il cricket!! E poi perché sostenere il Pakistan. Noi siamo kashmiri, non abbiamo ragione di tifare per una o l’altra squadra. Dobbiamo essere contenti del fatto che abbiamo due squadre asiatiche in finale, che abbiamo battuto l’Australia, l’Inghilterra, il Sud Africa che erano favorite in partenza. Penso che non guarderò nemmeno il secondo tempo. Fa freddo e ho un po’ di febbre. Probabilmente andrò a dormire presto.
La malinconia del suo sguardo era evidente, ma non ebbi il coraggio di infierire su una questione che sul momento mi sembrava estremamente più delicata di un lutto recente.
Arrivai a casa di Saiba per le nove. Ero stato invitato per la cena. Con me portavo una bottiglia di succo di frutta e le patatine: un magro contributo rispetto allo spessore della tragedia imminente. La madre aveva intanto preparato montone e haak, che in una famiglia con un tenore di vita decisamente basso significava celebrare un evento.
La partita era già ricominciata da un po’: la squadra indiana stava giocando piuttosto bene, qualche fuori campo, un paio di lanciatori pakistani di spessore già eliminati.
Abdul fissava lo schermo preoccupato, con una manciata di riso impastata nella mano destra sospesa nell’attesa di un momento di distensione. Mumin, il figlio più piccolo, intorno ai nove anni, cercava di far valere le sue competenze tecniche. Fino all’ultimo istante avrebbe seguitato a dire al padre che punto per punto ce la si poteva ancora fare.
Il padre, che aveva fatto i suoi calcoli, già presagiva la disfatta. La madre e la sorella minore di Saiba sembravano relativamente coinvolte, se non tramite le oscillazioni d’umore di Abdul e Adil, il figlio più grande. Saiba ancora si mostrava spudoratamente serena per l’andamento delle cose.
Ma quella sicurezza che mi aveva ostentato nei giorni precedenti relativa alla sua fede sportiva stava progressivamente cedendo a una forza misteriosa che le andava scurendo il viso illuminato dai led dello schermo. Abdul aveva riposto la fatidica manciata di riso nel piatto e chiesto bruscamente alla moglie di portarlo via. Mumin, che stava sgranocchiando le patatine percepì che non era il caso di proseguire, e me le restituì.
“Non posso guardare, non mi regge il cuore” disse Abdul, “vado a fare una passeggiata. Mumim, vieni con me!” Nella stanza eravamo rimasti io e Saiba, in un tetro silenzio, con l’euforico commentatore indiano che faceva da sfondo agli ultimi inutili brandelli di gioco. La madre lavava i piatti, gli uomini erano usciti, la sorellina era nella cucina.
La partita era finita, il Pakistan aveva perso. Saiba cercava di nascondere il suo palpabilissimo malumore, inspiegabile se messo in relazione alle dichiarazioni dei giorni precedenti. Anche lei mi disse, come da circostanza, che si trattava solo di un gioco, che gli dispiaceva per suo padre e suo fratello, e che quindi non poteva mostrarsi apertamente felice. Mi salutò sulla porta, con un sorriso stentato.
La metamorfosi di Saiba, sviluppatasi in parallelo all’andamento del match era stata sorprendente: molto più sorprendente ed inattesa di quella di Imran e di altri, i quali avevano formalmente abdicato la loro fede pakistana per una questione di opportunismo e di dignità strategica, di fatto dinamiche rinvenibili in tutte le tifoserie occasionali del globo.
Saiba, in piena adolescenza, era di fatto l’elemento ribelle della famiglia, tant’è che più volte durante il mio soggiorno a casa sua, l’anno precedente, l’avevo vista litigare sfrontatamente con il fratello maggiore e con il padre. Un paio di volte avevo notato che aveva dei lividi sul volto e dopo aver provato inutilmente a spiegarmi che era scivolata nel bagno, aveva dovuto ammettere che il fratello l’aveva picchiata. Il college che frequentava, come molti altri gestiti indirettamente dal governo, era didatticamente vicino al nazionalismo indiano.
Tutti elementi che entravano in conflitto con la tradizione famigliare, che per quanto non politicamente impegnata, rimaneva affettivamente prossima al separatismo. Lei stessa in certi momenti, in particolare durante i lunghi periodi di coprifuoco e sciopero dell’estate 2019, mi aveva chiaramente dichiarato di voler intraprendere la carriera di avvocato, e di diventare un’attivista anti-indiana.
Nonostante questa impostazione ideologica di fondo, nell’ambito del cricket Saiba aveva scelto di muoversi nello spazio dell’emancipazione relativo alle dinamiche di potere familiari.
La madre, durante la partita, si era sostanzialmente auto-emarginata, lasciando la comprensione tecnica del gioco ad Abdul ed Adil e prestandosi ad un coinvolgimento emotivo ancillare, mirato perlopiù a disperdere la tensione degli uomini. Aveva apparecchiato, sparecchiato, non si era (singolarmente) lamentata quando Abdul aveva lasciato la cena nel piatto, aveva fatto qualche domanda ingenua sull’andamento della partita e in conclusione, quando le cose erano chiaramente orientate al peggio, si era messa a lavare i piatti in cucina.
La prima scelta di carattere emancipatorio affrontata da Saiba era stata quella di riporre tutta la sua soggettività nella fruizione della partita. Ne conosceva le regole, che mi aveva spiegato scrupolosamente, conosceva i giocatori, le loro qualità, i margini di errore che ci si poteva permettere ecc. Già in questo Saiba si stava infiltrando sfrontatamente in una dimensione simbolica che sul piano formale sarebbe normalmente dovuta rimanere dominio della mascolinità.
Più di qualche volta, nel corso di conversazioni intime, mi aveva confessato la frustrazione legata al fatto di essere una ragazza in una società islamica, di non potersi muovere liberamente, di non poter nemmeno pensare di andare a studiare a Bangalore, il suo sogno difficilmente irrealizzabile.
Per svincolarsi ulteriormente dalla forza strutturante della ripartizione di gender intrinseca alle dinamiche famigliari, all’Islam ed alla tradizione kashmiri, aveva in qualche modo trovato un sostegno nel supportare l’India in ostilità aperta con il resto della famiglia, i cui membri avevano preso la cosa con una certa ironia canzonatoria. Saiba era per Adil ed Abdul quella “strana”, che doveva fare sempre il contrario di quello che facevano gli altri, che alla fine tifava Pakistan e voleva solo dare a vedere che supportava l’India.
La madre invece sembrava covare una segreta fierezza nei confronti di quella scelta, riconoscendo forse una forza che lei, per varie ragioni, non avrebbe mai espresso. Era sensazione comune a tutti il fatto che la scelta di sostenere l’India non riguardasse l’ambito della politica formale, nonostante Saiba avesse detto di non sentirsi affatto Pakistana, perché di fatto si può essere musulmani ed indiani allo stesso tempo, e che la cosa non crea nessun paradosso.
Il supportare l’India, al di là di queste razionali dichiarazioni di carattere ideologico, ricollegabili agli ideali di nazionalismo secolare impartite a scuola, rimaneva comunque circoscritta al cricket, intercettando la configurazione di forze della famiglia. Il politico tra queste due piattaforme discorsive, rimaneva un elemento strumentale, imprescindibile tramite che sarebbe riemerso attraverso una rivalsa delle emozioni e dell’affettività, con un sincero rientro nell’identità politica famigliare.
In fondo però Saiba la sua partita l’aveva vinta: aveva cioè negoziato la sua soggettività femminile sfondando in maniera relativamente diplomatica e dirompente degli argini formalmente predefiniti; aveva affrontato l’intero andamento della partita, sviluppando un’empatia crescente nei confronti del Pakistan quando questo si avviava alla sconfitta, mentre gli uomini di casa se n’erano andati per non affrontare emotivamente la questione. Tutto questo utilizzando una banale partita di cricket, le cui diramazioni ed implicazioni erano penetrate nella struttura famigliare Hangi della Bilal Colony di Srinagar. Per contro, la questione della “cricket diplomacy” dell’incontro tanto conclamato tra Gilani e Mohaman Singh, che aveva riempito le prime pagine dei giornali per diversi giorni, si risolse in chiacchiere prive di efficacia fattiva.
Mi avvia verso casa, anch’io piuttosto deluso, non saprei dire se per la sconfitta del Pakistan o per un semplice contagio emotivo. Passando davanti all’accampamento della CRPF di Bishembernagar sentii i canti, le urla, gli schiamazzi dei paramilitari indiani.
Erano ubriachi: indiani ubriachi e felici chiusi in un edificio ricoperto di rotoli di filo spinato, circondati da gente che tristemente stava elaborando le ultime analisi tecniche sulla partita, sugli errori di un Afridi (il capitano) oramai vecchio, sulla superiorità schiacciante dell’India anche sul campo da gioco. In quel momento quello mi sembrava l’osceno simbolo di un’arrogante occupazione straniera.
Il Pakistan, nonostante tutta la consapevolezza storica ed il distacco metodologico, era straordinariamente vicino. Per tutta la notte i festeggiamenti, racchiusi nelle sacche militarizzate della città avrebbero inondato il silenzio funereo della città. Ma già la mattina seguente passando davanti al medesimo campo militare avrei salutato la guardia di turno, che indossava la divisa delle grandi occasioni, congratulandomi per la splendida partita, di un gioco che mi risultava noiosissimo, e le cui regole non mi erano ancora completamente chiare. Le sue implicazioni sul piano microsociale erano molto più rivelatorie: il Pakistan era innanzitutto un’imprescindibile e potentissima emozione.
Questo brano è un estratto del libro“Linee di Controllo: genealogie, pratiche e immaginari nel separatismo kashmiri” (Meltemi 2008). Il testo, basato su una ricerca etnografica completata tra il 2008 e il 2012 è un’esplorazione degli aspetti microsociali attraverso cui il discorso separatista e il conflitto nel suo complesso si perpetuano nella valle del Kashmir.
Un reportage di al-Jazeera sulle nuove generazioni e il loro coinvolgimento nella politica in Kashmir
Clicca qui per guardare il documentario
Nella primavera del 2011 mi trovavo nella zona di Lal Chowk, lo snodo commerciale di Srinagar, nonché una delle frontiere della Down Town.
Passeggiando lungo il fiume Jelhum, in prossimità di Amira Kadal, decisi di andare a dare un’occhiata all’Hanuman Mandir, uno dei tenti templi induisti situati lungo le rive dell’ampio corso d’acqua che attraversata la città, si dirige verso Baramulla, quindi in Pakistan.
Il tempio era presidiato, come sempre, da un cospicuo numero di paramilitari che, contenti del mio arrivo, mi sorridevano incuriositi. Uno di loro, l’ufficiale responsabile, mi si avvicinò, sentendosi forse in dovere di fare gli onori di casa, per chiedermi cordialmente di dov’ero.
Nel tempio, aperto su un fianco sul fronte del Jelhum, stavano seduti a terra alcuni pellegrini e dei turisti indiani. Qualche militare si aggirava flemmatico nell’ampio atrio.
Il bramino, che non era evidentemente kashmiri, mi chiamò per segnarmi il tika sulla fronte. Si era nel frattempo accostato un piccolo uomo, quasi calvo, dagli occhi incredibilmente vispi ed intensi: “Non ti può capire, non parla inglese” mi disse.
Era Kumar, un Pandit kashmiri, o meglio l’unico Pandit con cui abbia avuto modo di stringere una relazione in questi anni. Scambiammo qualche chiacchiera di convenienza; poi, visto che gli avevo spiegato che mi sarei fermato a Srinagar per un po’ di tempo, mi scrisse il suo indirizzo su un pezzo di carta: Shiv Mandir, vicino ad Aali Kadal.
Ero quindi invitato a visitare il suo tempio. Quel pezzo di carta l’avrei conservato per qualche mese, prima di decidermi ad utilizzare questo contatto, così anomalo rispetto alle conoscenze che avevo accumulato negli anni, costituite quasi interamente da musulmani sunniti.
I Pandit kashmiri erano da secoli una minuscola minoranza all’interno della popolazione kashmiri. Fino al quattordicesimo secolo la popolazione della vallata era stata in realtà quasi interamente di religione induista, poi, in seguito all’opera missionaria dei sufi provenienti dal centro Asia, la maggioranza si era convertita all’Islam.
Solamente la casta braminica era rimasta a mantenere in vita la tradizione dello shivaismo kashmiri, una peculiare e antica diramazione della principale religione del subcontinente. Ora i Pandit erano praticamente scomparsi dalla vallata.
Con l’inizio dell’insurrezione armata dell’89 la loro presenza era diventata problematica. L’esercito indiano era stato dispiegato ovunque sul territorio, gli scontri erano all’ordine del giorno, come gli eccidi perpetrati per mano dei militari, riconducibili all’amministrazione di Jagmohan, il governatore del J&K, il quale aveva sciolto l’assemblea legislativa assumendo uno status plenipotenziario, ufficialmente nell’intento di riportare la situazione alla normalità.
Il clima era sostanzialmente quello di una guerra a pieno regime: la fase dell’iniziale euforia iniziava a calare, l’idea che l’indipendenza sarebbe arrivata in pochi giorni era completamente svanita. Tra gli episodi più tragici c’era stato il massacro di Gaw Kadal.
Il 20 gennaio 1990 si stava svolgendo una manifestazione, proprio in risposta all’assegnazione della nuova carica di governatore e alle perquisizioni a tappeto ad essa seguite. Mentre la processione stava attraversando il ponte Gaw, le truppe indiane si erano posizionate ai lati della strada ed avevano iniziato a sparare sulla folla, facendo più di cento morti. Quella di Gaw Kadal è univocamente definita come la peggiore strage perpetrata nel decennio. La natura dello scontro cambiò radicalmente a livello di intensità e di numeri. Scrive Balraj Puri :
con questo incidente la guerriglia entrò in una nuova fase. Non si trattava più di uno scontro tra militanti e forze di sicurezza. Assunse gradualmente le forme di un’insurrezione generale dell’intera popolazione.1
Ci furono quindi i primi eccidi ai danni della minoranza induista, a volte perché effettivamente si trattava di “mukbir”, di informatori delle forze di sicurezza, altre volte senza motivi specifici.
1] B. Puri, Kashmir: Insurgency and After, Delhi, Orient Blackswan, 1993, p.60
L’esodo era di lì a venire. Un passo di Curfew Night, un romanzo autobiografico scritto da un giornalista kashmiri, racconta magistralmente quei giorni del marzo 1990:
Al primo giorno di scuola come mi sedetti in classe fui colpito da alcune sedie vuote. Mi sentii un po’ confuso, incerto sul come giustificare le assenze. I miei compagni contraccambiarono con sguardi attoniti. “Se ne sono andati” disse qualcuno. Quelle parole esplosero come proiettili traccianti, illuminando i muri slavati di bianco della classe, la nuda lavagna, le superfici di legno verniciato dove quelli che erano assenti e quelli che erano presenti avevano inciso, in una suggestiva e romantica aritmetica, le loro iniziali. E i nostri sguardi rimasero per qualche istante fissi su quelle sedie vuote. Cinque dei nostri compagni Pandit non erano lì. Insieme a centinaia di musulmani pro-indiani, attivisti politici e informatori, i militanti avevano ucciso centinaia di Pandit sulla base delle stesse accuse, o senza ragione alcuna. Le morti avevano spaventato i Pandit e migliaia, compresi i miei compagni di classe e le loro famiglie, avevano lasciato la valle nel marzo 1990, verso Jammu, Delhi, e altre città indiane.1
Ci sono diverse teorie riguardo alla fuga dei Pandit, e molti Kashmiri sostengono che si sia trattata di una manovra cospiratoria di Jagmohan, che aveva ed ha tutt’ora la reputazione di essere apertamente anti-musulmano.
Questi, in qualche modo avrebbe tentato di dare un colore confessionale al conflitto e, secondo alcuni, avrebbe pianificato la partenza dei Pandit, non strettamente necessaria, nell’intento di avere mano libera in un’eventuale operazione di pulizia etnica.
Era un giorno qualsiasi del novembre 2011, non avevo particolari impegni da adempiere dopo aver lasciato la bottega, che era per altro uno dei pochi ambienti riscaldati a cui avevo accesso. Andare nella mia stanza, con i suoi 5 gradi magari resi appena accettabili dalla vicinanza di un kongri (il bracere tradizionale), non aveva troppo senso. Tirai fuori quel biglietto preservato per sei mesi nel portafoglio, oramai tagliato in quattro lungo le pieghe, e mi diressi verso Aali Kadal, distante forse una mezz’ora a piedi dal laboratorio.
Non sapevo dove si trovasse esattamente il tempio, così mi trovai a chiedere a negozianti e passanti se ne sapessero qualcosa o se si ricordassero di un Pandit di nome Kumar che abitava nella zona. Le prime tre o quattro persone mi spiegarono che lì di Pandit non ce n’erano, che se n’erano andati tutti molto tempo prima. Uno mimò sghignazzando la pressione dell’indice su un immaginario grilletto, come a chiarire la fine che avevano fatto. Trovai infine un anziano negoziante, che si ricordava del nome del tempio. Mi diede le indicazioni per raggiungerlo: si trovava a forse trecento metri di distanza. A fianco, all’inizio della scalinata che conduceva sui ghat che davano sul fiume, c’era un forno, con un paio di panettieri che fumavano il narghilè nella stanza annerita dalla fuliggine. Chiesi informazioni, nel mio kashmiri approssimativo: Kumar sarebbe rientrato dal lavoro circa un’ora più tardi.
Feci una passeggiata nei paraggi e ritornai sul posto. “É tornato” mi dissero, più distesi. “Ti sta aspettando. Puoi andare.”
Entrai attraverso il portoncino. Kumar era seduto a terra vicino alla finestra, avvolto nel suo pastrano tradizionale. Non sembrava entusiasta della mia visita, quasi come se il sospetto dei suoi vicini si fosse riversato nel suo umore, ma cordialmente mi diede il benvenuto. La stanza, che si affacciava direttamente sul Jelhum, era estremamente spartana. I muri di fango si stavano sbriciolando sotto l’usura del tempo. C’erano delle immagini di divinità induiste sulle pareti, dei testi sacri accatastati su una mensola: segni di un qualcosa di totalmente estraneo a quella che avevo mappato come “la casa kashmiri”, con le sue scritte in arabo, le immagini della Ka’ba ad indicare la direzione della preghiera. In questa configurazione di riferimenti devo dire che facevo quasi fatica a considerare Kumar un kashmiri.
Il kashmiri, com’è del resto nei discorsi della gente comune, era diventato anche per me un unicum con la categoria “musulmano”, al massimo shiita, difficilmente sikh. L’indù, colui che vive fuori dalla vallata, dopo il tunnel che conduce a Jammu, era l’indiano.
Un po’ imbarazzato mi sedetti.
– Si ricorda di me? Ci siamo incontrati all’Hanuman Mandir circa sei mesi fa…è passato un po di tempo. Mi aveva invitato a venirla a trovare. Spero di non disturbare!
– Mi ricordo. Non ti preoccupare, cos’è che vuoi?” Chiese sempre con tono più che diffidente.
-Solo fare una chiacchierata. Passavo di qui e mi sono ricordato del suo invito. Non è facile incontrare Pandit qui a Srinagar. Soprattutto nella Downtown. Ero curioso di conoscerla meglio.
-In questa zona sono l’unico rimasto, se ne sono tutti andati. Cos’è che fai qui? Sei stato molto tempo a Srinagar
Gli spiegai dapprima del mio apprendistato di intaglio, sempre rassicurante e innocuo, quindi del mio lavoro di ricerca, del fatto che comprendere il suo punto di vista sulla situazione in Kashmir mi interessava, che mi avrebbe fatto piacere, qualora possibile, scambiare qualche parola.
Mantenendo salda una certa discrezione, Kumar si iniziò faticosamente ad aprire:
Quando tutti se ne stavano andando io decisi di rimanere. I miei genitori erano morti. Era un periodo difficile. Ogni volta che uscivo di casa non sapevo se sarei tornato a casa. C’erano i guerriglieri, che in ogni momento potevano chiedermi che cosa facevo ancora lì. Potevano pensare che fossi un informatore, giustiziarmi sul posto. Ma non solo loro. Anche i militari erano sospettosi: il fatto che non me ne fossi andato significava che ero rimasto vicino alle persone di qui. Poi c’erano le dicerie della gente, che in quell’epoca stava diventando intollerante. A quel tempo ci voleva poco per essere accusato di essere un mukbir, e con tutte le armi che circolavano qualcuno alla fine mi sarebbe venuto ad ammazzare. Devo dire grazie alla gente del mio quartiere, che ha continuato a proteggermi. Quando veniva qualcuno a chiedere di me gli dicevano che mi occupavo solo del mio tempio. Non ho niente a che fare con la politica, per me c’è solo Dio. Devo ringraziare Dio.
Vedi, il problema è che la gente parla: per esempio queste persone che ti hanno visto che entravi qui… queste persone stanno già discutendo di chi tu sia, del perché sei venuto da me. E me lo verranno a chiedere. La gente è molto sospettosa, soprattutto nei confronti di chi è nella mia posizione. E sono vent’anni che combatto la mia battaglia per rimanere in pace con questa comunità, e non è facile. Devo stare attento a tutto, perché comunque sia loro sono musulmani e io induista. Molti sono analfabeti, senza istruzione, hanno questi mullah che sono l’unica autorità che conoscono e alcuni di loro sono intolleranti.
Tu sai che il kashmiri che parliamo noi Pandit è diverso da quello parlato dai musulmani, ci sono alcune parole che derivano dal sanscrito che loro hanno ripreso dal farsi. Beh, nei periodi peggiori, quando mi muovevo fuori dal mio mohalla dovevo parlare come loro, per evitare che capissero chi ero, e le questioni che ne sarebbero conseguite.
Non sono riuscito a fare troppe visite a Kumar: ho sempre percepito la responsabilità di portare involontariamente un’alterazione nel precario equilibrio del suo sistema di relazioni e quindi alla sua reputazione. Il problema me l’aveva chiarito esplicitamente. Kumar lavorava in una scuola dell’esercito, a Badgam, distante pochi chilometri da Srinagar. Nelle ore del tardo pomeriggio dava ripetizioni ai bambini del vicinato:
Non lo faccio per i soldi, che sono una miseria. Lo vedi da te che non sono ricco. Lo faccio per cercare di cambiare nel piccolo la mentalità delle persone. Se vedi qui insegno solamente a bambini fino alla sesta, massimo ottava classe. Perché dopo quell’età, mi dispiace dirlo, la loro mentalità cambia, diventano intolleranti (communal minded). Iniziano ad avere altre influenze, a chiedersi perché non sono musulmano anch’io, a non vedermi più come il loro maestro, ma come un indù.
1] B. Peer, Curfewed Nights, London, Random House Limited, 2008, p.22
Le domeniche invece, dopo essersi recato presso qualche grande tempio della valle -quei templi oramai ipermilitarizzati, in cui il bramino, quasi sempre non kashmiri, celebra la Puja per i soldati e qualche turista indiano di passaggio- si dedica a quella che lui definisce un’attività di counseling.
Donne kashmiri, musulmane vicine al sufismo, arrivano da ogni parte della vallata per chiedergli pareri e suggerimenti riguardo a problemi familiari, spirituali, psicologici e di qualsiasi natura. Lui le ascolta, sfoglia libri di astrologia legata al sistema induista, gli da delle risposte pacate e rassicuranti. Spesso gli prepara degli amuleti annodando fili di lana, un’usanza diffusa tra i pir, i guaritori spirituali di area sufi.
Una delle ultime volte che ci siamo incontrati, Kumar mi ha chiesto di cercare, se possibile, qualcuno in India che fosse disposto ad aiutarlo a mantenere lo Shiv Mandir, una vera bolla spaziotemporale nella Srinagar contemporanea. Lui, per questioni legate a una malattia, era diventato completamente sterile, e non aveva potuto metter su famiglia. Non aveva quindi una discendenza. Gli avevo proposto di metterlo in contatto con un amico che si occupava del reinserimento dei pandit in Kashmir. Lui mi ha risposto che chi cerca non può essere kashmiri:
Perché, nel momento in cui fosse un pandit emigrato la gente diventerebbe sospettosa…inizierebbero tutti a chiedersi del perché questa persona se n’era andata, perché era tornata, se c’è un piano delle agenzie indiane per modificare e controllare la situazione della downtown,e così via. Sarebbe un problema. É meglio qualcuno dello UP, del Bihar, qualche povero che abbia bisogno di vitto, alloggio e qualche soldo, e che non abbia niente a che fare con il Kashmir e la sua storia.
Quasi tutti a Srinagar negano una realtà nella vicenda dei pandit: l’implicita, silenziosa complicità della popolazione nel aver permesso la fine di un piccolo indispensabile frammento della cultura kashmiri.
C’è chi, come già detto, accusa Jagmohan, chi incolpa gli stessi pandit di aver tradito opportunisticamente la componente musulmana della società, che alla fine ha sofferto molto più di loro. Ma in questo senso uno dei pareri più espliciti e spietatamente sinceri me l’ha fornito Idris, il proprietario del laboratorio di intaglio dove mi recavo quotidianamente. Idris, ben istruito e musulmano praticante, vicino anch’egli a Jamaat, mi ha detto una volta:
Gli eccidi dei Pandit dovevano avvenire, è stata parte integrante del movimento separatista nella fase armata. Il fatto è che in massima parte i Pandit erano agenti indiani, lavoravano per i servizi segreti. Oltretutto, se hai studiato la storia del Kashmir, saprai bene che questi hanno sempre detenuto gli incarichi più importanti nell’amministrazione, nell’educazione, nel commercio, nella cultura. Ma di fatto la questione è che dovevamo liberarci di loro perché fin quando erano qui, noi musulmani non eravamo in grado di vedere il potenziale che abbiamo, oltre a non avere la possibilità di esprimerlo in ambienti come l’università per esempio. Si pensava sempre che i Pandit ci erano superiori, e che noi non eravamo in grado di stare allo stesso livello. Ma se guardi bene, chi sono stati i grandi poeti, scrittori, sovrani della storia del Kashmir? Sono tutti musulmani. Adesso finalmente abbiamo sconfitto questo complesso di inferiorità.
Con la fuga dei Pandit, i templi, principalmente sparsi lungo il fiume Jehlum sono rimasti incustoditi, oppure sono diventati dei bunker, avvolti dal filo spinato e da fitte reti per intercettare eventuali granate lanciate dai gurerriglieri.
Altri, completamente caduti in disuso dopo che i mujahideen li avevano utilizzati come nascondiglio nei primi anni ’90, sono diventati zona franca, adibiti a quelle attività considerate illecite dalla legge, o haram per il Corano e il costume locale. Le bottiglie vuote e le carte da gioco sparpagliate sul terreno segnalano l’estraneità di questi spazi al controllo sociale.
Il Ram Mandir, è per esempio un grande, splendido tempio nei pressi di Safa Kadal a cui si accede solamente scavalcando un muro. Il cortile esterno è stato adibito a discarica dal vicinato, e nel tempo si è riempito di sacchi della spazzatura, che alternativamente vengono lanciati direttamente nel fiume. Mi è capitato di andarci per respirare l’atmosfera di un’epoca non troppo lontana, ma irreversibilmente estinta.
Ogni tanto il mio arrivo inatteso ha generato fughe degli occasionali avventori: sui pavimenti in genere si trovano carte da gioco sparpagliate, qualche bottiglia di whisky, pacchetti di sigarette. Gli splendidi affreschi al suo interno sono stati vandalizzati e sulle raffigurazioni della mitologia induista sono state incisi gli acronimi di varie organizzazioni, come la JKLF, HM, Lashkar-e-Toiba, slogan come Indian Dogs Go Back, scarabocchi infantili di mitragliatrici e qualche immagine volgare.
Chiedendo spiegazioni al mio amico Majid, questi mi aveva detto: “Sono stati sicuramente dei ragazzini che durante il coprifuoco del 2010 probabilmente non sapevano dove andare. Non sanno quello che fanno, non sanno nulla della cultura pandit. Sanno solo che un tempio induista ha qualcosa a che vedere con l’India”.
Questo brano è un estratto del libro“Linee di Controllo: genealogie, pratiche e immaginari nel separatismo kashmiri” (Meltemi 2008). Il testo, basato su una ricerca etnografica completata tra il 2008 e il 2012 è un’esplorazione degli aspetti microsociali attraverso cui il discorso separatista e il conflitto nel suo complesso si perpetuano nella valle del Kashmir.