Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE
proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
10 dicembre 1948 – 10 dicembre 2018. Quando abbiamo aperto l’articolato della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che compie oggi settant’anni, siamo tornati indietro nel tempo, per poter affermare con coscienza che quelle parole furono scritte con la forza di un recente passato di morte e cadaveri e una speranza di futuro che rende quelle parole oggi ancora incredibilmente attuali.
La foto è quella di Eleanor Roosvelt che ha fra le mani un grande giornale, sono le pagine in cui è scritta la Dichiarazione, un lavoro che insieme a Roosvelt vide impegnati René Cassin, giurista e diplomatico francese, considerato il padre spirituale della Dichiarazione, il canadese John Peters Humphrey, giurista e considerato uno dei padri del sistema di tutela dei diritti umani. E ancora: l’australiano William Hogdson, il cileno Hernan Santa Cruz, il sovietico Alexander Bogomolov, il libanese Charles Habib Malik, relatore del Comitato, il cinese Peng Chun Chang e il britannico Charles Dukes.
La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:
1. Il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;
2. Gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza;
3. Gli articoli 3-11 stabiliscono altri diritti individuali;
4. Gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità;
5. Gli articoli 18-21 sanciscono le libertà fondamentali (libertà di pensiero, di opinione, di fede religiosa e di coscienza, di parola e di associazione pacifica);
6. Gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali;
7. I conclusivi articoli 28-30 definiscono aspetti generali ed ambiti in cui non possono essere applicati, in particolare che non possano essere usati contro i principi ispiratori della dichiarazione stessa.
Settant’anni dopo il mondo, la tecnologia, la società e il lavoro sono profondamente mutati. Eppure, in questo sta, come scriviamo, la drammatica contemporaneità di quell’articolato. Scorrete veloci le notizie su qualsiasi sito di informazione (informazione eh!) e purtroppo vedrete scorrere davanti a voi prima uno, poi l’altro di questi articoli che ricoprono valore universale.
I diritti sono universali, non si applicano solo ai ricchi, o ai quadranti che si ritengono portatori di civilizzazione. I diritti sono umani, là dove il concetto stesso di umanità è stato svilito fino a rappresentare un dato ininfluente, in un lungo e sanguinoso cammino che possiamo retrodatare forse proprio all’utilizzo dell’atomica statunitense sulle città giapponesi indifese. Quando cioè la guerra ha iniziato a colpire sempre di più la popolazione civile.
La guerra è la violazione più evidente di un diritto, quello alla pace, ma oggi viviamo in Italia e in Europa un vento di ingiustizie sociali che corrispondono a violazioni di diritto inserite in leggi statuali: un vero e proprio corto-circuito del progredire dell’umanità. Per questo la Dichiarazione e in ogni caso il lavoro che si può e si deve compiere a favore e in difesa dei diritti è una delle nuove frontiere che aspettano un pensiero rinnovato progressista, quando in Italia il Censis parla di sovranismo psichico e in Europa non si riesce a trovare una sponda capace di essere davvero una buona guardiana del rispetto di quei principi che hanno una instancabile sacralità congenita.
Q Code Magazine ha deciso di associare a ogni articolo della Dichiarazione una storia, o una foto, un ragionamento, una analisi, una poesia e molto altro ancora. In una narrazione collettiva che abbiamo costruito e che iniziamo a lanciare da oggi.
In neretto troverete ogni passaggio del testo ufficiale della Dichiarazione, poi il racconto di tante voci.
A tanti compagni di viaggio abbiamo chiesto quale articolo volessero raccontare, con che linguaggio. Perché volessero farlo non abbiamo avuto bisogno di chiederlo. Lo sappiamo. Oggi più che mai.
Buona lettura.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
È indubitabile l’alto impatto e la suggestione che il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riesce a suscitare in chi lo legge con attenzione e in maniera non scontata.
La libertà e l’uguaglianza per tutte le persone, la presenza contemporanea di dignità e diritti in ogni luogo e per ogni tempo…
Si tratta davvero del grande compimento della stagione delle “Dichiarazioni dei diritti” iniziata con la Rivoluzione francese. Ma sarebbe un grave errore considerarla un punto di arrivo e personalmente, come persona che cerca di considerare i diritti umani come propria bussola quotidiana, proprio l’Articolo 1 mi ha sempre suggerito invece l’idea di un primo passo che attende tutti quelli successivi. Di un percorso ancora da intraprendere e soprattutto da completare.
Sbagliano tutti coloro che considerano questo testo – votato proprio settant’anni fa – come una specie di monumento, un simulacro di belle intenzioni ma che rimane freddo e fuori dalla storia quotidiana. È in realtà uno sprone, soprattutto perché (forse per la prima volta in maniera così compiuta) parla di diritti una prospettiva eminentemente sociale e collettiva.
Non c’è più solo una rivendicazione individualista di ogni persona contro il mondo, ma una chiara consapevolezza del fatto che la dignità e diritti di ciascuno si possano realizzare solo se collettivamente si è in grado di costruire a partire dai diritti una nuova forma società. È il primo seme della pace positiva, è il primo seme di una pace vista non solo come assenza di guerra e del tuonare del cannone (non va dimenticato come il voto di Parigi avveniva pochi anni dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale) ma come compimento dei diritti umani per tutti e per ciascuno.
Per questo ognuno di noi è chiamato a realizzare il proprio passo verso il compimento dell’Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e come attivisti del disarmo umanitario (da notare questa formula e questa significativa consapevolezza che i movimenti contro le armi hanno ormai acquisito) ne abbiamo avuto prova proprio un anno fa, quando la nostra campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.
Ed allora è importante capire la portata rivoluzionaria di quelle che non sono solo parole, ma sono ormai anche un progetto politico che deve essere dichiarato se vogliamo sperare di riuscire a metterlo in pratica. Lo dicono in maniera forte le parole pronunciate da un altro Nobel per la Pace, Martin Luther King, nell’immediata vigilia della sua morte, di cui quest’anno abbiamo celebrato il 50º anniversario “Men, for years now, have been talking about war and peace. But now, no longer can they just talk about it. It is no longer a choice between violence and nonviolence in this world; it’s nonviolence or nonexistence. That is where we are today. And also in the human rights revolution…”
“Gli uomini, per lunghi anni ormai, hanno parlato di guerra e pace. Ma ora non possono più solo parlarne. Non si tratta più di una scelta tra violenza e nonviolenza in questo mondo: è nonviolenza o non esistenza. Ecco a che punto siamo oggi. E anche nella rivoluzione dei diritti umani… “
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Non ci si è ancora ripresi dall’enormità dell’enunciazione del primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, cioè l’idea di diritti fondamentali di uguaglianza, libertà e la dignità che spettano a tutti gli individui sin dalla loro nascita, che si passa subito ad un principio egualmente straordinario dei diritti dell’uomo: la loro universalità.
Il secondo articolo della Dichiarazione enuncia infatti che diritti umani enunciati nella Dichiarazione Universale – quel bagaglio
di principi unici e assoluti che governano tutti gli esseri umani nel tempo e nello spazio – spettano a tutti, senza possibilità di deroga, discriminazioni o eccezioni: se gli esseri umani sono nati eguali e liberi, in sostanza, vuol dire che tutti hanno gli stessi diritti. Uomini, donne, giovani e anziani, ricchi e poveri, non importa la loro – la nostra – razza, origine, appartenenza culturale, religiosa, sociale, politica, identità biologica o di genere, colore della pelle, o altre differenze.
Siamo tutti uguali, ergo abbiamo tutti gli stessi diritti.
L’universalità dei diritti umani è una dichiarazione poderosa. Da un punto di vista giuridico, l’articolo enuncia un principio che si applica ai singoli come alle comunità, e che aprirà la strada alle successive fasi di legiferazione e specificazione dei diritti civili, politici, sociali economici e culturali, soprattutto con riguardo agli obblighi specifici per gli Stati. Infatti, anche nelle due grandi Convenzioni per i Diritti Umani successive – che insieme alla Dichiarazione Universale costituiscono il “International Bill of Human Rights”, la Convenzione Internazionale per Diritti Civili e Politici (ICCPR, entrata in vigore nel 1976) e la Convenzione Internazionale per i Diritti Sociali, Economici e Sociali (ICESCR, 1976), gli articoli 2 sono a tutela del principio di non discriminazione, rispettivamente nei commi 2.1 e 2.2. Da questo principio derivano, inoltre, Convenzioni che mirano a proteggere categorie specifiche, considerate più “vulnerabili”, da tali discriminazioni. Le più conosciute sono la Convenzione contro l’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale (ICERD, entrata in vigore nel 1969), la Convenzione contro l’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW, 1981), la Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità (2008).
La Protezione
Se la Dichiarazione Universale è considerata diritto internazionale consuetudinario, secondo il Comitato dei Diritti Umani nel suo “Commento Generale n. 18”, il principio di non-discriminazione costituisce “un principio generale di base per la protezione dei diritti umani”.
Comprendere cosa ostacola l’accesso a, o l’esercizio di, un diritto fondamentale è l’esercizio primario da fare per “proteggere” i diritti di tutti.
Secondo lo stesso Comitato, il termine “discriminazione” deve essere inteso per “comprendere ogni distinzione, esclusione o preferenza usata sulla base di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro, origine sociale o nazionale, proprietà, nascita o altri status, che abbia l’effetto di annullare o inficiare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio di tutti gli individui, in maniera equa, di tutti i diritti e di tutte le libertà”. Quando qualcuno non riesce a godere – o non le/gli è riconosciuto
l’esercizio – di un diritto, la domanda da farsi è: quali sono gli ostacoli?
La protezione dei diritti umani, ovvero fare in modo che tutti possiamo avere i nostri diritti riconosciuti, possiamo goderne ed esercitarli, è l’esercizio, cioè il lavoro, che fanno le agenzie delle Nazioni Unite, ma anche i nostri legislatori. E soprattutto, è un compito di tutti, oltre che un nostro diritto.
L’Equità
Secondo il Comitato però, il godimento dei diritti e delle libertà in maniera equa non significa necessariamente che gli individui siano trattati in maniera identica in ogni situazione. Siamo tutti uguali, sì, ma siamo anche tutti diversi, perché ognuno di noi ha le proprie specificità. Per non essere discriminati, bisogna fare in modo che tutti accediamo, “on equal footing”, cioè in maniera eguale, all’esercizio dei propri diritti, ognuno secondo i propri bisogni e le proprie necessità. Anche questo è un compito di tutti,
di chi legifera e di chi mette in piedi meccanismi di welfare sociale, di chi insegna nelle scuole e di chi disegna le strisce pedonali.
Garantire l’equità dei diritti significa infatti non solo trattare tutte e tutti allo stesso modo, ma fare in modo che tutte e tutti possano accedere ai loro diritti, dalla vita, all’istruzione, alla salute, all’acqua, al cibo, e così via per tutti gli articoli della Dichiarazione che seguiranno dopo questo.
I diritti sono per tutti/2
Il passo compiuto nel 1948 è sicuramente un grande passo per l’umanità. Sono trascorsi solo settanta anni, eppure mai come ora, nonostante il principio di non discriminazione ormai ci sembri assodato e irrinunciabile, c’è un gran bisogno di assicurarci che sia rispettato.
La discriminazione assume molte, infinite forme: da una legge iniqua, ad una parola sbagliata messa in una frase, ad un comportamento nell’autobus, e di lì fino ad un sistema di oppressione, magari militare, magari civile, contro altri individui.
Di discriminazione siamo circondati, e contro tutte le forme di discriminazione ci dobbiamo sempre battere. Perché i diritti sono inalienabili e universali, ma chi ha più difficoltà ad esercitarli ha bisogno dell’aiuto di chi queste difficoltà non le ha. Perché la discriminazione di genere, per citarne una di tante, appartiene alla stessa forma di esercizio iniquo ed arbitrario del potere che discrimina le razze e le minoranze, negando loro l’accesso e l’esercizio dei loro – dei nostri – diritti fondamentali, e la lotta contro tutte le forme di discriminazione assume perciò una valenza universale.
Se è vero che, come aveva considerato l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel Preambolo della Dichiarazione Universale, “il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità”, noi abbiamo il compito imperativo di portare avanti questo messaggio e di difendere la nostra coscienza umana attraverso un continuo lavoro di “protezione”, di riconoscimento di tutte le identità, singole e comunitarie, della loro uguaglianza, della loro e della nostra universalità, attraverso un’incessabile e instancabile battaglia per i diritti di tutti.
*Questo articolo rispetta il pensiero dell’autrice espresso a titolo personale
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona
La canzone è Srinivas di Marc Ribot, cantata da Mark Ribot e Steve Earle, e racconta la storia di un hate crime verso un ingegnere indiano ucciso in un bar in Texas.
Un esempio dell’America trumpiana e di quello che rischiamo anche noi se non contrastiamo l’hate speech che dilaga. Dice mad man pulled the trigger, Donald Trump loaded the gun…..
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Un tempo, questo edificio – oggi musealizzato – era il mercado de escravos, il mercato degli schiavi. Era posto appena al di fuori delle antiche mura della piccola cittadina portuale di Lagos, ora nota località turistica dell’Algarve, nel sud del Portogallo.
A partire dal XV secolo, Lagos è stato uno dei maggiori centri della tratta degli schiavi, che prelevati dall’Africa venivano portati in Europa per poi essere venduti.
È qui che si ritiene si sia svolta la prima vendita di schiavi della storia moderna europea. Era l’8 agosto 1443. A essere vendute furono 235 persone.
Il cronista portoghese di corte Gomes Eanes de Zurara assistette all’evento, che così descrive:
*«Al mattino presto, quando il vento era calmo, i pescatori cominciavano a preparare le loro barche, a prendere i prigionieri e a portarli dove gli veniva ordinato. Alcuni avevano la testa bassa e i volti solcati dalle lacrime, si guardavano tra loro; altri piangevano di dolore e alzavano la testa al cielo (…); alcuni si battevano il volto con le palme delle mani e si buttavano a terra; altri ancora intonavano dei canti di lamentela come usavano fare nelle loro terre d’origine.
Poi arrivavano coloro che erano incaricati di dividere gli schiavi e iniziavano a separarli (…). Un lavoro senz’altro faticoso. Separavano i bambini dai genitori, mettendo i bambini da una parte e i genitori dall’altra, coi bambini che cercavano disperatamente di tornare dai loro genitori; le madri cercavano di tenere i bambini stretti nelle loro braccia e si gettavano a terra ferendosi, senza badare alla loro sicurezza, per evitare che i loro bambini venissero presi. E così compivano il faticoso lavoro di separare gli schiavi»
*[Brano tratto da Crònica dos Feitos da Guiné, di Gomes Eanes de Zurara, 1452-1453, capitolo XXV]
Oggi la schiavitù è vietata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da tanti altri strumenti giuridici. Eppure, il fenomeno non solo esiste ancora, ma è persino aumentato. Si parla di forme di “schiavitù moderna”. Nel mondo, almeno 40,3 milioni di persone ne sono vittime. Il dato è stato diffuso dall’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) lo scorso 2 dicembre, in occasione della Giornata mondiale per l’abolizione della schiavitù. Vi rientrano le vittime di pratiche come il lavoro forzato (24,9 milioni di persone), i matrimoni obbligati (15,4 milioni di persone) e il traffico di esseri umani. Il dato si gonfia, però – ricorda l’agenzia ONU – se consideriamo le 16 milioni di persone che vengono sfruttate in alcuni settori privati, come i lavoratori domestici, i braccianti agricoli e gli operai.
Gli schiavi di oggi sono i migranti.
Secondo uno dei massimi esperti in materia, il prof. Kevin Bales, il 10% degli schiavi è un migrante, e la percentuale arriva al 75% nei paesi industrializzati e nel Medio Oriente.
«Lavorano in cambio di niente; vengono sfruttati sessualmente, o come forza lavoro, o come manodopera per la criminalità, o per i loro organi. La loro libertà, i loro diritti, le loro scelte, vengono portate via, e loro diventano un mezzo per fare soldi. Schiavi moderni possono essere le donne di servizio nelle residenze più facoltose; i ragazzi che vi lavano la macchina e quelli che vi dipingono casa; chi raccoglie pomodori nei campi e chi vi fa la manicure. Il filo rosso è che si tratta sempre di lavori poco specializzati e poco pagati».
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
« La sofferenza e il dolore dell’esilio non li avrei sicuramente subiti se avessi potuto vivere in libertà nel mio paese.»
(Dalla lettera scritta da Reinaldo Arenas, prima di suicidarsi)
Prima che sia notte è l’autobiografia di Reinaldo Arenas, poeta e scrittore cubano. Nato in un villaggio di campagna, Arenas cresce nella povertà e appoggia fin da giovane la rivoluzione comunista. Ne prenderà in seguito le distanze, contestando pubblicamente la repressione praticata dal regime nei confronti degli oppositori.
Lo scrittore pagherà questa presa di posizione con la censura delle sue opere e con periodi di internamento nei campi di lavoro per antirivoluzionari e omosessuali.
Nel 1973, viene incarcerato e torturato a causa della sua omossesualità dichiarata. “Gli omosessuali, non erano trattati come esseri umani, ma come del bestiame (…) per il minimo peccato venivano crudelmente picchiati” racconta Arenas. Commovente è la scena in cui ci descrive le sue notti, trascorse in prigione con L’Illiade tra le braccia, respirando il profumo delle sue pagine.
Forse, un disperato tentativo di superare la situazione disumanizzante e di degrado profondo vissuto. Le parole scelte per descrivere la permanenza nella prigione del Morro e in seguito a Villa Marista, carcere dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale, trasmettono con precisione chirurgica il senso di annientamento dell’individuo.
Un luogotenente, che si era presentato con il nome di Gamboa inizio il suo interrogatorio chiedendomi se sapevo dove fossi ; risposi di si, ero all’Agenzia per la sicurezza Nazionale. Mi disse in seguito : “Sai cosa significa ? Significa che possiamo farti sparire, possiamo annientarti e nessuno lo saprà. Tutti ti credono al Morro, dove è molto facile morire accoltellati, ad esempio”.
Dopo numerose angherie e trattamenti degradanti, Arenas tenta il suicidio. Nel 1980, quando Castro autorizza l’esodo di massa dei dissidenti, lascia Cuba e si trasferisce a New York. Malato di Aids, il “figlio e vittima” della rivoluzione, si suicida nel 1990.
Il libro si inserisce in un’ampia riflessione sull’atteggiamento dei regimi non democratici, che soffoca e schiaccia gli individui, sottoponendoli a trattamenti degradanti, in una sorta di girone infernale, fatto di orrore e miseria umana. Ma il libro esprime con forza anche la volontà di un uomo che decide di resistere, nonostante la consapevolezza di un dolore inevitabile, come quello dell’esilio ; un uomo che non si spezza, mantenendo salde le proprie idee.
“Circondato da spie, vidi fuggire la mia giovinezza senza essere mai stato una persona libera. La mia infanzia e adolescenza erano state sotto la dittatura di Batista e il resto della mia vita sotto la dittatura ancora più implacabile di Fidel Castro. Non ero mai stato un vero essere umano nel pieno senso della parola.”
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Nessuno è sconosciuto al diritto, è scritto così, me l’hanno spiegato.
Nessuno è sconosciuto, ci sono diritti naturali che vengono prima dei diritti positivi. C’è una soggettività che è universale, non solo statuale.
Nessuno è sconosciuto, in ogni luogo, è scritto. Sei sconosciuto, ci dicono in troppi luoghi.
Quanto sono stretti gli ambienti in cui ci troviamo oggi? Quanto restringiamo i nostri diritti – nostri di tutti – quando non riconosciamo l’esistenza di un diritto universale?
Dov’è ogni individuo che, in ogni luogo, si sente soggetto del diritto, quello del riconoscimento della propria personalità giuridica in quanto essere umano, e riconosce quel diritto anche agli altri, a tutti gli altri?
Io me lo ricordo, quel 10 dicembre del 1948. Anche se ero piccolo me lo ricordo. Eravamo attaccati alla radio ad ascoltare i discorsi subito dopo l’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani: non mi ricordo chi parlava ma erano discorsi belli, eravamo d’accordo. Mio padre sorrideva e noi ci sentivamo sicuri. Sicuri non come si intende ora. Sicuri perché sentivamo di avere il diritto di esistere.
Perché oggi ci fanno sentire sconosciuti?
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Nel 2013 Kanchana aveva solo 19 anni quando è stata violentata. L’uomo che ha abusato ripetutamente di lei vive a poca distanza da casa sua, nello stesso villaggio.
Eppure Kanchana (nome di fantasia) non ha mai denunciato la violenza subita: solo quando è giunta al quinto mese di gravidanza la sua famiglia ha scoperto quello che le era successo.
Non ha potuto farlo perché Kanchana è una giovane donna indiana con una disabilità intellettiva: non era a conoscenza del fatto di poter denunciare l’uomo che abusava di lei.
La sua condizione ha reso difficile – per lei e per tutta la sua famiglia – spiegare alla polizia quello che era successo.
Anche il processo è stato complicato: Kanchana e sua madre Diya hanno partecipato a cinque udienze in tribunale. Ma le diverse fasi del procedimento non erano state spiegate adeguatamente alla ragazza che, in alcune occasioni ha vissuto veri e propri traumi.
Ad esempio quando la polizia le ha chiesto di entrare nella cabina dei testimoni la ragazza ha iniziato a urlare terrorizzata: “Non poteva capire, credeva che la stessero per portarla in prigione”, ha spiegato la donna. Nel 2014, la Kanchana ha presentato domanda di risarcimento: il caso si è chiuso nel 2016, ma a metà 2018 la sua pratica era ancora sospesa.
La vicenda di questa giovane donna è stata raccolta da Human Rights Watch che, in un recente report, denuncia le difficoltà che le donne e le ragazze con disabilità vittime di violenza devono ancora affrontare per avere accesso alla giustizia.
“Dal 2013 il governo indiano ha implementato importanti riforme sul tema delle violenze sessuali”, ha spiegato Nidhi Goyal, attivista con disabilità e co-autore del rapporto. Una situazione da cui sono escluse donne e ragazze con disabilità per le quali le difficoltà restano -spesso- insormontabili. E rischiano così di restare vittime invisibili.
Per queste donne e ragazze l’accesso alla giustizia è particolarmente difficile a causa di un doppio stigma correlato al loro genere e alla disabilità. Di conseguenza: spesso non ricevono un adeguato supporto durante i diversi passaggi del processo: dalla fase della denuncia alla polizia, all’accesso ad adeguate cure mediche, fino all’interno del complesso meccanismo della giustizia.
Di fronte a vicende come queste risuona con ancora maggiore forza il richiamo dell’articolo 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che ribadisce: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.
Un richiamo fatto proprio dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che, all’articolo 13, ribadisce: “Gli Stati Parti assicureranno l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell’età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari”.
A livello globale le donne con disabilità sono circa 600 milioni (49 milioni in Europa). A milioni di loro continua a essere negato il diritto di accedere alla giustizia: “Sappiamo molto bene cosa significa veder violati i nostri diritti e vedere quanto poco o nulla viene fatto per proteggere i nostri diritti”, ha commentato Ana Peláez Narváez, vice presidente dell’European disability forum in occasione della giornata mondiale per l’eradicazione della violenza contro le donne.
Sono tante le barriere che ancora oggi (anche in Europa) molte persone con disabilità devono affrontare per avere accesso alla giustizia. Persino il semplice fatto di arrivare davanti a un giudice può essere considerato un grande traguardo dal momento che il sistema giudiziario tende generalmente a non avere fiducia nelle loro testimonianze, soprattutto se la donna ha una disabilità
intellettuale o psicosociale, o è sordocieca.
Bisogna poi fare i conti con gli ostacoli fisici (dalle barriere architettoniche nei tribunali alla mancanza di ausili che permettono di comunicare), con quelli economici (mancanza di risorse finanziarie per affrontare una causa) e con la mancanza di consapevolezza, da parte di molte donne con disabilità, dei propri diritti. E della possibilità di esigerne il rispetto.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Signori della Corte marziale, sarò breve. Non vi annoierò. Non insisterò nemmeno sull’interrogatorio infame che ho subito: ciò che ho già detto su quello mi basta.
Prima di esaminare le imputazioni che mi vengono mosse, preferisco insistere su un altro aspetto della vergognosa istruttoria che mi riguarda: il vostro tentativo di sostenere l’accusa con false prove, elementi non veri, testimonianze precostituite o imposte ai testimoni di entrambe le parti.
Questa mia apologia infatti non vuole essere un’autodifesa, e non lo sarà. Vuole essere piuttosto una requisitoria, e lo sarà: partendo proprio dal falso documento che mi viene attribuito e che è stato il filo conduttore dell’intero processo. Documento importante, a mio avviso, perché tipico di tutti i processi che si svolgono nei paesi dove la legge viene uccisa insieme alla libertà.
Non siete soli in questa ignominia, no. Sicuramente, mentre vi parlo, patrioti di altri paesi senza legge e senza libertà vengono giudicati da una Corte marziale asservita a un regime tirannico e condannati sulle basi di false prove, elementi non veri, testimonianze precostituite o imposte ai testimoni, confessioni simili alla confessione che io non ho mai reso e mai firmato: come dimostra il fatto che essa non porta la mia firma bensì quella di due aguzzini che si chiamano Hazizikis e Teofilojannacos.
Aguzzini privi di rispetto per la grammatica, oltretutto. Stanotte ho potuto leggere quei fogli, infine, e sarebbe difficile dire se ho rabbrividito di più per le menzogne o per gli errori sfondoni grammaticali che essi contengono. Se li avessi visti prima, vi assicuro, anche in stato di coma avrei suggerito qualche correzione. Ahimè, di quali analfabeti dispone questo regime!
Si direbbe che l’ignoranza vada di pari passo con la crudeltà.
Ebbene, signori della Corte marziale, voi sapete benissimo che servirsi di un documento falso è inaccettabile sia da un lato morale che da un lato legale. E poiché questo processo era stato costruito su tale documento, io avrei avuto il diritto di invalidarlo. Non l’ho invalidato perché non volevo indurvi a credere che avessi paura di affrontare l’accusa. Chiaro che accetto l’accusa. Non l’ho mai respinta, io. Né durante l’interrogatorio né dinanzi a voi.
E ora ripeto con orgoglio: sì, ho sistemato io gli esplosivi, ho fatto saltare io le due mine.Ciò allo scopo di uccidere colui che chiamate presidente. E mi dolgo soltanto di non esser riuscito ad ucciderlo. Da tre mesi quella è la mia pena più grande, da tre mesi mi chiedo con dolore dove ho sbagliato e darei l’anima per tornare indietro, riuscirvi.
Quindi non è l’accusa in sé che provoca la mia indignazione: è il fatto che attraverso quei fogli si tenti di infangarmi dichiarando che sarei stato io a coinvolgere gli altri imputati, a fare i nomi che sono stati pronunciati in quest’aula. Ad esempio il nome del ministro cipriota Policarpo Gheorgazis. L’infamia sta qui, ed anche la sua tipicità. Per rafforzarla i miei accusatori hanno perfino detto che la mia fedina penale era sporca, che io ero un teddy boy da ragazzo, un malvivente da adulto, un ladrone e un mercenario. La mia fedina penale è dinanzi a voi, signori della Corte marziale, e potete controllare su quella che io non fui mai un teddy boy, né un malvivente né un ladrone né un mercenario.
Fui sempre, e sono, un combattente che lotta per una Grecia migliore, un domani migliore, una società insomma che creda nell’Uomo.
Se io mi trovo qui è perché credo nell’Uomo. E credere nell’Uomo significa credere nella sua libertà. Libertà di pensiero, di parola, di critica, di opposizione: tutto ciò che il golpe fascista di Papadopulos ha eliminato un anno fa.
Ed eccoci alla prima accusa che mi viene mossa. La prima accusa, anche in ordine di importanza, è tentata sovversione dello Stato: articolo 509 del Codice Penale. E non è paradossale che a muoverla contro di me siano proprio coloro che il 21 aprile 1967 infransero l’articolo 509?
Chi dovrebbe stare dunque in questa gabbia? Io o loro? Qualsiasi cittadino con un po’ di cervello e un po’ di coglioni vi risponderebbe: loro. E aggiungerebbe ciò che ora aggiungo: diventando un fuorilegge, rifiutandomi di riconoscere l’autorità del tiranno, io ho rispettato e non offeso l’articolo 509. Ma non m’illudo d’esser compreso da voi su tale punto perché, se il golpe fosse fallito, anche voi sareste in questa gabbia, signori della Corte: non solo i capi della Giunta.
Perciò non dico altro, su questo, e passo alla seconda accusa: diserzione. E vero: ho disertato. Qualche giorno dopo il golpe ho abbandonato la mia unità e sono andato all’estero con un passaporto falso. Avrei dovuto farlo lo stesso giorno del golpe, non dopo. Ma in quel senso devo essere assolto: il giorno del golpe la situazione era assai tesa con la Turchia e, se fosse scoppiata la guerra, il mio dovere di greco sarebbe stato combattere e non disertare. Proprio perché la guerra non scoppiò mi affrettai a compiere l’altro dovere: disertare. Signori della Corte, servire l’esercito di una dittatura, sì che sarebbe stato un tradimento.
Scelsi d’essere disertore, dunque, sono fiero della mia scelta, e detto ciò eccoci all’accusa che a voi preme di più: tentato omicidio del capo di Stato. Incomincerò affermando che contrariamente alle ciance narrate dai miei aguzzini, io non amo la violenza. La odio. Non mi piace nemmeno l’assassinio politico. Quando esso avviene in un paese dove esiste un libero Parlamento e ai cittadini è data la libertà di esprimersi, di opporsi, di pensare in maniera diversa, io lo condanno con disgusto e con ira. Ma quando un governo si impone con la violenza e con la violenza impedisce ai cittadini di esprimersi, di opporsi, addirittura di pensare, allora ricorrere alla violenza è una necessità. Anzi un imperativo.
Gesù Cristo e Gandhi ve lo spiegherebbero meglio di me. Non c’è altra via, e che io non vi sia riuscito non conta. Altri seguiranno. E riusciranno. Preparatevi e tremate.
No, signor presidente, non mi interrompa: la prego. Sto arrivando alla terza accusa e presto potrà gridare ai quattro venti che la sua uniforme non trema. Terza accusa: possesso di esplosivi. Che altro posso dire oltre a ciò che vi ho già detto?
Ho spiegato che solo due dei miei coimputati sapevano che mi accingevo a fare un attentato, ma non sapevano quale attentato. Mi sono assunto la responsabilità anche delle due bombe scoppiate la stessa mattina al parco e allo stadio. Ho chiarito che esse avevano soltanto uno scopo dimostrativo, di ammonimento, che per questo erano state fatte esplodere in modo da non provocare vittime tra la popolazione.
Se i miei coimputati hanno detto cose diverse nei documenti che hanno firmato, non conta. Si tratta di documenti estorti con le torture, se io torturassi Hazizikis e Teofilojannacos gli farei dire perfino che la loro mamma è una prostituta e loro padre un frocio.
E suppongo che a sistemi simili si debba la calunnia che riguarda Policarpo Gheorgazis. Lo so, Papadopulos darebbe molto perché la calunnia fosse una verità. Joannidis lo stesso. Così avrebbero il pretesto per invadere Cipro, stroncarne l’indipendenza come qui hanno stroncato la democrazia. Ma devono rassegnarsi entrambi: nessun uomo politico straniero è implicato nella lotta che rappresento. Essa avviene qui in patria, signori, non all’estero: a ragione il mio gruppo si chiama Resistenza Greca. E se Policarpo Gheorgazis lavorasse per Resistenza Greca, per me, sarebbe la prima volta che un semplice soldato chiama alle armi un ministro della Difesa. Ma allora, obietterete, da dove veniva questo esplosivo? Signori della Corte marziale, non ve lo dirò. Non l’ho confessato sotto le sevizie più atroci, vi aspettate forse che lo confessi in un’apologia? Quel segreto morirà con me. E con ciò ho finito.
Mi resta solo da aggiungere una cosa personale. Se volete, un piccolo atto di orgoglio personale. I vostri testimoni hanno detto che io sono un uomo egoista. Ebbene, se lo fossi, se lo fossi stato, sarei rimasto tranquillamente all’estero. Invece dall’estero sono tornato a rischiare e a lottare. Conoscevo i pericoli che mi attendevano. Proprio come, ora, conosco la pena che mi infliggerete. Io lo so, infatti, che mi condannerete a morte.
Ma non mi tiro indietro, signori della Corte marziale. E anzi accetto fin d’ora questa condanna. Perché il canto del cigno di un vero combattente è il rantolo che egli emette colpito dal plotone di esecuzione di una tirannia.

Alekos Panagulis
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Perseguitato, come un personaggio di Kafka, da una colpa ignota e incancellabile, il poeta latino Ovidio vive il lungo esilio che lo terrà lontano da Roma per il resto della sua vita, nel remoto villaggio di Tomi, sulla costa del Mar Nero.
Qui non gli resta che scrivere versi e pensieri tristissimi, struggendosi nel ricordo del successo mondano e di una vita trascorsa a tu per tu con i potenti.
È il romanzo Dio è nato in esilio, del rumeno Vintilă Horia. Scritto in francese, vinse il premio Goncourt nel 1960, ma l’autore dovette rifiutarlo in seguito alla polemica che ne scaturì. Emerse infatti che lo scrittore era profondamente compromesso con il precedente regime fascista e si trovava in Francia per evitare la condanna a morte decretata dal nuovo regime filosovietico.
Come l’antico romano, anche il rumeno contemporaneo aveva duettato con il potere arbitrario della detenzione e dell’esilio prima di esserne vittima, ma immaginò per Ovidio una lenta, miracolosa rivelazione.
Lì agli estremi confini dell’unica civiltà possibile, scopre popoli barbari come i Geti, i quali, simili alla donna che gli viene a rassettare la casa, «non conoscono la raffinatezza del sorriso e vivono tra i due rozzi estremi dell’austerità e dell’allegria chiassosa», e che addirittura, da un mitico schiavo di Pitagora di nome Zalmoxis, avrebbero ereditato l’idea della metempsicosi.
Insomma genti che credono ancora nelle metamorfosi come essenza fuggevole del mondo e non solo raffinato gioco letterario, e che hanno la libertà di scegliersi un unico dio capace di «colmare con la sua persona tutto un cielo».
E tutto ciò proprio negli anni in cui giunge notizia della nascita di un dio bambino nel territorio d’Israele. Vagheggiamento mistico di un cristiano post-fascista? Forse. Però non siamo lontanissimi dalle posizioni che un Pasolini esprimeva nel prologo di un film come Medea (nota: proprio a Tomi, secondo il mito, Medea avrebbe fatto a pezzi il fratello, per evitare che il padre, impegnato a raccoglierne i brandelli, continuasse a inseguire la maga nella sua fuga con Giasone).
Resta comunque una lezione sulla lontananza forzata e sulla frontiera come luogo brulicante «di razze, di popoli, di tribù che si precipitavano verso le nostre terre coltivate»; dove la barbarie è ottimisticamente vista come seme di una nuova Roma possibile, una città che «senza i giochi del circo, senza imperatori avrebbe conquistato il mondo in maniera del tutto diversa e la pena dell’esilio sarebbe rimasta sconosciuta»
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Notti, tante notti senza vedere il firmamento.
Sarà pieno di stelle, penso,
e la luna starà inondando la terra con la sua luce.
Per 6 anni, 9 mesi e 24 giorni gli occhi di David non hanno potuto vedere le stelle. Rinchiusi tra le quattro pareti di una cella, i suoi occhi potevano solo inseguire il movimento rapido dei ragni, perdersi nella simmetria delle loro tele, immaginare mondi lontani oltre le crepe sottili del muro.
Soltanto una volta al giorno, durante l’ora d’aria, David poteva respirare un po’ di luce. E sognare una finestra di libertà, facendo scorrere lo sguardo lungo lo stretto quadrato di cielo delimitato dal filo spinato. Un’ora per lasciarsi trasportare dal naufragare lento delle nuvole, aggrapparsi a quelle zattere del cielo, e navigare lontano da Bogotà, verso nord, fino ad attraccare nella sua città natale, Barrancabermeja.
Immagino le nuvole che vagano,
le immagino visitare le stelle e abbracciare la loro luce,
e penso alla donna che amo:
come sarà l’immensità?
Gli agenti di polizia arrivarono a casa di David Ravelo Crespo il pomeriggio del 14 settembre 2010. Lo arrestarono, lo scortarono su un volo verso Bogotà, e dopo un primo interrogatorio con l’unità anti-terrorismo lo trasferirono alla prigione della Picota.
David avrebbe trascorso in carcere sette lunghi, lunghissimi anni. Sette anni di false testimonianze, di giudici corrotti, di ricorsi negati. Sette anni dietro le sbarre, costretto a vedere la parola giustizia calpestata, ferita, svuotata di senso.
Al momento dell’arresto, David faceva parte del Consiglio direttivo di CREDHOS, organizzazione che dal 1987 denuncia le violazioni dei diritti umani nella regione di Magdalena Medio, dipartimento di Antioquia. Gli attivisti di CREDHOS documentano i crimini, accompagnano le vittime, e lottano in prima linea contro violenze e ingiustizie perpetrate da paramilitari, gruppi armati, forze di sicurezza e politici.
Nel 2017, David pubblicò un video che mostrava un incontro segreto tra l’allora presidente Alvaro Uribe e un gruppo di paramilitari di Barrancabermeja. Da quel momento, si intensificarono le minacce e gli attacchi, non solo contro David ma anche nei confronti dei suoi amici, colleghi e familiari. L’attivista rischiò più volte di essere assassinato, e i paramilitari – con la complicità di chi al governo li proteggeva – cercavano in ogni modo di incastrarlo per sbarazzarsi di lui.
Ho vissuto sull’orlo della morte,
solo per i miei pensieri differenti.
Sono vivo per miracolo e per pura fortuna,
non sono riusciti ad assassinarmi,
per questo con false testimonianze
mi hanno incarcerato.
David fu arrestato con accuse gravissime, e completamente infondate. L’unità anti-terrorismo aveva aperto un’indagine per il suo presunto coinvolgimento nell’omicidio di David Nuñez Cala, Segretario dei Servizi Pubblici a Barrancabermeja e candidato sindaco che fu assassinato nel 1991.
Contro David avevano testimoniato Mario Jaimes Mejía e Fremio Sánchez , due paramilitari del gruppo Autodefensas Unidas de Santander y Cesar. All’epoca i due erano in carcere, condannati per una serie di omicidi compiuti a Barrancabermeja alla fine degli anni Novanta. David e la sua organizzazione, CREDHOS, avevano raccolto documentazione e testimonianze proprio sulle stragi di cui erano responsabili. Paradossalmente, però, i paramilitari potevano chiedere una riduzione della pena rivolgendo accuse contro David: secondo la legge di Giustizia e Pace del 2005, chi confessa crimini e collabora nelle indagini facendo i nomi di altre persone coinvolte può infatti avere dei benefici.
Mejia – noto come El Panadero – fu successivamente condannato anche per essere stato complice del sequestro e dello stupro della giornalista investigativa Jineth Bedoya, e per aver testimoniato il falso in un altro processo. Ciò nonostante, la sua testimonianza non fu mai messa in dubbio.
Il pubblico ministero che aprì le indagini contro David era l’ex-tenente William Gildardo Pacheco Granados. Nel 1993, Pacheco fu destituito dalla Polizia Nazionale, con l’accusa di essere coinvolto nella sparizione forzata di Guillermo Hurtado, un testimone chiave che aveva visto dei poliziotti uccidere un civile. La legge colombiana vieta a chi sia stato rimosso da un incarico pubblico di lavorare in tribunale, ma a Pacheco fu comunque consentito di seguire il caso di David.
Durante le udienze, il pubblico ministero Pacheco accettò solo le testimonianze dei paramilitari. Furono invece ignorate le dichiarazioni di oltre 30 cittadini di Barrancabermeja – tutte persone riconosciute e rispettate – che sostenevano l’assoluta innocenza di David.
Inoltre, un’altra persona accusata nel caso – Orlando Noguera – denunciò che durante l’udienza preliminare i due paramilitari cercarono di corromperlo. Gli fu chiesto esplicitamente di accusare David: in cambio, gli fu promesso uno sconto della pena.
Nel dicembre 2012, David fu condannato a 220 mesi di carcere per omicidio aggravato. Riconquisterà la libertà – condizionale – dopo 81 mesi, il 20 giugno 2017.
Per sette anni, nella penombra del carcere, David leggeva libri di poesie, di letteratura, di economia, di storia, di scienza, di diritto. A un anno dalla sua liberazione, nomina Victor Hugo, Antonio Machado e Albert Einstein come fossero stati i suoi compagni di cella. Cita i loro scritti a memoria, la loro voce è la sua.
“Come scriveva Victor Hugo, il futuro ha molti nomi. Per i deboli, è l’irraggiungibile. Per i paurosi, l’ignoto. Per i coraggiosi, un’opportunità. E per me, per noi difensori dei diritti umani, il futuro è sempre un’opportunità: nel mezzo della tempesta, nel mezzo delle avversità, continuiamo ad affrontare tutto con dignità”, dice David, con la voce ferma e sicura di chi ormai ne ha passate troppe per lasciarsi spaventare o scoraggiare.
E per sette anni, nella penombra della sua cella, David scriveva. Poesie, racconti, lettere, testimonianze autobiografiche, favole. Scriveva per non lasciarsi travolgere dal vortice della monotonia, per lasciar traccia dell’ingiustizia subita, per continuare a guardare oltre il muro, per non arrendersi alle quotidiane privazioni. Scriveva per vivere, leggeva per vivere.
“È nei momenti difficili che brilla il lume della creatività umana”, dice David. “Ho iniziato a scrivere perché la creatività abbatte, cancella le frontiere della realtà. Scrivevo della mia vita quotidiana, della parete – le quattro pareti in cui ero rinchiuso – della mia famiglia, della solidarietà, della speranza. E la scrittura è diventata una trincea, un’ancora di salvezza. Ingrandiva il mio spirito. Ciò che io chiamo resistenciarte, la resistenza attraverso l’arte, dava al mio spirito la capacità di aggrapparmi alla vita. Mi ha reso indistruttibile, perché sapevo che quando sarei stato liberato avrei continuato a portare avanti la mia lotta in difesa dei diritti umani”.
Notti senza firmamento,
non le vedo ma le invento,
la pioggia balla insieme al vento,
e il tuono risuona come un lamento.
Descrivimi il firmamento,
perché non lo vedo da molto tempo.
Grigio o azzurro sarà il cielo?
All’interno del carcere, David ha continuato la sua battaglia per i diritti umani. Poco dopo il suo arrivo alla Picota, ha iniziato a lottare per migliorare le condizioni di prigionia, organizzava corsi e letture per gli altri detenuti, si batteva con loro e per loro affinché fosse rispettata la loro dignità.
“Quando si arriva in prigione si provano sentimenti negativi e contrastanti: disperazione, tristezza, melanconia. Ma dopo alcuni mesi mi sono fatto una domanda: continuo a provare questi sentimenti oppure provo a portare avanti ciò che facevo prima, quando ero in libertà? E ho iniziato così a difendere i diritti dei detenuti, perché chi ha perduto la libertà non deve per forza perdere la dignità. Perché è la dignità a rendere uguali tutti gli esseri umani”, racconta David.
Non rinuncio alla vita,
non rinuncio alla libertà,
non rinuncio alla verità.
Non rinuncio a vincere,
non rinuncio a lottare,
non rinuncio a perseverare,
arriverà un’alba nuova.
Da quando David è stato liberato, le minacce sono ricominciate. Più volte è stato pedinato da paramilitari, e ha ricevuto altre intimidazioni.
“La mia vita è una fabbrica di speranza. Ho sette vite come i gatti. Ho visto assassinare molti dei miei compagni, e io stesso sono sopravvissuto a vari tentati omicidi, ma non ho mai taciuto: continuo a scrivere, a esprimere la mia opinione, ad agire, perché la verità sta dalla mia parte”, dice David.
Dalla firma degli Accordi di Pace nel novembre 2016, la situazione per i difensori e le difensore dei diritti umani in Colombia è drammaticamente peggiorata. I gruppi paramilitari, con la complicità delle autorità e dei grandi imprenditori, hanno conquistato i territori lasciati liberi dai guerriglieri delle FARC (Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane) e hanno ulteriormente rafforzato il loro controllo sull’economia e sulla politica colombiana, spargendo sangue ogni volta che qualcuno prova a denunciare e opporsi.
Tra gennaio e giugno 2018, l’organizzazione colombiana Somos Defensores ha registrato 272 minacce, 77 omicidi, 23 tentati omicidi e 4 sparizioni forzate di difensori dei diritti umani. L’anno scorso – secondo il report “Stop the Killings” a cura di Front Line Defenders – sono stati assassinati 121 attivisti, e solo nel 5 % dei casi c’è stata un’indagine e una condanna dei responsabili.
“A 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani, e a 20 anni dalla Dichiarazione ONU sui Difensori e le Difensore dei diritti umani, il movimento in difesa dei diritti umani fa passi da gigante e in alcuni Paesi queste dichiarazioni vengono commemorate e celebrate con euforia”, dice David. “Ma non in Colombia, dove invece si fanno passi indietro. Mentre parlo, in questo esatto momento, in Colombia stanno probabilmente assassinando un difensore dei diritti umani. Stiamo vivendo una notte oscura, che getta ombre lunghe sull’orizzonte”.
Muore la notte quando appare l’alba,
nasce il giorno con lo splendore dell’aura,
per me il firmamento è una cosa rara.
Gli anni di prigionia non hanno piegato la volontà e l’energia di David. Nonostante le difficoltà non ci sono dubbi o paure quando parla del futuro, solo una speranza cieca, una voglia di aggrapparsi alla bellezza della vita. Soppesa le parole quando parla, le assapora. Ora che non ci sono più quattro fredde pareti a rinchiudere la sua voce, ogni sua parola è un grido di libertà.
“In Colombia vogliamo costruire un futuro in cui sia rispettata la vita, i diritti dei cittadini, i diritti della Madreterra, in cui ai contadini non venga usurpata la terra, in cui ci sia vera pace”, dice David. “Dopo anni di omicidi, sparizioni forzate e ingiustizie meritiamo la pace. Dobbiamo lottare per assicurare la dignità di tutti e di tutte, in qualunque momento, in qualunque luogo. I diritti non devono essere un sogno, un’illusione. I diritti devono essere realtà.”
Passerà il cattivo tempo,
la pioggia diverrà rugiada.
Il sole brillerà mostrando tutto la sua grandezza,
e con il suo fulgore ci condurrà alla libertà.
* I corsivi sono una traduzione di alcuni passi delle poesie scritte da David Ravelo Crespo in carcere, e raccolte nel libro “Acúsenme”, pubblicato nel dicembre 2015 da Editorial La Oveja Negra con il supporto di Front Line Defenders, Justice for Colombia, e Ruskin College.
** L’intervista con David Ravelo Crespo è stata condotta a Parigi, il 31 ottobre 2018, in occasione del Summit mondiale dei Difensori e delle Difensore dei diritti umani, un evento in cui si sono riuniti oltre 150 difensori/e da tutto il mondo per celebrare il 20esimo anniversario della Dichiarazione ONU sui Difensori/e dei diritti umani e trovare possibili soluzioni per sostenere e proteggere chi difende i diritti umani.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Primo comma: la gogna dei social network non è giustizia
Non è un caso se, immediatamente dopo aver sancito la reale possibilità che tutte le persone, su un piede di ‘piena eguaglianza’, possano adire un tribunale che giudichi super partes (articolo 10), la Dichiarazione Universale dei Diritti del’Uomo annoveri tra le libertà individuali fondamentali quella della presunzione di innocenza.
Un segnale chiaro e netto della garanzia del giusto processo, del passato in giudicato, del fino a prova contraria, ancora più forte nell’epoca del giustizialismo sfrenato da social network.
Mai come oggi l’articolo 11 risuona con tutto lo splendore del significato che porta. Se la presunzione di innocenza può essere nullificata da un tweet o qualche riga di facebook, lo stato di diritto ricorda invece che la colpevolezza deve essere provata legalmente. E deve essere provata, senza alcuna distinzione, per tutti. L’imputato, l’indagato, il sospettato di qualsiasi provenienza, sesso, religione, orientamento sessuale e politico, non è mai assimilabile alla figura del colpevole fino al momento della condanna definitiva.
Un articolo che ha una portata contraria alla gogna pubblica che tanto va di moda ultimamente.
Un articolo che ricorda come, al fine della conservazione di quella uguaglianza di dignità umana tutelata dall’articolo 1 della stessa Dichiarazione, norma a fondamento di ogni Costituzione, il principio di innocenza sia la norma delle norme, quella su cui si misura un vero e proprio Stato di diritto.
Presunzione di innocenza
Immaginiamola come sviluppata lungo tre direttrici: il divieto assoluto di presentare l’imputato/indagato in pubblico come colpevole, il diritto al silenzio e alla non auto-incriminazione, l’onere della prova.
Ognuna delle tre direttrici deve essere garantita non solo per il rispetto della dignità umana, appartenente ad ogni individuo solo per il fatto di essere nato nel mondo, ma anche per la civile convivenza, la tanto discussa sicurezza, il buon clima tra esseri umani.
Risulta evidente come si scappa da questi tre principi, e quindi dal rispetto dello Stato di diritto, se si espongono le persone a gogne pubbliche e mediatiche ancor prima che un giusto processo si sia concluso definitivamente.
E’ utile soffermarsi sull’ultima direttrice: l’onere della prova. Provare la reità dell’imputato spetta alla pubblica accusa, mentre la difesa avrà il compito di provare l’esistenza di fatti favorevoli all’imputato. Scontato, si penserà. Invece, anche questa sottolineatura ha una portata gigantesca. In altre parole si sta affermando che non è compito dell’imputato dimostrare l’ innocenza, non spetta nemmeno all’uomo urlare la propria non colpevolezza, perché questa è qualità intrinseca di se stesso che non necessita di alcuna dimostrazione.
L’uomo nasce innocente. Per dimostrare che questa qualità non esiste più bisogna provarlo, oltre ogni ragionevole dubbio. La giustizia è una cosa seria.
Secondo comma: l’importanza degli attimi
‘Nulla poena sine lege’, si tradurrebbe in latino. Non può mai esservi reato, in assenza di una legge preesistente che proibisca quel comportamento. Questo principio, più comunemente noto come “principio di irretroattività”, tutela la possibilità che l’individuo venga colpevolizzato per un fatto che, al momento della commissione, non costituiva illecito. Aggiunge anche un altro piccolo passo ulteriore: vietando di infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento del fatto, automaticamente afferma che la conoscibilità delle regole da osservare e la relativa violazione è uno strumento di tutela talmente importante che deve essere considerato nel momento, nell’attimo, in cui il reato è compiuto. Se l’individuo confidava nel rischio di incappare in una pena diversa e minore, un inasprimento successivo di quella pena non può e non deve riguardarlo.
Nella sentenza n. 394/2006 della Corte Costituzionale, questo principio viene ricondotto a condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
«Interferenze arbitrarie nella vita privata».
La lettura si blocca a questa frase.
Con uno sforzo arrivo fino alla fine. Poi torno indietro, ricomincio.
La lettura si inceppa allo stesso punto: «Interferenze arbitrarie nella vita privata». Un’immagine mi compare davanti agli occhi: vive dentro di me da quando, nel 2011, la notizia uscì dall’Egitto per essere ripresa dai media internazionali. Le attiviste scese in piazza durante la rivoluzione che portò alla caduta di Mubarak furono forzosamente sottoposte a “test di verginità”. Me le sono sempre immaginate così: a dibattersi, mordere, graffiare, lottare con tutta l’energia di cui i loro corpi disponevano – quei corpi che stavano per essere violati, umiliati – contro uomini in
camice bianco che le costringevano a sdraiarsi su un tavolo scrostato per verificare se non avessero già avuto rapporti sessuali.
«Interferenze arbitrarie nella vita privata».
In quei giorni di rivoluzione, la giornalista e scrittrice anglo-egiziana Shereen El Feki, si trovava in piazza Tahrir, al Cairo, per raccogliere materiale per il suo libro Sex and the Citadel: Intimate Life in a Changing Arab World. «Domandai a persone
di entrambi i sessi in che modo sarebbero cambiate le cose in camera da letto se la rivoluzione politica avesse avuto successo», mi ha detto in un’intervista. «Le donne immaginavano già di poter rivendicare la gestione autonoma del proprio imene, la cui
integrità non dovrebbe essere un problema né di famiglia né di Stato. Gli uomini, invece, reagirono con orrore all’idea di una rivoluzione sessuale, oltre che politica. “Siamo arabi, tradizionalisti e musulmani, non è questo il cambiamento che auspichiamo”, mi risposero». E ha aggiunto: «Ancora oggi il matrimonio è il solo
lasciapassare per la vita adulta. Se non ci si sposa non si può uscire di casa, fare sesso, avere figli: si vive in uno stato di adolescenza sospesa».
L’imene come affare di Stato. La scelta di un compagno per la vita come questione familiare, comunitaria, sociale.
«Interferenze arbitrarie nella vita privata».
I pensieri si incatenano gli uni agli altri. Sono tutti declinati al femminile. E richiamano cifre. Un sacco di cifre.
650 milioni: le persone di sesso femminile che, nel mondo, sono state costrette a sposarsi prima della maggiore età (dati Unicef).
12 milioni: le spose bambine per anno, nel mondo (dati Unicef).
200 milioni (almeno): le donne e ragazze – ancora in vita – che sono state sottoposte a mutilazioni genitali nei 30 Paesi prevalentemente affetti dal problema. Nella maggior parte dei casi la mutilazione è avvenuta prima dei 5 anni di età (dati Oms).
29 milioni: le donne intrappolate in forme di schiavitù moderna. Il 71% del totale (dati Ilo).
4,8 milioni (di cui il 99% donne): le vittime mondiali di sfruttamento sessuale (dati Ilo).
35% delle donne nel mondo: quelle che hanno subito – almeno una volta nella vita – violenza fisica e/o sessuale dal partner o violenza sessuale da una persona estranea (dati Onu).
6,78 mila: le donne tra i 16 e i 70 anni (il 31,5% del totale) che hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale in Italia (dati Istat)
So che potrei continuare, elencando il numero dei femminicidi, delle bambine vittime di turismo sessuale, delle donne stuprate durante le guerre in ogni angolo del Pianeta.
E ancora. Ancora.
Ma mi allontanerei dal punto.
Rileggo l’articolo 12, fino alla fine.
«Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».
E mi viene da pensare: ogni individuo, certo. Ma forse le donne di più.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Dalla metà degli anni’60 furono numerosi i cittadini del blocco sovietico che approdarono come richiedenti asilo in Italia. La maggior parte arrivava attraverso la Jugoslavia, alcuni si staccavano da gruppi organizzati, delegazioni ufficiali, o cercavano di attraversare clandestinamente i confini. Nel solo agosto 1967, in meno di un mese si registrarono diverse rocambolesche fughe. Un elettricista cecoslovacco oltrepassò con un salto la recinzione al confine. Due giovani ungheresi percorsero 25 chilometri su un canotto di gomma fino a raggiungere Grado. Altri cinque loro connazionali che tentavano alcuni giorni più tardi di raggiungere l’Italia dalla Jugoslavia su un’imbarcazione improvvisata naufragarono; uno di loro annegò e gli altri furono fortunosamente salvati da un’imbarcazione di passaggio.
Un dentista cecoslovacco, in auto con la sua famiglia, schiacciò il piede sull’acceleratore e travolse la sbarra del valico, lasciando le guardie di frontiera jugoslave attonite in una nuvola di polvere. Un ginecologo ungherese e la moglie attraversarono il confine nel bagagliaio di un’auto tedesca. Pochi giorni dopo un insegnante di geografia rumeno di 25 anni fu salvato dall’annegamento dopo che il suo gommone si era sgonfiato. Il caso più eclatante tuttavia rimaneva quello di una contorsionista romena che aveva attraversato il confine appallottolata sotto il sedile anteriore dell’auto di un amico. Alle volte a chiedere asilo erano anche individui che si trovavano legalmente in un paese del blocco occidentale e decidevano di non tornare indietro. Nello stesso 1967 due ballerini della Compagnia dell’Operetta ungherese si staccarono dal gruppo durante la tournée in Italia e presentarono richiesta di asilo.
Se oggi nella memoria è rimasto impresso soprattutto il muro di Berlino, tutte le borderlands tra i blocchi della guerra fredda, oltre alle zone grigie come la Jugoslavia, furono per decenni segnate
da continui tentativi di fuga. E i confini da attraversare non erano solo quelli terrestri. Nel 1969-1970, in meno di un anno si contarono sette dirottamenti di aerei da parte di cittadini del blocco sovietico verso aeroporti tedeschi o austriaci.
A scappare erano persone molte diverse tra loro. C’erano i membri di una classe media insoddisfatta e non sempre politicizzata, artisti, intellettuali, calciatori. Nel 1968 Attila Dobos e Zsuzsa Mary, due note pop star ungheresi, raggiunsero la Germania occidentale a bordo della loro limousine tedesca e vi presentarono richiesta di asilo. Ma partivano anche molti diseredati, che spesso tentavano la fuga alla disperata, attraverso confini presidiati militarmente. Inutile dire che furono loro a pagare il più alto tributo di sangue.
E’ impossibile stimare il numero di coloro che persero la vita crivellati dai colpi delle guardie di frontiera dei propri paesi d’origine (e in alcuni casi anche jugoslave), annegati nei fiumi o in mare, tentando di attraversare i confini in zone impervie.
Come Elisabeth Moldovan, una ragazza rumena di 17 anni, che precipitò e morì sul passo della morte, mentre tentava di raggiungere la Francia insieme a un’amica.
La quasi totalità dei richiedenti asilo provenienti dal blocco sovietico furono accolti con generosità in occidente ed ebbero infine la possibilità di iniziare una nuova vita oltreoceano. La generosità non era disinteressata, ma rappresentava uno dei cardini della narrazione sul “mondo libero” che offriva asilo agli individui – quasi esclusivamente europei – in fuga dalla persecuzione. Le fughe dal blocco sovietico incarnavano la natura oppressiva dei regimi oltrecortina che, nonostante l’uso della forza, non riuscivano a trattenere i propri cittadini all’interno dei loro confini.
La mancata libertà di movimento era considerata a tutti gli effetti una violazione dei diritti umani, così come le punizioni che attendevano in patria i colpevoli di defezione.
L’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sanciva il diritto di ogni individuo a lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, nonché di ritornarvi.
L’accoglienza verso gli esuli provenienti dall’Europa orientale si basava su un equilibrio sottile, che permetteva al blocco occidentale di usarla a proprio vantaggio: il flusso era ridotto a poche migliaia di persone all’anno dal controllo delle frontiere operato dalle autorità del socialismo reale. Le alcune migliaia di profughi che ogni anno raggiungevano Italia, Austria, Germania occidentale, molti dei quali proveniente dalla classa media, con profili specializzati, erano facilmente ricollocabili, anche grazie a programmi specifici come l’United States Escape Program.
Tuttavia, nonostante le strumentalizzazioni della guerra fredda, si diffuse in quegli anni un’empatia per la figura del profugo, spesso assimilata a quella del dissidente, che, utilizzando il linguaggio
dell’epoca, “votava con i piedi”, a cui in ogni caso bisognava garantire i diritti primari e possibilmente offrire una seconda vita.
Questa costruzione iniziò a scricchiolare negli anni ’80, con l’esplosione dei numeri delle richieste di asilo, e si incrinò con i primi anni ’90. Una volta esauritasi la guerra fredda e cancellati
dall’Europa i paesi del socialismo reale, considerati per tanti anni una deviazione rispetto alla “normalità democratica”, il sistema dell’asilo in Europa iniziò a riformarsi in accordo alle esigenze della fortezza Europa.
A distanza di ormai quasi trent’anni della caduta del muro di Berlino, in modo ironico e paradossale, la situazione pare essersi ribaltata. Gli individui in fuga di oggi possono in genere uscire liberamente dai loro paesi ma non trovano nessuno disposto ad accoglierli. Nel tentativo di esternalizzare il controllo delle frontiere, l’Unione Europea stringe accordi con i paesi di transito e
provenienza dei profughi per tenerli, con ogni mezzo, prigionieri all’interno dei propri confini. E a fare da antemurale, nella narrazione di un’Europa assediata dai profughi, sono proprio molti dei paesi che fino a poche decine di anni fa vedevano i propri cittadini morire sulle frontiere.
Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Nel 2014 ero a Coventry per un master in Arte Moderna. Come tutte le mattine, dopo aver bevuto un caffè e fumato una sigaretta, sono andato a lavorare nello spazio che mi era stato messo a disposizione. Si trattava di un posto di pochi metri quadri, dove potevo realizzare le mie idee. In quel periodo avevo in testa molti pensieri: io, curdo, stavo iniziando il mio progetto di vita, intanto il mio Paese, l’Iraq, stava per essere conquistato dall’Isis.
Non sapevo ancora quale sarebbe stato l’argomento su cui avrei lavorato per la tesi, così ho acceso il computer e sono andato sulla mia pagina Facebook. La prima cosa che ho visto è stata la fotografia di infanzia di un mio amico di scuola. Ne sono rimasto stupito e ho iniziato a pensare ai ricordi della mia infanzia.
Quell’immagine era stata scattata in uno dei vecchi studi fotografici della mia città, e mai avrei immaginato che sarebbe stata capace di farmi sorgere così tante domande. Dove sono le foto della mia infanzia? È possibile che abbia anche io delle foto di quando ero piccolo? E perché non ne ho mai viste? Le domande si facevano sempre più numerose. La prima persona a cui chiedere spiegazioni era mia madre. Lei infatti ha vissuto gran parte della sua vita dentro casa, sa dove si trova ogni cosa, e avrebbe sicuramente avuto buona memoria per ricordarsi dove si trovavano le mie fotografie, l’album di famiglia e le cose importanti come i documenti. Io però ero in Gran Bretagna e mia madre in Kurdistan. La dovevo chiamare subito, così ho cercato mia sorella chiedendole di chiamarmi su Skype la sera per poter parlare con mamma. Dopo esserci scambiati i saluti, ho iniziato subito a domandare a mamma se avesse conservato le mie foto da bambino e perché non le avessi mai viste.
Mi ha risposto così: «Sì, avevamo tante foto di te, dei tuoi fratelli e di tutta la famiglia. Però la maggior parte di quelle immagini sono andate perse, alcune a causa della guerra del 1985, altre nella fuga collettiva del 1990». Le ho chiesto se fosse stata salvata almeno una foto della mia infanzia. Lei mi ha risposto di sì, che una era riuscita a conservarla: «È un piccolo ritaglio di una foto e si vede solo la parte dove c’è il tuo volto. Il resto l’ho tagliato». Ho voluto sapere perché fosse rimasto solo un frammento. Dopo un profondo respiro mi ha risposto: «Figliolo, noi avevamo tante foto e tanti album fotografici, ma durante i giorni della rivoluzione contro il regime Ba’ath, i soldati di Saddam andavano casa per casa a cercare i Peshmerga (partigiani curdi) e tutti quei segni che potessero far pensare alla loro presenza. Se avessero trovato foto o armi in casa ci avrebbero portato via tutti e nessuno avrebbe saputo nulla. Ero spaventata. Ho cercato di bruciare alcune foto di vostro padre con le armi. Alcune le ho tagliate apposta; ma poi ti ho visto, piccolo, dolce, non sono stata capace di tagliare a pezzi tutto. Ho lasciato quella parte che ritrae il tuo viso, mentre quelle di tuo padre vestito da partigiano le ho tagliate a pezzettini piccoli per non farlo riconoscere».
«Ti racconto una cosa. Forse era il 1984 quando siamo andati a casa di mia sorella Hairan. Eravamo io, te, tuo padre, mia sorella Shukri e tuo zio Wali. Siamo andati a fare un picnic a Bani Khelan e stavamo preparando da mangiare quando sono arrivati due signori, erano parenti di Ali, il marito di tua zia Hairan. Erano mercenari del governo ed erano armati. Si sono seduti e uno di loro ha appoggiato il suo kalashnikov accanto a noi. Tu avevi solo un anno, ancora non camminavi e potevi alzarti in piedi soltanto appoggiandoti alle cose. Quando ci siamo voltati, tu stavi già appoggiato all’arma, in piedi. Lo Zio Wali aveva una macchinetta fotografica e velocemente ha immortalato quel momento. È quella la foto che ho tagliato e di cui ho conservato un frammento del tuo visino».

All’epoca dell’operazione militare Al-Anfal, Yadgar Bakir aveva quattro anni. Qualche anno fa ha trovato il frammento di una foto che lo ritraeva. Ne mancava un pezzo così ha chiesto a sua madre che fine avesse fatto. Era stata lei a tagliarla perché accanto a lui si vedeva il kalashnikov di un peshmerga. In quel momento Yadgar ha deciso di ricostruire la propria storia chiedendo ai familiari di raccontargli le fotografie come erano. Grazie a questi racconti Yadgar, rifugiato politico in Italia dal 2016, sta ricreando quelle foto e le condivide nella performance White Faces
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Carta d’identità, di Mahmud Darwish, tratto da FrontiereNews
Ricordate!
Sono un arabo
E la mia carta d’identità è la numero cinquantamila
Ho otto bambini
E il nono arriverà dopo l’estate.
V’irriterete?
Ricordate!
Sono un arabo,
impiegato con gli operai nella cava
Ho otto bambini
Dalle rocce
Ricavo il pane,
I vestiti e I libri.
Non chiedo la carità alle vostre porte
Né mi umilio ai gradini della vostra camera
Perciò, sarete irritati?
Ricordate!
Sono un arabo,
Ho un nome senza titoli
E resto paziente nella terra
La cui gente è irritata.
Le mie radici
furono usurpate prima della nascita del tempo
prima dell’apertura delle ere
prima dei pini, e degli alberi d’olivo
E prima che crescesse l’erba.
Mio padre… viene dalla stirpe dell’aratro,
Non da un ceto privilegiato
e mio nonno, era un contadino
né ben cresciuto, né ben nato!
Mi ha insegnato l’orgoglio del sole
Prima di insegnarmi a leggere,
e la mia casa è come la guardiola di un sorvegliante
fatta di vimini e paglia:
siete soddisfatti del mio stato?
Ho un nome senza titolo!
Ricordate!
Sono un arabo.
E voi avete rubato gli orti dei miei antenati
E la terra che coltivavo
Insieme ai miei figli,
Senza lasciarci nulla
se non queste rocce,
E lo Stato prenderà anche queste,
Come si mormora.
Perciò!
Segnatelo in cima alla vostra prima pagina:
Non odio la gente
Né ho mai abusato di alcuno
ma se divento affamato
La carne dell’usurpatore diverrà il mio cibo.
Prestate attenzione!
Prestate attenzione!
Alla mia collera
Ed alla mia fame!
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
In quel villaggio il dottore era arrivato da pochi giorni. Gli avevano destinato una capanna vuota con un’amaca. Adesso erano rimasti in poche centinaia gli Arawete, divisi in tre villaggi lungo la sponda del fiume.
Erano stati nomadi fino a pochi anni prima, poi il governo brasiliano li aveva persuasi ad una precaria vita stanziale lungo il corso del fiume.
La prima volta il dottore aveva montato la sua piccola tenda a poche centinaia di metri dal villaggio, ed erano presto arrivati i bambini che avevano poi raccontato dell’uomo bianco che non sapeva cacciare né pescare, ma aveva lo zaino pieno di pomate, farmaci, scatole di medicinali.
Lo avevano prima accolto come un ospite d’eccezione, poi, anno dopo anno, lo avrebbero riconosciuto come un potente sciamano.
Quel pomeriggio un uomo entrò nella sua capanna e osservò con attenzione gli oggetti tirati fuori dallo zaino e ordinatamente disposti sul sacco a pelo, poi prese il magnifico coltello a più lame che il dottore portava sempre con sé nei suoi viaggi, lo infilò nella tasca delle brache e uscì in fretta dalla capanna.
Il dottore scavallò dall’amaca e lo seguì nel largo spiazzo assolato, dove si aggiravano i cani macilenti e i pappagalli colorati con le ali tagliate.
Il coltello è mio, disse con il sorriso più amichevole, affiancando l’uomo che sembrava rimbalzare sui piedi nudi.
L’altro l’osservò prima stupito, poi si fermò e sorrise anche lui, ma con l’accondiscendenza dovuta ai bambini, ai pazzi e a quell’uomo bianco che nella foresta camminava in mezzo al gruppo per sentirsi ed essere eventualmente protetto.
Nel suo curioso portoghese cantilenante spiegò al dottore che il coltello in quel momento a lui non serviva mentre serviva a un suo parente. Quando serve a te, gli spiegò, basta che chiedi in giro.
Fu così che il dottore apprese che il suo coltello era anche suo, che nel villaggio la proprietà di un utensile era di chi ne aveva bisogno.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Passaggio, respinta, cross in area. Ye Erfan, spalle alla porta, divora la palla con gli occhi, salta e con una sforbiciata la infila in rete. Un gol epico, diventato subito virale sui social. Un gesto atletico di quelli che ti possono cambiare la vita. E in effetti questa era la prospettiva della giovane promessa dello Jiangsu Suning, squadra di calcio cinese dello stesso gruppo che controlla l’Inter. Dopo la sua prodezza, erano stati proprio i nerazzurri ad averlo puntato. A dicembre dell’anno scorso giravano voci sul suo arrivo a gennaio alla Pinetina. Alla fine non se n’è fatto nulla. Rimane il fatto, però, che di lui non si hanno più notizie dall’aprile di quest’anno.
Ye Erfan, nome di battaglia di Erfan Hezim, quando ha segnato il gol che lo ha reso celebre in tutto il mondo indossava la maglia della nazionale cinese under 19, ma era (e si spera sia ancora) prima di tutto uno uiguro, membro cioè della minoranza turcofona-musulmana che abita da secoli lo Xinjiang.
In questa regione dell’estremo ovest della Cina è in atto, ormai da più di un anno, una sorta di pulizia etnica di massa. In tutto si stima siano un milione gli uiguri rinchiusi in quelli che il governo cinese definisce “centri di rieducazione”, allestiti in nome della “sicurezza nazionale” e “contro la minaccia del terrorismo islamico”. La stima però è approssimativa. Al Summit Mondiale dei Difensori dei Diritti Umani, che si è svolto a Parigi dal 29 al 31 ottobre scorsi, Dolkun Isa, presidente dello World Uyghur Congress, ha detto che potrebbero essere anche tre milioni le persone rinchiuse. «Negli ultimi dieci mesi, abbiamo ricevuto tantissime denunce di uomini e donne che sono stati presi e che non sono mai più tornati indietro».
Centri che di fatto sono campi di detenzione, dove a chi ci è rinchiuso viene fatto il lavaggio del cervello. «Non si sa per quanto tempo debbano stare lì. Non c’è nessuna reale spiegazione del loro imprigionamento. I primi sono comparsi nel 2017. All’inizio rinchiudevano chi era stato all’estero, chi aveva dei parenti o degli amici residenti in altri paesi, poi hanno iniziato con chi andava in moschea. Ora le scelte sembrano essere del tutto arbitrarie», ha spiegato ancora Isa. I prigionieri sono costretti a imparare il mandarino, inneggiare al Partito Comunista, rinnegare la fede musulmana. Chi non viene privato della libertà, invece, vive in un costante stato di polizia. Le autorità locali, coadiuvate da quelle centrali, hanno organizzato un sistema di raccolta dati invasivo. Dalle registrazioni delle telefonate, al controllo dei messaggi in entrata e in uscita, fino al riconoscimento facciale. Lungo le principali strade delle città della regione, ma anche negli angoli delle vie e di fronte alle moschee, sono state installate migliaia di telecamere. Operazione che ha trasformato lo Xinjiang in una delle zone più sorvegliate al mondo.
Girare per strada con il velo è vietato, mangiare carne di maiale nei locali pubblici è proibito, chi non beve alcol è guardato con sospetto. In pratica Pechino ha messo al bando l’Islam, considerando chi pratica la religione alla stregua di un “malato di mente”.
Se fino a qualche mese fa la Cina continuava a negare l’esistenza di questi campi, alla fine, di fronte alle inconfutabili prove portate al cospetto delle autorità centrali persino in sede Onu, non ha più potuto nascondere al mondo intero che sta rinchiudendo migliaia di persone solo perché di fede musulmana.
A testimonianza di un fatto che ha dell’incredibile, sia in termini numerici che umani, ci sono riprese satellitari, testimonianze di ex detenuti, incroci di dati. Un lavoro di inchiesta e di denuncia iniziato da Human Rights Watch e portato avanti anche da giornalisti di diverse testate internazionali, dal New York Times al The Wall Street Journal, fino alla Reuters, che ha provato a mappare i vari centri di detenzione sparsi nella regione. “In tutto per ora se ne contano 39. Ma l’impressione è che si stiano espandendo a macchia d’olio”.
Mentre per l’amministrazione Trump la questione uigura è un puntello su cui fare leva (con dazi e sanzioni) nei confronti dell’emergente potenza egemonica, per l’Europa rischia di compromettere i buoni rapporti commerciali. Tuttavia nella risoluzione del 4 ottobre 2018 sulle “Detenzioni arbitrarie di massa degli uiguri e dei kazaki nella regione autonoma dello Xinjiang”, il Parlamento europeo ha accolto con favore le decisioni prese dalla Germania e dalla Svezia e ha invitato tutti gli altri Stati membri dell’UE a seguire l’esempio e ad accelerare le pratiche per le richieste di asilo dei musulmani turchi per evitare che vengano rimpatriati. Il Parlamento europeo ha anche invitato gli Stati membri dell’UE a invocare il diritto interno, a seconda dei casi, per fare indagini sull’intimidazione del governo cinese nei confronti della comunità in esilio in Europa.
L’ultimo atto della campagna di informazione e pressione affinché Pechino non solo ammetta ma smetta anche questa pratica che viola i diritti umani, è la lettera scritta lo scorso 3 dicembre sempre da Human Rights Watch: “Unione europea: sospensione delle deportazioni dei turchi musulmani in Cina”, è l’oggetto della missiva rivolta a tutti i paesi membri. Un ulteriore problema che sta emergendo in questi mesi, infatti, sarebbe quello del pressing degli uomini di Xi Jinping sui membri della diaspora uigura, che godono dello status di rifugiato o di richiedente asilo.
«Abbiamo documentato casi di rimpatri forzati di uiguri da Cambogia, Nepal, Pakistan e Thailandia, tra gli altri; tutti corrono il rischio di ulteriori abusi e tra quelli che sono stati costretti a tornare solo di pochi si hanno avuto ancora notizie. Di alcuni si sa che sono stati processati e maltrattati durante la detenzione».
“Campi di concentramento”, “pulizia etnica”. Sono i termini che andrebbero usati per definire quello che sta accadendo oggi in Xinjiang. Loro, i “cinesi”, è dal 1949 che cercano di rimpiazzare gli uiguri. Avevano provato con il trasferimento forzato in questa remota regione di decine di migliaia di han (gruppo etnico maggioritario in Cina). Poi, nel 2014, dopo gli attentati a Kunming e a Ürümqi, in cui hanno perso la vita una settantina di persone in tutto, Pechino ha lanciato la campagna “Strike Hard”.
La retorica dell’antiterrorismo è approdata nell’estremo ovest della Repubblica popolare e con essa la pratica. Sotto il vessillo della sicurezza nazionale, è stato messo in atto un piano per eliminare una minoranza, un’altra. «Spetta solo alla Cina risolvere i “problemi” in Tibet», disse l’ambasciatore di Pechino al Palazzo di Vetro, Wang Guangya, incontrando il segretario generale Ban Ki-moon. Era il marzo del 2008 e per le strade della capitale Lhasa erano appena caduti un centinaio di rivoltosi sotto il fuoco incrociato dell’esercito cinese. Evidentemente la lezione tibetana non è servita al resto del mondo.
Alla Cina sì, visto che il modello repressivo è lo stesso che ha esportato in Xinjiang, dove dal 2016 è arrivato a dettare legge l’ex segretario del Partito comumista in Tibet. E per gli uiguri non c’è stata più pace.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Clicca sulla foto per leggere il rapporto dell’Unesco
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Clicca sulla foto per leggere il rapporto annuale di Amnesty International
Articolo 22
“Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità”.
“Il più grande inganno del diavolo è stato quello di far credere al mondo che lui non esiste”.
(da “I soliti sospetti”).
Una mattina di molti anni fa fui svegliato dalla telefonata di un collega. Fuori era ancora buio e lui – all’epoca eravamo fotoreporter – mi avvertiva che nella notte era scoppiato un numero imprecisato di bombe a Roma, dove vivevamo. In particolare a San Giovanni e a San Giorgio al Velabro.
Scoprimmo più tardi che quegli episodi facevano parte di una
strategia concepita da Cosa Nostra, all’epoca la compagine mafiosa più forte, che includeva eventi analoghi a Firenze e Milano. Una manciata di morti, molti misteri. Vennero colpiti luoghi religiosi e culturali.
Quella mattina sigillò, come una lastra di marmo sopra una tomba, la speranza di vivere in un paese dove gli anticorpi per resistere alle mafie fossero cresciuti a sufficienza per resistere. Venivamo tutti da un anno terribile. Nel 1992 quelli di Cosa Nostra si erano
sbarazzati con inaspettata semplicità dei due nemici più insidiosi: Falcone e Borsellino saltarono in aria insieme ai loro cari, agli agenti di scorta.
Non era passato molto tempo da quando Falcone affermava che se si vuole capire e dunque combattere e infine sconfiggere la mafia, bisogna andare nelle banche. Capire la direzione e i percorsi dei soldi.
Sembra passata un’eternità da quei giorni eppure sono solo quasi trent’anni. Tuttavia le giovani generazioni italiane sono nate e cresciute in un paese dove la memoria di quegli eventi, delle parole pronunciate, dei nomi e dei volti dei protagonisti è andata massimamente perduta.
Le trasformazioni sociali, politiche e culturali sono state repentine e non aiutano a creare un quadro preciso della storia recente. Se queste generazioni pensano di trovarsi in uno dei “migliori mondi possibili” che ho sentito nominare tanto in questi anni, soprattutto da chi ha sempre ignorato le crescenti e insopportabili disparità sociali trovandosi dalla parte privilegiata della ruota, secondo me sbagliano. Ma sarebbe già molto se si ponessero questo dubbio.
Nonostante negli ultimi quindici anni siano stati arrestati molti esponenti di spicco dei consorzi mafiosi “tradizionali”, con realismo si può affermare che il treno passato a ridosso delle stragi del ‘92, quello in cui la rabbia e il desiderio di cambiamento si avvicinarono come non mai travalicando le appartenenze politiche pur di unirsi nella lotta alle mafie, sia stato ampiamente perso e chissà quando ripasserà.
Le mafie hanno sempre avuto momenti duri nella loro storia, vecchia quanto l’unità d’Italia. Si sono sempre sapute riorganizzare, soprattutto modificando il proprio comportamento e
anticipando i tempi. Loro, i mafiosi, i treni raramente se li fanno sfuggire. Che passino in orario oppure no. Da che si spostarono dalle campagne alle città a quando la loro attività prevalente si trasformò da predominio sugli appalti edilizi al commercio di droga; da che il loro controllo passò da quello esercitato su un territorio regionale alla creazione di una fitta rete di traffici internazionali; da che con il controllo del territorio potevano influire sulle scelte elettorali, imprenditoriali e politiche di una regione a quando in qualsiasi angolo del territorio chi intraprenda una carriera istituzionale sa che il suo cammino prima o poi
incrocerà quello di un clan; infine, dal controllo assoluto entro i confini nazionali alla cessione di controllo del territorio a gruppi mafiosi stranieri, permesso evidentemente rilasciato a fronte di una non negoziabile convenienza economica.
Per molti ragioni c’è motivo di credere che le mafie la loro partita contro lo Stato l’abbiano vinta. Che uno o più sistemi mafiosi abbiano inquinato quello democratico, dimostratosi troppo permeabile e fatalmente incapace di stabilire priorità e impostare strategie di resistenza alle infiltrazioni.
Che oggi si viva un momento in cui le mafie godono di una
tranquillità tale che non hanno un estremo bisogno di mostrare i denti, compiere attentati e diventare così visibili agli occhi dei più. Quasi ovunque oggi non è neanche così decisivo che un clan imponga il proprio dominio su un clan limitrofo. Oggi una guerra, come quella che negli anni Ottanta contrappose i corleonesi di Riina e Provenzano alle famiglie palermitane dei Bontade e degli Inzerillo, non lascia sulle strade più di mille cadaveri come
allora. Quando accade, seppur con numeri molto più esigui, la trattazione ricevuta dai media sembra ricalcare quella che ci raccontava la mafia negli anni sessanta.
Notizie di cronaca, trafiletti e nessuna intenzione, o voglia, o capacità – il risultato alla fine si somiglia – di mettere insieme gli elementi e dipingere un quadro più esteso.
I presìdi democratici continuano a crollare, tanto è vero che il movimento antimafioso sorto una quindicina d’anni fa, in grado di destare interesse, adesioni e speranze, si è smarrito di fronte all’ambiguità di alcuni suoi rappresentanti istituzionali oggi sotto inchiesta o arrestati.
E anche le realtà più solide non sono in grado di rappresentare le istanze di un popolo che voglia liberarsi dalle mafie senza apparire di parte. Sfruttando la portata limitata della strategia repressiva e la colpevole distrazione dei governi i clan si sono espansi come mai prima. La rigida burocrazia dell’ancor giovane
Unione Europea, capace di inalberarsi per uno zero virgola di crescita in più o in meno, si è mostrata permeabile – è un termine gentile – alle attività mafiose e soprattutto ai soldi generati dai metodi mafiosi. La prova più evidente è la mancanza di una legislazione antimafiosa che valga in tutto il continente, per cui le prove raccolte in un paese si dimostrano insufficienti per portare a processo qualcuno in un altro paese.
Nessuno Stato è immune da questo problema, non si dia nessun appiglio a chi afferma che parlarne significhi fare razzismo al contrario dimostrando la propria anti-Italianità. In Europa le mafie sono entrate e hanno messo le tende in mercati giganteschi, vere e proprie miniere d’oro. Dal mercato ortofrutticolo di Fondi, il più grande a livello continentale, a quello dei fiori in Olanda. In Germania (la virtuosa, quella che per anni ha impartito lezioni di morale su come si tengono in ordine i conti) si contano ormai su due mani gli anni in cui le mafie hanno intrapreso investimenti massicci.
Ad eccezione di qualche operazione di polizia che finisce sui giornali il tempo di un battito di ciglia, i sodalizi criminali agiscono pressoché indisturbati. Anche in Gran Bretagna, grazie alla possibilità di aprire una società in pochi minuti senza nessun controllo particolare, le mafie italiane sono ormai di casa. Il binomio democrazia-capitalismo, a prescindere dalla Brexit, offre maglie molto larghe e permette operazioni di riciclaggio rivestite da un aspetto di normalità.
Lo sport, o almeno gli sport dove vengono investiti miliardi di euro, è un buon parametro per definire il grado di penetrazione delle mafie nel tessuto sociale. Spiace constatare che senza l’intervento della magistratura, la quale non è comunque esente dall’accumulo di ritardo nel contrasto alle mafie, i clan calabresi avrebbero potuto continuare ad agire indisturbati nella gestione della vendita dei biglietti del club calcistico che domina senza rivali da quasi un decennio il campionato italiano. “Lo fanno tutti”, è stata una delle inquietanti tesi difensive.
Nel recente passato spicca, a sforzarsi di mantenere la memoria, la storia di Simone Farina, difensore ventinovenne in forza al Gubbio, che rifiutò duecentomila euro per truccare l’esito di una partita subito dopo l’insorgere di una inchiesta giudiziaria su un giro di scommesse miliardario che coinvolgeva calciatori ed ex calciatori di serie A. Farina fu ricoperto di complimenti ma contestualmente alla sua denuncia smise di giocare a calcio e trovò lavoro solo nei settori giovanili di squadre di club inglesi.
I clan trovano il modo di trarre il massimo profitto da qualsiasi attività dove ci sia un giro di soldi che reputano interessante. Dall’Expo di Milano agli appalti e al radicamento sul territorio in Emilia Romagna, che ha portato agli arresti del 2015 e al susseguente processo “Aemilia”. Ogni compagine politica deve fare i conti ormai con la contiguità ad ambienti mafiosi, con il rischio di incrociare la propria strada con quella di compagni di viaggio molto presentabili ma con zero scrupoli.
Il volto delle mafie non è quasi mai più quello di Riina e Provenzano. Oggi i mafiosi si confondono nella società civile con maggiore facilità perché minore è la voglia di segnare una linea di confine, un “noi” e un “loro”. Ci sono segnali di tutti i tipi in questo senso: dagli affari già citati alle involuzioni culturali che portano un politico che è stato a capo del governo sette volte a definire “eroe” un boss mafioso.
E la cosiddetta società civile nel frattempo ha ancora il diritto di indignarsi, di appoggiarsi agli slogan di venticinque anni fa? Le “loro idee” hanno davvero camminato “sulle nostre gambe”? Salvo alcune eccezioni credo proprio di no. Il recente abbattimento delle otto ville appartenenti al clan dei Casamonica a Roma, nel quartiere Quadraro, è davvero un evento storico per la città, come ha detto l’attuale sindaco Raggi. Potrebbe segnare un “prima” e un “dopo” se è vero che i simboli, quando si parla di mafie, hanno la loro importanza. Eppure un evento simile trent’anni fa sarebbe stato salutato come un successo della civiltà democratica su quella mafiosa, mentre oggi è stato ridotto all’ennesimo fronte di scontro politico per attribuirsi i meriti dell’operazione e scaricare sugli avversari i ritardi.
A questo si riduce la narrazione sulle mafie in Italia come fuori confine e questa pochezza si percepisce interamente. Se oggi parlare di sicurezza significa discutere (più che altro scontrarsi) quasi esclusivamente sull’immigrazione ciò si deve a trent’anni di progressiva disattenzione. Tutto è diventato più urgente, più importante, dell’esistenza delle mafie.
Quando esistono, giacché non più tardi di otto anni il prefetto di Milano affermava che “a Milano e in Lombardia la mafia non c’è”. Le cronache restituiscono una quotidianità del tutto diverso in cui l’unico elemento di forte novità è rappresentato dal radicamento
progressivo, su tutto il territorio Italiano, di gruppi mafiosi provenienti dall’estero.
Nigeriani, marocchini, cinesi, sudamericani, rumeni, albanesi e dimentico qualcuno di sicuro. Ma quante volte siamo in grado di operare questo ragionamento? Perché se ragioniamo sull’arrivo di persone dalla Nigeria dovremmo ignorare la presenza massiccia della mafia nigeriana? Quando tornerà una generazione che avrà voglia di misurarsi su questo terreno si ritroverà comunque, come già accaduto nella nostra storia, troppo in ritardo. Le dichiarazioni d’intenti non servono a nulla.
Non ho idea di quanto tempo dovrà passare prima che l‘articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani trovi una sua applicazione pratica. Non mi pare esagerato voler legare il significato di questo articolo, che parla di sicurezza e diritto allo sviluppo di ogni singolo individuo, alla proliferazione massiccia di attività e investimenti mafiosi ormai
in tutto il mondo. Al di là delle cifre, che per forza di cose rimangono orientative (alcuni calcolano che le mafie in Italia “fatturino” annualmente il 10% del PIL; altri che questa cifra si attesti sullo 0,7%. In entrambi i casi si ragiona su numeri con tanti zeri), c’è da rimanere sgomenti e disorientati se si approfondisce la ricerca su quanti gruppi mafiosi esistano nel mondo e di quanta ottima salute godano tutti.
L’abbaglio per il quale “prima almeno c’era la DC ed è vero, rubava, ma almeno faceva mangiare tutti”, mi sembra uno dei danni maggiori consolidatosi negli ultimi anni sul piano sociale e culturale. Quel che viviamo oggi è solo una diretta conseguenza del modo di operare della politica di trent’anni fa, delle connessioni sempre più forti tra mondi apparentemente in contrapposizione ma in realtà, come spiegava bene Massimo Carminati in una delle intercettazioni dell’operazione “Mafia Capitale”, fortemente desiderosi di incontrarsi in una Terra di Mezzo per trarre benefici reciproci.
Le intimidazioni subìte dai giornalisti Italiani e gli omicidi di loro colleghi nel resto d’Europa mostrano il vero volto di un sistema che di sociale ha ben poco e bada soprattutto ad un proprio tornaconto. La dignità di cui parla l’articolo 22 è qualcosa che in questo contesto va conquistata ogni giorno, in una dimensione individuale prima che collettiva, secondo la quale ben pochi di
noi possono sentirsi esclusi dal far parte, seppur controvoglia, di uno dei tanti meccanismi mafiosi in essere nel nostro paese e nel mondo.
Rileggendo l’articolo prima di consegnarlo mi rendo conto di aver scritto molte cose scontate e ai limiti della banalità, lette e rilette altrove centinaia di volte. Eppure in contrasto rimane la sensazione che quando si parla di mafie si tratti sempre di un argomento per i più confinato a una dimensione leggendaria. Si raccontano invasioni e distruzione del welfare senza mettere questi argomenti in correlazione con l’esistenza delle mafie. Mai come in questi anni abbiamo letto in contrapposizione i commenti su Falcone o Borsellino (“Chi glielo ha fatto fare? Altro che eroi, erano due poveri illusi”) o i numerosi attestati di solidarietà nei confronti di persone arrestate, sulla base del principio che “rubano tutti, perché prendersela solo con loro?”. O il sempreverde “Perché chiamarla mafia? Se tutto è mafia, niente è mafia”. Giochi di parole e azzardi filosofici fatti scontare ai dodicenni che vengono assoldati per fare da palo mentre gli adulti intascano migliaia di euro al giorno vendendo droghe di ogni tipo. Sì, perché di quei dodicenni non vi è traccia nelle agende politiche, nelle risse televisive, nelle infinite campagne elettorali trascinate su Twitter.
Almeno sul piano delle coscienze individuali non dovremmo permettere ai sistemi mafiosi di far credere che va bene così, che il dilagare dei traffici e la moltiplicazione dei canali di riciclaggio dei soldi si trasformi in benessere per tutti. Che non sia un percorso semplice lo sappiamo bene o almeno dovremmo saperlo. Ciò non toglie che tutta la strada che possiamo fare siamo chiamati a farla al meglio.
Possibilmente creando delle basi per le generazioni future che siano meno traballanti di quelle che il secolo scorso, con le sue certezze contrapposte e in apparenza incrollabili, ha lasciato a noi.
A Rita Atria, Gelsomina Verde, Annalisa Durante, Luigi ed Aurelio Luciani, a Daphne Galizia Caruana e a tutti coloro vissuti in assenza delle garanzie previste dall’articolo 22.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la
disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato, e nessuno mi può costringere a continuare a farne parte. È un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di riferimento, e privo ormai anche di prospettive.
Non ci sono le condizioni per impormi, e io non ho i poteri o i mezzi per crearle. Non sono rappresentato da niente di ciò che vedo e
non gli attribuisco nessun senso: io non c’entro nulla con tutto questo.
Non posso passare la vita a combattere solo per sopravvivere, per avere lo spazio che sarebbe dovuto, o quello che spetta di diritto, cercando di cavare il meglio dal peggio che si sia mai visto per avere il minimo possibile. Io non me ne faccio niente del minimo, volevo il massimo, ma il massimo non è a mia disposizione.
Di no come risposta non si vive, di no si muore, e non c’è mai stato posto qui per ciò che volevo, quindi in realtà, non sono mai esistito. Io non ho tradito, io mi sento tradito, da un’epoca che si permette di accantonarmi, invece di accogliermi come sarebbe suo dovere fare.
Si chiamava Michele, aveva trent’anni. Si è tolto la vita nel 2017, sottolineando in più punti della sua lettera d’addio come precarietà e disoccupazione avessero contribuito a minare nel profondo il suo spirito.
Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato. L’articolo 23 infatti poneva le basi per un mondo diverso. Il lavoro come diritto, il lavoro come parte del proprio percorso di realizzazione personale, frutto di una libera scelta.
Michele, come tantissimi altri giovani della sua generazione, non ha potuto scegliere, ha subito dinamiche più grandi di lui. Non è stato protetto dalla disoccupazione e i grandi sogni che la Dichiarazione dei Diritti Umani si proponeva di incoraggiare e far volare si sono frantumati di fronte all’orrore del quotidiano.
L’orrore di non essere mai abbastanza. Mai abbastanza qualificati, mai abbastanza appetibili per il mercato. Il lavoro è qualcosa che ci si deve meritare, un diritto che spetta solo ai vincenti di questa competizione permanente. Bisogna avere le caratteristiche che il mercato richiede, fare le scelte giuste, vietato sbagliare.
I perdenti si devono accontentare, non devono essere choosy. Prendere quello che viene ed esserne grati. Ai perdenti rimane solo il compatimento per la loro sorte.
Si chiamava Isabella, aveva 34 anni, era madre di 4 figli. Stroncata da un malore nel 2012, probabilmente le sue condizioni di salute si sono deteriorate a causa della fatica e di ritmi di vita logoranti.
Ore di pendolarismo da Torvaianica a Roma ogni giorno, orari massacranti nel piccolo bar che aveva preso in gestione. “Il mare? È da mesi che non lo vedo”, così i giornali riportarono le sue parole nel raccontare la vicenda.
Si chiamava Mohammed Bouazizi, abitava in una cittadina sconosciuta della periferia del mondo, Sidi Bouzid, Tunisia. Si diede fuoco dopo la confisca del suo carretto da parte della polizia, morendo il 17 dicembre 2010. Ciò che seguì quel disperato gesto è ormai storia nota.
In un mondo che celebra l’iniziativa individuale e la figura dell’imprenditore (forse sarebbe meglio dire startupper, aderendo allo spirito del tempo che propone soluzioni individuali al lavoro che non c’è?), poca attenzione viene rivolta a chi si arrabatta, ai sacrifici fatti quando lo scenario è gretto e grigio. L’epica vuole eroi belli e dalle magnifiche gesta, non bariste né venditori ambulanti di frutta e verdura.
Nonostante lavorino duramente, proprio come l’etica dominante prescrive ciecamente in quanto ricetta per il successo.
La Dichiarazione dei Diritti Umani è un prodotto del pensiero liberale, distante dalla teoria del valore marxiana e dal concetto di lotta di classe. I diritti “socio-economici” sono stati spesso trattati con imbarazzo, come un lusso. Eppure, 70 anni dopo, l’articolo 23 risuona quasi rivoluzionario nel rivendicare il diritto al lavoro, all’equa paga, alla dignità e alla protezione sociale.
Principî ora appannaggio di un club ristretto che dispone del necessario capitale per negoziare, fuori dal quale queste nobili idee diventano un ostacolo per un modello di crescita che accettiamo come “naturale”, ma che in verità è il prodotto di precise dinamiche e decisioni politiche.
Si chiamava Abdesselem, 53 anni, di origini egiziane. È morto nel 2016, travolto da un tir durante un picchetto di fronte alle società di logistica Gls di Piacenza. Scioperava per il mancato rispetto degli accordi riguardo all’assunzione a tempo determinato di alcuni colleghi precari.
Se l’iniziativa privata è il motore di tutto, protestare non sta bene. Lo chiamano trickle-down effect: lasciate fare, non chiedete redistribuzione, tanto prima o poi il benessere arriverà anche agli ultimi. Un’idea infondata, smentita dai fatti e della ricerca, ma così potente da dominare le agende politiche a diverse latitudini.
Si chiamava Soumaila Sacko, 29 anni, originario del Mali. Sindacalista. È stato ucciso a fucilate nel giugno 2018, nella zona di Rosarno, mentre recuperava dei materiali di scarto per le baracche in cui lui e i suoi compagni braccianti vivevano in condizioni miserevoli.
Molti di questi nuovi schiavi sono cosiddetti “migranti economici”: hanno abbandonato le periferie di origine inseguendo una chimera di dignità e benessere, per rivivere le stesse, se non peggiori, situazioni di emarginazione e sfruttamento.
L’articolo 23 della Dichiarazione dei Diritti Umani è assente in queste storie. Spazzato via da altre logiche e altri rapporti di forza.
“Nell’oceano del lavoro la tempesta deriva dall’aver messo in competizione tra loro, deliberatamente, il mezzo miliardo di lavoratori del mondo che hanno goduto per alcuni decenni di buoni salari e condizioni di lavoro, con un miliardo e mezzo di nuovi salariati che lavorano in condizioni orrende con salari miserandi”, scriveva Luciano Gallino nel suo libro Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità. Abdicando alle rivendicazioni dei propri diritti, il mercato del lavoro è diventato una corsa al ribasso su scala globale, da cui è parzialmente esente solo un ristretto gruppo di fortunati e privilegiati (ma qualcuno direbbe “meritevoli”).
Quali sono i nomi dei 1134 morti e degli oltre 2500 feriti del crollo del Rana Plaza, in Bangladesh, il 24 aprile 2013? Operai, soprattutto donne, vittime di un modello capitalista globalizzato che risparmia su tutto, dai salari alla sicurezza, per accumulare profitti nelle mani di pochi. Un risparmio funzionale anche a mantenere contenuti i prezzi dei beni di consumo sui nostri mercati, affinché si possa continuare a spendere nonostante delocalizzazioni e precarietà.
“Il problema smisurato che la politica nazionale e internazionale dovrebbe affrontare sta nel far sì che l’incontro che prima o poi avverrà tra queste due parti della popolazione mondiale avvenga verso l’alto della scala dei salari e dei diritti piuttosto che verso il basso; che è l’esito verso cui finirebbe per condurci lo smantellamento delle protezioni legali dell’occupazione ― uno dei tanti sinonimi della flessibilità”, proseguiva Gallino.
Perché l’articolo 23 torni a vivere e valere, magari venendo anche superato nel senso di una più alta giustizia sociale, le nuove lotte non possono che essere una combinazione di istanze nazionali e internazionali. Una vocazione universale, appunto.
A Sandro Accorsi, ragazzo della Bologna del ’77 e alle sue storie di gioiosa militanza.
Au revoir là-haut, camarade.
Torno con la mente al 1948, mio padre aveva sedici anni, la guerra era finita da poco, nei suoi racconti – non così dettagliati, ci sono corse nei boschi in periferia di Milano con raffiche di aereo, corpi per le strade all’indomani di Piazzale Loreto. Mia madre aveva cinque anni, nell’astigiano, nata con il rumore dei bombardieri e le sirene nelle orecchie. Solo a scriverlo mi pare di iniziare un racconto di un’epoca passata. Ed era solo settant’anni fa. Oggi mia madre spippola sullo Smartphone, mio padre a 86 anni gira su un’auto nelle zone dove correva con le braghe corte e riceve chiamate con il bluetooth.
È così che va letta la carta che si celebra, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Universale, uomo, il tutto e l’uno
Nel 1948 sicuramente il concetto di individualismo era ben distante da quello che è stato costruito negli anni successivi, a tavolino, con la disintegrazione del lavoro come lo conoscevamo, delle classi, per come le conoscevamo, delle ideologie per come rappresentavano la storia del Novecento. Ed è in quel quadro storico, usciva il famoso 1984 di George Orwell, nasceva la Costituzione repubblicana in Italia, il primo numero di Tex nelle edicole, per dire tre cose diverse di una società ancora piagata dalla dominazione dei dogmi cattolici e clericali sull’etica laica, che dovremmo leggere una prima volta quegli articoli.
Sono di una contemporaneità disarmante, come se vi fosse, sui principi base, l’assenza di invecchiamento, di ossidazione, mentre ancora troppi di quegli articoli sono negati e sopraffatti ogni giorno.
L’articolo 24 è quello che ho scelto. Pare frivolo, oggi, parlare di diritto allo svago, meno frivolo parlare di diritto al riposo.
Per restare nella sfera dei miei affetti devo confessare che ho scelto il 24 guardando le mie figlie, in un messaggio che spesso ricorre quando si gioca al gioco dell’immaginazione. Il che vuol dire guardare la realtà e costruirne una parallela.
E se davvero fossimo una specie intelligente, davvero avremmo creato una gabbia quotidiana che ci dice quando possiamo riposare o svagarci?
Davvero si può immaginare solo una società che chiude i battenti in un arco di 20 giorni estivi per precipitarsi in massa dai centri cittadini verso coste e montagne, aerei e macchine, per poi tornare alla base a un segnale dato? Davvero questo è progredire nel benessere dell’umanità?
Giocare a questo gioco significa che va spiegato con calma e cercando le parole il concetto di produzione, di produttività e di profitto. Inevitabilmente si arriverà a parlare di chi accumula il capitale e delle leve che hanno spinto verso un’iperproduzione che, nei fatti, sta uccidendo, più che la Terra, l’umanità stessa.
Che parabola grottesca! E come se si potesse schiacciare un enorme tasto rosso ‘reset’ sarebbe bello poter ricominciare.
Dai raccoglitori e i cacciatori, per vedere se possa nascere qualcuno più ispirato verso criteri di uguaglianza e non di accaparramento, il che ci porterebbe a disquisire sulla natura del genere umano, già molti illustri filosofi ne han detto dall’homo homini lupus e prima ancora.
L’articolo 24 andrebbe applicato davvero, forse saremmo tutti più buoni. E però prima di questo diritto sacrosanto c’è quello cui si riferisce la parte finale. Le vacanze. Perché se stai vacando vuol dire che prima eri occupato in qualche cosa che secondo il sistema genera reddito. E torniamo daccapo, pensando a quante persone hanno vacanze lunghe un anno e più e sul pianeta quanto poco svago ci sia per le masse di sfruttati e diseredati; altro che vacanze.
Però. Lo svago è davvero un diritto, il distogliere l’attenzione, una pratica in controtendenza per la nostra adorazione al totem digitale. Svagarsi è sempre più difficile, eppure sarebbe un gesto da poco, un diritto non difficile da esercitare.
L’articolo 24 per me diventa così un legato, un messaggio da imprimere su milioni di t-shirt taglia small, al massimo medium. Un diritto che dovrebbe provocare gioia e non ritrosia con il pensiero alla produzione di lavoro come unico scopo della vita, fino a una pensione in cui sei troppo vecchio, ormai, per affrontare degnamente lo svago.
E distraetevi, per il vostro bene. E per quello dell’umanità!
Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
M. ha di nuovo la tosse. Ormai ci conosciamo da quasi cinque anni e so che ad ogni cambio di stagione a lui ritorna la tosse. A volte così forte che non riesce a parlare, deve interrompere a metà una frase, un discorso.
M. è arrivato dallo Sri-Lanka appena maggiorenne, ormai vent’anni fa, su una piccola barca che ha viaggiato per circa un mese nell’Oceano Indiano, attraverso il Canale di Suez e poi finalmente nel Mediterraneo. Da quando è sbarcato in Sicilia, ormai una vita fa, ne ha passate di ogni genere: ha vissuto in tante città, ha fatto ogni tipo di lavoro.
Poi finalmente, grazie al passaparola di alcuni amici italiani si è sistemato: è diventato custode, nelle case popolari. M. si ritiene fortunato perché insieme al lavoro ha avuto anche un appartamento: il piccolo bilocale al piano terra, casa e portineria. Certo, il suo non è un lavoro facile: tra le occupazioni, i conflitti, l’assenza delle istituzioni… M. però non si lamenta quasi mai.
Qualche anno fa è tornato al suo paese per sposarsi e poi ha portato qui sua moglie. Hanno avuto due bambini.
Nati con la tosse. Perché in quella casa al piano terra manca la luce, manca l’aria e c’è tanta umidità. La tosse M. se l’è guadagnata come operaio in una fabbrica di lavorazione dell’acciaio. E la coltiva vivendo da dieci anni in una casa dove il sole non entra mai.
M. non si lamenta quasi mai, ma è preoccupato per i suoi figli.
Oltre alla tosse, F., il suo bambino più grande che ormai ha quasi tre anni è molto nervoso ultimamente. F. passa tutto il giorno a casa con la mamma, la zia e il fratellino. Una piccola stanza per giocare. Poca luce, poco ricambio di aria.
Per fortuna nei prossimi mesi finalmente andrà alla scuola di infanzia. La notte dormono tutti e quattro insieme, nel lettone, perché altri spazi in casa non ce ne sono.
E. viene dall’Egitto. Suo marito è in Italia ormai da molti anni, lei è arrivata da circa sette o otto. Sta studiando l’italiano, è piuttosto brava e le volontarie che le insegnano spesso le chiedono di aiutarle con le iscrizioni delle nuove allieve. Ma E. avrebbe bisogno di un lavoro “vero”.
Suo marito era dipendente presso una ditta di pulizie, ma da quando c’è la crisi lavora solo a chiamata. Con tre figli piccoli però trovare un lavoro non è facile. Meno male che almeno tutti e tre sono “diventati italiani” perché il papà ha ottenuto la cittadinanza giusto qualche mese fa, dopo anni di attesa.
Quando ancora si lavorava bene il marito di E. ha acquistato la casa dove vivono, accendendo un mutuo quarantennale. La rata da pagare è di circa 400 euro al mese. Spesso E. e suo marito chiedono una proroga.
Un giorno E. mi ha invitato a prendere il caffè a casa sua. Nel salotto troneggiano le foto dei genitori e le immagini di alcuni santi perché E. e suo marito sono copti. E. mi ha fatto vedere la casa, pulita e messa in ordine per l’occasione: un piccolo cucinino, un balcone, il bagno e una stanza da letto. Una sola stanza dove ci sono tutti i letti: un matrimoniale per i genitori, un divano letto per i piccoli.
E. è preoccupata per quando i suoi figli cresceranno e perché neanche ora sa bene dove fargli fare i compiti, quando tornano da scuola.
A. mi ripete spesso che avrebbe fatto bene a laurearsi, quando era in Marocco. E invece gli studi non li ha mai finiti. Si è accontentata di essere assunta nello studio legale di suo marito e con la separazione ha perso anche il lavoro. A. vive in Italia da circa quindici anni. I primi anni in particolare non sono stati facili per niente. A. però non è una che si dà per vinta facilmente.
Nonostante i suoi studi e la sua esperienza lavorativa riguardassero tutt’altro, A. si è adattata a fare un corso per operatrice socio-sanitaria ed è stata assunta da una cooperativa. A. è molto precisa e paziente.
Quando è riuscita a farsi ospitare da un connazionale per una cifra accessibile, ha fatto arrivare qui in Italia anche sua figlia S.
A S. mancava solo un anno per finire le superiori, ma nessuna scuola le ha riconosciuto gli anni svolti, avrebbe dovuto ripetere almeno tre anni. Così A., con moltissimi sacrifici, le ha pagato un corso professionale che poi si è rivelato essere una truffa.
In pochi mesi è precipitato tutto: la cooperativa di A. ha perso l’appalto e ha licenziato i dipendenti. La casa dove A. alloggia è stata venduta all’asta: su di essa pendeva un fallimento. Entro la fine del mese A. e sua figlia dovranno trovare un’altra sistemazione.
Queste sono solo alcune delle storie che pulsano dentro un quartiere qualunque della città di Milano, dove vivo.
Non serve andare molto lontano per incontrare persone per le quali spesso perdere la casa – o non avere mai avuto accesso ad una casa degna, a una casa che ci si possa davvero permettere, a una casa salubre, a una casa che consenta tanto ai figli quanto ai genitori di avere uno spazio per sé – significa, presto o tardi, perdere molto di più.
L’articolo 25 recita così “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia”. E la casa (l’abitazione, come dice da articolo) è dal mio punto di vista, forse uno dei perni più rilevanti per la costruzione di questo benessere. Lo si capisce dal fatto che anche quando è inadeguata, insalubre, economicamente insostenibile, la casa rimane comunque un appiglio, a cui restare agganciati forte per non vedersi strappare anche tutto il resto.
Allora in questa continua sfida senza senso tra il minimo indispensabile per sopravvivere e ciò che ci è necessario per stare bene, io mi immagino di allargare un po’ lo sguardo “dalla casa alla città”. E mi immagino la città come un “dispositivo abilitante” che possa farci arrivare un po’ più vicino a tutti quei diritti a cui ciascuno di noi, in forma individuale, spesso non riesce ad accedere. Una città fatta di “spazi per”: spazi per giocare, spazi per studiare, spazi per la salute, spazi per stare insieme, spazi per stare bene.
Mi immagino una città in cui chi ci abita ci stia così bene da sentirsi legittimato a chiedere ciò di cui ha bisogno e non costretto a giocare continuamente a ribasso sui propri diritti. Una città in cui sia possibile capire un po’ meglio, anche solo immaginarlo meglio, il significato dell’articolo 25.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli
Ti ho visto leggere un libro
Tra le pagine ho visto un arcobaleno
Una colomba
Tra le pagine ho visto un coriandolo
Una montagna innevata
Ti ho visto leggere un libro
Tra le pagine ho visto una smorfia
Una lacrima
Un dolore
Ho visto un invito a lottare
C’erano un soldato semplice
E un generale
Un impiegato
E un manovale
Ti ho visto leggere un libro
Tra le pagine ho intravisto un attimo di tempo
L’infinito e il silenzio
Ho visto il passato del presente
E il presente del futuro
Ho visto la crepa che fa entrare la luce
La luce della lampadina nuova
Il sangue del corpo dimenticato
Ho visto il corpo dell’uomo abbandonato
E della donna ritrovata
Ti ho visto prendere un libro
Era chiuso il libro e poi sigillato
Vuoto e abbandonato
Non c’erano le parole nel libro
Ho visto un abisso
Il niente
Chè la gente aveva perso tutto
Chè la gente non sapeva niente
Chè io tremavo
E anche tu.
Non sarò mai abbastanza cinico
Da smettere di credere
Che il mondo possa essere
Migliore di com’è.
ARTICOLO 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Il “diritto alla cultura” enunciato dall’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si può intendere almeno in due modi.
Prima di tutto, si tratta di un diritto fondamentale di non esclusione: ciascuno ha diritto di partecipare, con la propria cultura d’origine, alla costruzione collettiva della società.
Qui il termine “cultura” è inteso in senso lato, che comprende scienza e arte al fine di garantire la tutela di ciascuna espressione culturale. Il fumetto si è più volte soffermato su questo aspetto, raccontando il tentativo – ricorrente nella storia – di cancellare culture considerate “inferiori” o “degenerate”.
Tra i numerosi esempi offerti dal ricco panorama di graphic novel pubblicati nel nostro Paese si possono citare i tanti fumetti dedicati alla Shoah, come Jan Karski di Rizzo e Bonaccorso (Rizzoli-Lizzard).
Particolarmente efficace in questo senso, anche perché dedicato alle vicende poco note del confine orientale italiano, è L’inverno d’Italia di Davide Toffolo, recentemente pubblicato in una nuova edizione da Coconino.
In questo emozionante graphic novel, Toffolo racconta – con due protagonisti bambini che ricordano i Peanuts di Charles M. Schulz – la pulizia etnica condotta dal regime fascista, che a partire dal 1941 deportò circa 100mila sloveni in campi di concentramento come quello di Gonars (Udine), dove morirono almeno 500 persone.
Un tentativo sistematico di cancellare una cultura diversa da quella dominante, oggi peraltro quasi del tutto dimenticato nel nostro Paese. Del resto memoria e cultura vivono un rapporto simbiotico, nessuna delle due può sopravvivere senza l’altra.
E se c’è qualcosa che la cultura può fare per salvare se stessa è diffondersi, anche attraverso il fumetto, per tornare a far crescere la consapevolezza individuale, la conoscenza reciproca, il dialogo tra le persone.
Questo impegno contraddistingue, tra le tante che si potrebbero citare, anche la nuova linea editoriale Feltrinelli Comics, lanciata appena un anno fa con titoli come Mujeres di Cacucci e Delli Veneri.
La centralità fin da subito accordata al tema diritti porterà la casa editrice a pubblicare almeno due titoli decisamente interessanti nel 2019, annunciati dal curatore della collana Tito Faraci all’ultimo Lucca Comics.
Si tratta di Lamiere. Storie da uno slum di Nairobi di Deninotti, Fontana e Ruvidotti – reportage realizzato in loco, come Zlatan di Paolo Castaldi – e di Post Pink. Antologia di fumetto femminista, a cura di Elisabetta Sedda con un ricchissimo elenco di autrici.
La combinazione tra cultura, diritti e fumetto richiama subito alla mente anche Becco Giallo, prima casa editrice italiana a puntare con decisione sul graphic journalism in tempi non sospetti.
Proprio l’editore padovano – e qui chiudiamo il cerchio sull’articolo 27, chiamando in causa il secondo comma – lancia una sfida non da poco al mondo del fumetto. I suoi graphic novel, infatti, sono pubblicati con licenza creative commons internazionale, accompagnati dal motto Condividiamo la conoscenza!
Perché se è vero che “Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”, è altrettanto evidente che se vogliamo garantire il diritto universale alla cultura non possiamo costringerla nelle strette maglie della proprietà intellettuale.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
A guardarsi intorno con le lenti del senso comune e del gusto condiviso non si trova nemmeno uno straccio di buona ragione per venire qui a Gulpio.
Non di certo per la chiesa, di un anonimo stile moderno; non per la scuola elementare, chiusa da almeno vent’anni; non per la piazza del paese, un breve triangolino d’asfalto che, sul bordo della strada, ospita due panchine, una fontana e un monumento a circa dieci caduti.
E neanche per quel pittoresco fervore che anima molti paesi italiani, ma non Gulpio, dove vivono circa trenta abitanti, quasi tutti anziani, sparsi fra questo mucchietto di case, alcune di pietra scura, molte abbandonate e cadenti, che spuntano come una piccola colonia di funghi nel verde delle campagne, fra le chiome di peri, fichi e noccioli, e si arrampicano mollemente per poche centinaia di metri lungo una curva in salita, dove non passa mai nessuno, se non piccoli gruppi di braccianti di ritorno dai campi su vecchi furgoni con gli ammortizzatori in affanno. Oppure qualche camminatore della domenica che tenta di occultare fra questi dolci rilievi le ignobili tracce di abuso di pizza fritta e babà con la panna.
A Gulpio non succede mai niente, a parte la festa del Santo Patrono e, a volte, insulsi fatti minori. Come la dipartita di un’anziana donna che lascia due figli disabili, dei quali ora chissà chi si occuperà; o il furto di attrezzi agricoli e di maiali a danno di una famiglia di contadini che per vivere dovrà ingegnarsi diversamente. Affari triviali e insignificanti, che neppure meritano l’attenzione degli altri, sicuramente turbati e distratti da drammi ben più seri, come le pene d’amore del tal ministro scaricato sul web dall’amata.
Decisamente no. A guardarsi intorno con le lenti del senso comune e del gusto condiviso non si trova nemmeno uno straccio di buona ragione per venire qui a Gulpio, in questo posto che si nasconde ostinato dal frastuono dei clamori del mondo.
Eppure, con fare sfrontato e beffardo, il mondo ha deciso di passare di qui avvicinandosi con un rumore sommesso, come quello dell’onda che si sparge sulla battigia. E poi si è ritirato in fretta, lasciando dietro di sé una piccola folla di naufraghi usciti a fatica dalle tempeste dei cosiddetti “tempi moderni”.
A Gulpio sono arrivati dieci africani. A guardare senza le lenti del senso comune, anche questo tutto sommato è un fatto triviale: poco lontano da qui, nelle campagne in pianura, gli africani sgobbano da almeno trent’anni. Ma adesso è tutto diverso: questi, infatti, non sono solo africani. Sono profughi. Invasori. E non vengono per lavorare, ma per stare negli alberghi di lusso per 35 euro al giorno.
Poco importa che a Gulpio non ci siano bar e negozi, figurarsi gli alberghi, la notizia ha diffuso comunque un certo scompiglio, come un pugno di becchime lanciato in un gallinaio: un po’ di schiamazzi, un turbinare di piume e un goffo slancio poco convinto verso quelle granaglie che, si sa, spettano prima agli italiani.
Poi in questo universo immobile è tornato il silenzio, sul quale però aleggia un legittimo dubbio: che cosa faranno dieci africani a Gulpio?
La risposta è semplice: niente. O quasi. Qualcuno è rapidamente saltato su uno di quei vecchi furgoni con gli ammortizzatori scarichi, condividendo con altri braccianti del posto non solo l’abitacolo, ma anche un comune destino di molta fatica, scarsi guadagni e nessuna garanzia in un settore che langue. Gli altri trascorrono le loro giornate fra le gite in cerca di sigarette al paese vicino, a due chilometri e mezzo di verdeggianti curve ondulate, e le interminabili ore trascorse sul muretto antistante la casa che è stata trasformata in centro d’accoglienza.
Chiacchierano fra di loro o, quando capita, con qualche camminatore della domenica.
Anna è uno di questi. A Gulpio viene saltuariamente, a smaltire gli eccessi della sua stessa cucina, ma più di trent’anni fa veniva qui tutti i giorni, a insegnare nella scuola elementare ormai chiusa. Vive insieme alla sua famiglia, la parte che non è emigrata, nel paese vicino, cinquecento abitanti, un bar e un minimarket con tabacchi, quello dove gli africani vanno a comprare le sigarette.
Anna è nata e cresciuta qui, da queste parti, e non si è mai spostata. Ha visto molto poco del mondo, che però è passato spesso da casa sua, lasciando tracce sparse un po’ ovunque: quel tavolino comprato a Damasco, una bottiglia di cognac armeno, bambole russe di varie misure, bracciali yemeniti e suppellettili varie portate da lontano, insieme ai racconti di terre mai viste, dai membri più vagabondi della famiglia. Forse è per questo motivo che questi stranieri, trascinati su queste colline dai tumulti del mondo, non le fanno tutta questa paura. Arrivano da lontano, ma le loro storie, a ben pensarci, non suonano poi così oscure o distanti. Parlano di disoccupazione, povertà, corruzione, difficoltà di avere una vita normale in una terra ricca di risorse e per questo depredata dagli stessi che, dal lato fortunato del mare, ora rimangono a guardare.
Il loro vocabolario è scarno, l’italiano barcollante, ma gli africani di Gulpio hanno urgenza di comunicare, non solo per il desiderio di raccontare quel passato che li ha spinti ad attraversare il Mediterraneo, ma anche perché quegli improbabili e grotteschi conciliaboli anglo-franco-italo-dialettali sono fra le poche occasioni che hanno a disposizione per imparare l’italiano in un luogo dove non ci sono bar, né scuole, né negozi e, a dire il vero, nessuna forma di vita sociale.
Eppure la lingua è la base per iniziare, in questa terra straniera, a immaginare e scrivere un futuro voluto e cercato anche a rischio della propria vita. Chi migra lo sa bene, spesso meglio di quelli che si occupano di assegnargli un destino a tavolino. Forse per questo chi migra si muove più rapidamente della burocrazia per trovare soluzioni.
Jonathan, ventenne arrivato dal Ghana, ha saputo chissà come che Anna fa l’insegnante. Qualcuno deve avergli detto anche che Anna non sa dire di no, quindi si è fatto avanti, sicuro: “Vuoi essere la nostra insegnante di italiano?”. La risposta, come era prevedibile, è stata sì.
Ma a questo punto la burocrazia, superata in volata dall’intraprendenza di Jonathan, ha ripreso le forze e cominciato a mostrare ai nuovi venuti chi è che comanda.
Anna ha sempre insegnato ai bambini e non ha esperienza di settori che non siano la scuola. Non è un operatore sociale, né un’attivista. Sa solo che è importante, oltre che giusto, dare ai nuovi arrivati l’opportunità di imparare l’italiano. Ma questi non sono minori seduti al banco di una scuola pubblica nei loro lindi grembiulini, stirati con cura da vigili mamme. Con questi studenti è tutto diverso. Da dove si potrà mai partire per organizzare i corsi? A chi chiedere aiuto?
Facile. Alla personalità più in vista di una piccola frazione di campagna: il prete. Don Riccardo, che in realtà si chiama Richard e arriva anche lui da lontano, là per là si è mostrato entusiasta alla proposta di Anna. Ma poi l’entusiasmo si è disperso nella sua frenetica routine di parroco itinerante, che vaga di parrocchia in parrocchia per raggiungere i fedeli sparsi su un territorio vasto, ma sempre più spopolato.
Poco male, forse si può fare un tentativo con il Comune, dove un funzionario, un po’ meno entusiasta, si è offerto di dare una mano. Salvo poi dimenticarsene, trascinato anche lui dalla vorticosa routine dei giorni in un sonnolento comune sospeso fra mare e collina.
Allora Anna si ricorda di Armando, quel conoscente che lavora in polizia e che forse può avere gli agganci giusti. L’intuizione non era sbagliata: Armando riferisce puntuale che l’ente di competenza in questi casi è la Prefettura e promette di informarsi personalmente.
E a differenza degli altri, non se ne dimentica. Torna da Anna, ma con cattive notizie. Per entrare nel centro è necessaria un’autorizzazione della Prefettura, che però la rilascerà difficilmente a un esterno per un’attività del genere. I corsi di italiano, spiega Armando, sono già parte delle iniziative previste e finanziate all’interno di un centro di accoglienza. Anzi, dovrebbero essere già attivi. In altre parole, riassume Armando, la Prefettura non può autorizzare l’ingresso di un insegnante nel centro perché già ne paga uno. Del legittimo titolare del corso, però, a Gulpio non c’è traccia.
Anna non è ancora stanca. Prova a pensare a un’alternativa: se il centro è inaccessibile, si può forse utilizzare un altro locale. Ma quale? In parrocchia non è fattibile, Don Riccardo è troppo impegnato.
Basterebbe un circolino, una sede proloco, il retrobottega di un negozio, ma a Gulpio, purtroppo, non c’è nemmeno un bar.
A quanto pare non rimane che la resa. Anna, però indispettita, continua a informarsi, nell’attesa che l’insegnante di italiano prima o poi faccia la sua comparsa. Ma attende invano. E con lei Jonathan e i suoi nove compagni africani di Gulpio.
Di recente una delle vagabonde della famiglia, in fugace transito nella casa paterna, le ha chiesto: “Come è andata a finire con i corsi d’italiano?”. “E’ andata a finire che deve pensarci il centro dove stanno”. “Sì, lo so, questo me l’hai già detto tre volte, ma qualcuno nel centro si è attivato?”. “No, niente. Ma adesso sento di nuovo Armando. Senza fare troppo “casino”, però, ché non vorrei passare un guaio”.
Intanto, il nocciolo ha perso le foglie e le piogge hanno iniziato a bagnare le curve che portano a Gulpio. Le giornate sono sempre più corte e i camminatori della domenica sono sempre più rari.
Mai come in questa stagione dell’anno, a guardare con le lenti del senso comune non si trova neanche uno straccio di ragione per venire a Gulpio.
Eppure tutti, tolte le lenti, dovrebbero andarci per vedere con i propri occhi cosa resta di un essere umano quando della sua libertà non rimane altro che un ricamo di belle parole scritte su carta in una lingua che non potrà leggere.
Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
“Lei è all’orizzonte. […] Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a questo: a camminare.”
Eduardo Galeano
Quando un viandante, un giorno in cui nessuno l’aveva incontrato, si incamminò nella poesia di Machado, si stupì di trovarsi senza sentieri e senza mete. «Camminando si fa il cammino» scriveva il poeta sivigliano.
E d’altro canto, ogni meta ha il passo di chi la cerca. E il sentiero esiste solo alle spalle del suo errante.
Quello che il viandante si mise nella saccoccia, alla vigilia della partenza, non ci è dato saperlo. Ma nessuna percorrenza può esistere senza il suo viatico, l’irrinunciabile, la condizione necessaria e sufficiente per.
Per questo, quando messi al mondo abbiamo compiuto la prima delle nostre migrazioni, per il solo fatto di esserci incamminati, un viatico comune ed equamente spartito ci è stato dato come corredo.
Era presente e predetto nello srotolarsi delle spine dorsali, nelle prime tribù di stelle a cui dettero un nome e una corte sulla pelle del cielo, nelle prime cacce, nelle prime guerre e nelle prime tregue. E in tutto ciò che seguì.
Che sia dovuto al discendere dagli stessi lombi d’argilla o ai millenni passati su un progenitore preistorico, poco importa.
Per il solo fatto di essere uomini in un paesaggio di uomini, il diritto d’essere vivi e di restarlo fino a scadenze naturali, il diritto di andarsene o restare secondo la marcia della propria meta, il diritto di essere uguali e liberi e felici e riconosciuti, ci sono stati dati.
Dal latino dirigere, cioè, porre in linea retta e, più ancora, dare una direzione, guidare, i diritti sono la verticale inossidabile. Ciò che non può essere flesso, né reclinato.
Il paesaggio che abitiamo, però, ogni istante cambia il suo profilo. Starci richiede inesausta gentilezza. Esercizio costante di essere, esattamente, consapevoli del peso di un atto, sulla vita degli altri.
Nella geometria della convivenza, la perturbazione in uno snodo, produce effetti su ognuna delle altre confluenze. Tutti siamo a un crocevia, tutti l’altro di qualcuno.
Nella fisica della coesistenza i diritti sono un liquido: volume incomprimibile, forma adattabile.
Lo spazio tridimensionale che occupano è il luogo dell’individuo, inespugnabile. La forma invece si plasma per interazione, non può espandersi laddove l’espansione causa retrazione dell’altro.
Una forma di principio d’equilibrio, dove il dato viene ricevuto. Il principio più antico del mondo.
Perché il flusso delle cose è reciproco e quanto offerto in dote deve essere restituito. E mentre con il viatico si viene al mondo, la restituzione è un processo che si apprende. Diritti e doveri in funzione di una felicità comune.
Sappiamo che le parole hanno il loro incantamento. Da tempo immemore dare nome alle cose dà una forma al mondo: a seconda degli accenti e delle sillabe, si forma una quinta dimensione, la dimensione della narrazione. Parole magia, parole creature.
Ecco che quindi chiamare giustizia fucina un mondo giusto, libertà un mondo libero.
E questo perché l’adempimento di un desiderio sta nelle parole scelte per esprimerlo.
E poi, negli atti.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
L’articolo 30 è come un messaggio nella bottiglia, lanciato tra le onde, verso un altrove nello spazio e nel tempo. Come un messaggio registrato e spedito nello spazio, per comunicare a qualcuno o qualcosa, in un altro quando e in altro dove, di tenere gli occhi aperti.
Perché non esistono poteri buoni. Questo è il senso, come di brivido, che provavano ancora sulla loro pelle i giuristi che han dato vita a questo straordinario documento che vi abbiamo raccontato in questo mese. Una narrazione collettiva come collettivo è il destino di questa Terra, collettiva come la vocazione di questo documento. Che muore, ammalandosi di retorica, se non capiamo che i destinatari di quel messaggio nella bottiglia siamo noi. Che dobbiamo vigilare sul potere, in quanto giornalisti, cittadini o qualsiasi ruolo abbiamo nella vita pubblica, perché non ci venga sottratto neanche uno di questi diritti, a noi e a tutti.
I giuristi, in forma elegante, sembrano dire: noi siamo arrivati fin qui: tocca a voi difenderla praticarla, a cominciare dalle vostre vite private, passando per i condomini e arrivando al mondo intero. Sentendo il dolore degli altri come vostro, perché nessuno è al sicuro se si tratta sui diritti.
Ecco che per me, l’articolo 30 è una canzone: Kanyon Drine, degli Zabranjeno Pušenje.
Zabranjeno Pušenje (Vietato fumare, in serbo-croato) è una versione di successo del grande classico della band degli amici del liceo. Sarajevo, anni ’80, liceo Sarajevska Druga Gimnaizija. Un gruppo di ragazzi con la passione della musica rock, che vivevano nella stessa via Fuada Midžića, nel quartiere di Koševo, dell’attuale capitale della Bosnia – Erzegovina. Ma all’epoca era Jugoslavia.
Solo che il ‘grande padre Tito’ era morto e i nazionalismi, sotto la spinta del cambiamento internazionale che lentamente portò in un decennio alla caduta del muro di Berlino, digrignavano i denti in attesa del sangue. E di spartirsi il boccone.
Questo gruppo di ragazzi che, in un decennio, tra dischi e spettacoli tv nella trasmissione Top Lista Nadrealista, con l’arma dell’ironia amara, raccontarono in anticipo quel che accadeva. Quel che stava per accadere, anzi. E questa canzone, del 1989, è un inno alla ragionevolezza che cede il passo alla barbarie.
Tre amici, di notte, su una strade tra le montagne che circondano il fiume Drina (simbolo del libro di Ivo Andric) chiedono un passaggio a un vecchio camionista. Son le tre anime del paese di fronte ai vecchi partigiani che avevano creato la Jugoslavia, contro i nazionalismi? Cercate voi il senso dei brividi che sentivano, vedete voi l’allarme che ciascuno deve sentire quando gli imprenditori della paura si fanno potere. Perché questa Dichiarazione siamo noi e vale tanto quanto la collettiva capacità di difenderla.
Kanion Drine
saliamo sopra Mufa, Kik e io
la neve si scioglie, la strada è vuota,
si è fermato davanti a noi un vecchio camionista.Le montagne nude e impervie ci spezzavano la strada,
il padrone guidava visibilmente di cattivo umore,
anzi, più triste che arrabbiato.
Diminuisce la velocità, si accende una sigaretta
nel buio gli brillano gli occhi.
Il padrone, con voce calma, dice:
Ragazzi, non andrà a finire bene.
Perché ora tutto va all’indietro,
viviamo in tribù come degli Apache,
Ma ovunque andiamo, ragazzi, voi ed io,
il cuore ci batte per tutti loro.
Svegliami, questo è un brutto sonno,
ragazzo, meno sai e meno sei infelice.
Le montagne nude e impervie ci spezzavano la strada,
il padrone guidava visibilmente di cattivo umore,
anzi, più triste che arrabbiato.
I musulmani [*1] si sono divisi i distretti,
evacuano i ragazzi con gli aeroplani
e io mi sento fuori posto
come una zebra a Brioni. [*2]
Ma per voi, ragazzi, sarà meglio,
siete abituati a andar presto a letto,
fra poco, a tutti noi ci faranno
uscire soltanto fino alle nove. [*3]
Svegliami, questo è un brutto sonno,
ragazzo, meno sai e meno sei infelice.
Le Gole della Drina sono dietro di noi,
davanti a noi la piatta Romanija.
La neve si scioglie,
niente fermerà l’arrivo della nuova primavera.


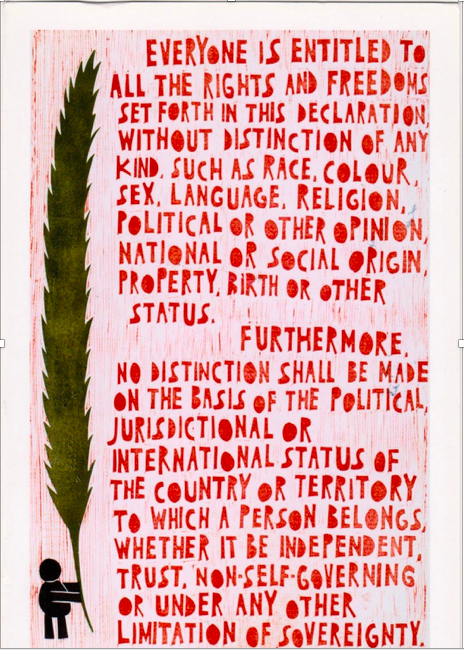







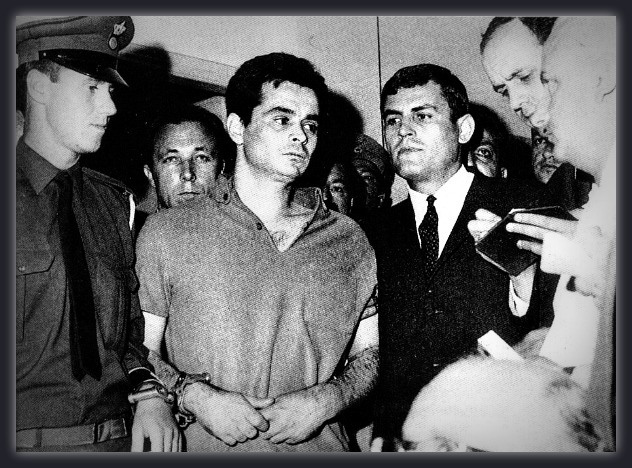

















NOTE
[*1] Il termine utilizzato, derivato dal turco, indica alla lettera il pellegrino musulmano che ha effettuato il pellegrinaggio alla Mecca.
[*2] Sull’isola dalmata di Brioni il maresciallo Tito aveva la sua esclusiva residenza privata, dove invitava gli ospiti di riguardo. Sull’isola era presente un giardino zoologico, con la relativa zebra.
[*3] L’allusione è ovviamente al coprifuoco notturno.